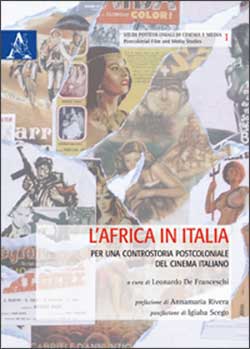“C’è un’intera generazione che rischia di rimanere tagliata fuori”. Fuori dalla vita pubblica del paese, ma anche fuori da luoghi solo apparentemente più inclusivi e senza barriere come possono essere quelli legati a contesti artistici, il mondo del cinema o della televisione per esempio. L’affermazione iniziale è di Leonardo De Franceschi, docente di Teorie e pratiche postcoloniali del cinema e dei media presso l’Università di Roma3, ideatore e curatore della collana di studi post coloniali su cinema e media appena inaugurata e che ha dato alle stampe un primo volume dal titolo: “ L’Africa in Italia”. Un lungo e ricco excursus su quelli che sono stati e continuano ad essere i contributi che cineasti (attori, registi, tecnici, organizzatori di festival ) africani o afrodiscendenti hanno apportato al cinema nostrano senza che questo sia stato pienamente riconosciuto, cinquant’anni fa come ancora oggi dove al fenomeno coloniale subentra una nuova necessaria riflessione che investe il fenomeno migratorio nella sua complessità.
I diversi saggi raccolti nel testo, le testimonianze, i personaggi che lo popolano in una sorta di galleria virtuale e che al tempo stesso vanno ad arricchire il panorama del piccolo e del grande schermo confermano ancora una volta l’urgenza di uno sguardo altro su quelli che sono “gli altri” accanto a noi ( sebbene questa definizione di altri venga ampiamente criticata e sezionata da buona parte degli autori del volume). Siano essi migranti dell’ultima ora o persone nate in questo paese ma trattate ancora come straniere in patria.
Uno sguardo verso l’altro che trova però “resistenze molto forti” per usare le parole di De Franceschi, resistenze che si annidano non solo tra il pubblico quanto piuttosto tra chi il cinema lo fa.
Il volume dedica un ampio spazio di riflessione ai film che tentano di raccontare l’immigrazione…
Su questo c’è da dire che sono ancora pochi i registi in grado di affrontare la questione in maniera adeguata. I migranti rappresentati sono quasi disumanizzati, figure astratte come quelle appena sbarcate a Lampedusa per cui, difficilmente la scelta per ruoli del genere ricade su attori professionisti, preferendo invece il non professionista, “l’uomo preso dalla strada”… Il punto di vista scelto sembra essere quello sociologico svuotato di umanità.
E questo a cos’è imputabile?
Manca una memoria storica rispetto alla narrazione cinematografica del fenomeno, dai primi film della fine degli anni ’80 ad oggi sembra sia rimasto tutto fermo, ma manca soprattutto una conoscenza approfondita, dall’interno. Il regista medio italiano che decide di raccontare l’immigrazione non ha quasi mai contatti diretti con i migranti, non prende gli stessi mezzi pubblici per esempio, non li frequenta; continua a sussistere una certa distanza che poi viene traslata nel film, prova ne è l’inserimento della figura di un “mediatore”, mentre l’immigrato appare nel migliore dei casi come vittima e in quanto tale non consente margine alcuno ad una possibile identificazione con lo spettatore.
Forse l’Italia non ha fatto sufficientemente i conti con il suo passato coloniale?
In realtà di studi sull’argomento ve ne sono tanti, basta solo andarseli a cercare, è piuttosto un problema di senso comune e quindi di un immaginario collettivo che non riesce ad andare oltre lo stereotipo. Pochi sono i registi o gli esperimenti che sono riusciti a spingersi più in là, per esempio Segre è uno di questi, ma anche film come Là-bas o Take five, o l’interessante esperimento di Italian movies ( nonostante le difficoltà nella distribuzione) dimostrano tuttavia come sia possibile rompere certi schemi e certi clichès, finanche a giocare con la commedia e l’ironia e arrivare direttamente al pubblico, perchè alla fine è il pubblico che decide.
Cosa si può fare allora per invertire la tendenza?
Il testo fa emergere potenzialità molto forti che però per affermarsi molte volte devono andare all’estero: basterebbe investire su certi profili per invertire il circolo e farsi seguire dal pubblico. Dall’altra parte è necessaria una forte presa di posizione da parte degli attori, africani o afrodiscendenti nello specifico, che dovrebbero fare fronte comune, un po’ come successo in America anni addietro. Fu grazie alle mobilitazioni degli attori che alla fine si arrivò ad imporre il cosiddetto “blind casting”.
Affinchè si arrivi a un’assunzione generalizzata di consapevolezza e alla rinuncia al tono pietistico che permea tante pellicole, la “cosiddetta” seconda generazione può giocare un ruolo fondamentale…
Infine potrebbe essere utile creare dei canali di azione affermativa, investire su formazione e alta formazione per attori e attrici non italiani/e, magari immaginare dei progetti collettivi…
Per quanto ci riguarda, oltre allo studio già pubblicato, stiamo lavorando a un blog che dovrebbe rappresentare una gigantesca banca dati per i cineasti africani e afro-discendenti operanti in Italia.