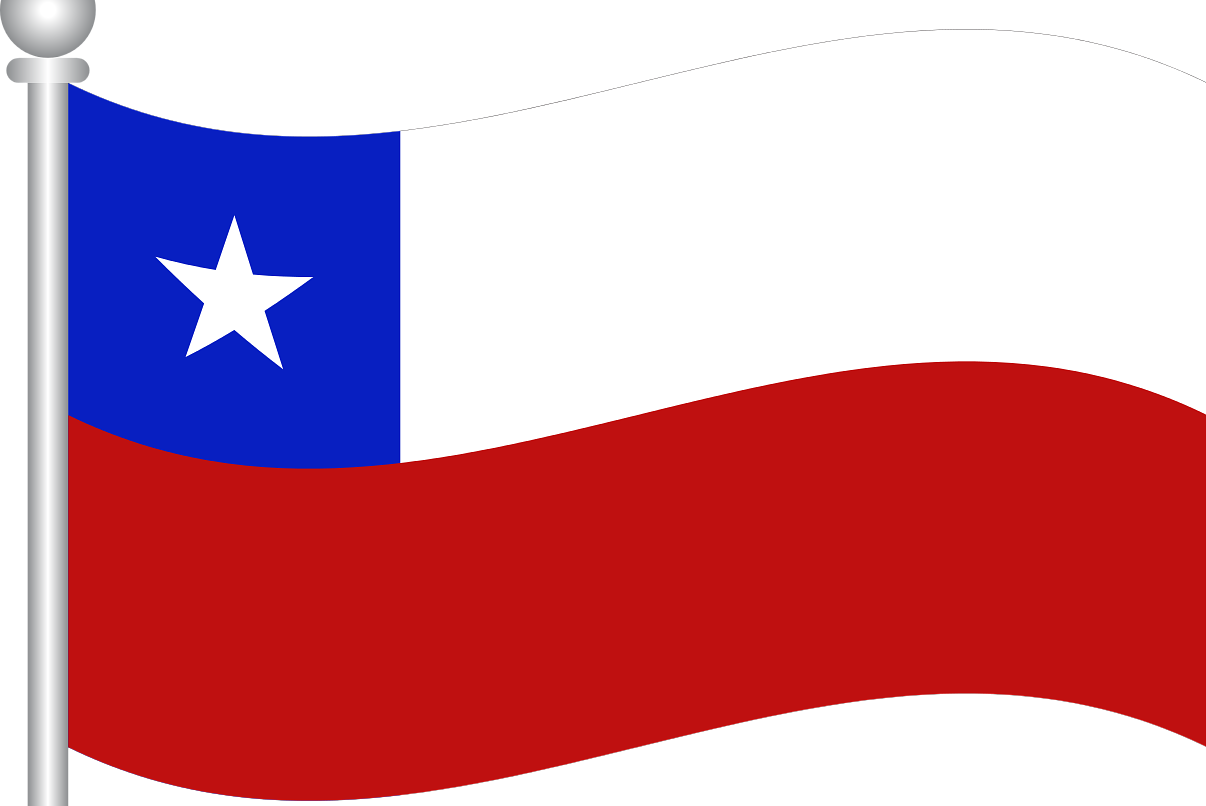Il Cile e le sue istituzioni sono ancorati oggi fermamente al quadro democratico. A mezzo secolo dal tragico 11 settembre 1973, ci sono però ancora piaghe aperte che tormentano la coscienza del paese e dividono la sinistra sulle compatibilità del socialismo con i limiti fluttuanti della democrazia capitalista. Una parallela e opposta inadempienza politica spinge la destra verso nuovi estremismi. I diritti umani, dei quali al momento del golpe l’Ambasciata d’Italia a Santiago fu un rifugio, potrebbero diventare un terreno di confronto. Una riflessione con l’ex ambasciatore Roberto Toscano.
Le radici del golpe
Nel 1970, quando Salvador Allende venne eletto, la maggioranza dei militari non era golpista. Non tutti i golpisti erano però militari, né necessariamente cileni. Quest’ultimo è un fattore rilevante. Le intromissioni internazionali furono varie. Palesi e di sostegno quelle cubana e russa. Decisive l’ostilità dichiarata e soprattutto quella occulta degli Stati Uniti di Richard Nixon. Era apparsa evidente fin dalla vicenda cilena, la spregiudicatezza etica e politica dell’allora capo dello stato più potente del mondo, che lo costrinse infine alle dimissioni per evitare l’impeachment. Così che nessuno poteva essere certo, nel Cile di quel tempo, di equilibri di potere in continua variazione. All’interno (e anche oltre frontiera), la propaganda più esacerbata mescolava la suggestione verbale alla realtà oggettiva. Spesso destinata a coprire carenze d’una parte o dell’altra, talvolta finiva per alimentare illusioni e perfino generare autoinganni.
Di qui – in un apparente paradosso -, il margine di diffusa incertezza che fin dall’inizio ha accompagnato l’arduo cammino di Unidad Popular lungo la via chilena al socialismo, nella doppia sfida del primo governo al mondo dichiaratamente marxista e pacifista. Una condizione che ne ha ulteriormente accentuato la vulnerabilità nella società e nelle istituzioni (aveva ottenuto solo la maggioranza relativa dei voti: 36,4 per cento, su circa 3 milioni di votanti); ma al tempo stesso anche per questo rendendolo possibile. Se più forte, con maggiore autonomia al Congresso e più ampia presenza nel paese, avrebbe con ogni probabilità fin da subito incontrato apprensioni e intransigenze impossibili da scavalcare: forse non gli avrebbero neppure permesso di nascere.
Il paese veniva da 6 anni di governo del cattolico Eduardo Frei, al quale la legge impediva di ripresentarsi. Sostenuto attivamente dall’Internazionale democristiana e ben accetto a Washington, il suo coerente riformismo aveva in qualche misura allentato le tensioni sociali accumulate dai precedenti governi conservatori. Lasciando però insoddisfatte molte, diffuse e più profonde aspirazioni. Nella comune arretratezza, i contrasti tra città e campagna erano allora epocali. Davvero da “fine del mondo”. Non casualmente il programma elettorale del candidato indicato dalla democrazia cristiana a succedergli, l’esponente dell’ala sinistra Rodomiro Tomic, sebbene più gradualista aveva molti punti in comune con quello di Allende.
Trame e documenti
Vennero imbastiti intrighi politici, marchingegni giuridico-procedurali e attentati mortali pur di riuscire a portare alla presidenza lo sconfitto candidato della destra, Jorge Alessandri (35,2 per cento). Ma infine – espressamente richiesto dalla Costituzione -, il voto del Congresso seguì l’indicazione delle urne popolari, consacrando il candidato socialista (153 voti contro 35). La democrazia cristiana, ottenuto un impegno ufficiale all’assoluto rispetto delle regole parlamentari, lo aveva preferito ad Alessandri. Consorti di ufficiali superiori delle Forze Armate liberarono dozzine di galline davanti alle caserme di Santiago, per stigmatizzare la presunta viltà di quanti dall’interno assistevano passivi agli eventi. Per dire l’umore dei quartieri alti.
Il golpe militar restava dunque un esito possibile pur se latente nella testa di quanti lo auspicavano così come in quella di chi lo temeva. In ottobre, divenne palese che c’era chi era disposto a tutto. L’assassinio del comandante in capo dell’Esercito, generale Renè Schneider, leale alla Costituzione, fece la prima, sanguinosa vittima di questa strategia del terrore. Compiuto da sicari della destra estrema con dirette complicità interne e internazionali, fallì l’obiettivo dichiarato d’impedire l’insediamento del presidente Allende. Perché tra i militari prevalse in quel momento un imprevisto atteggiamento d’indignata ripulsa del crimine. Nondimeno più avanti favorì i contrasti interni alle diverse componenti di Unidad Popular.
Le migliaia e migliaia di documenti segreti resi pubblici nei decenni trascorsi dalle stesse massime autorità degli Stati Uniti, ancora altri in queste ultime settimane su richiesta formale dell’attuale governo di Santiago, provano inconfutabilmente le continue ingerenze compiute in Cile e nell’America Latina dai governi dell’epoca a Washington. Leggerne alcune suscita tuttavia un sentimento d’immediatezza che assottiglia lo spessore del tempo trascorso. Le parole indagano oltre le episodiche verità dei fatti, scoprendo tratti del carattere personale, dello stato d’animo di chi le ha scritte e loro tramite logiche di pensiero d’un sistema di potere. E’ il caso di queste in appendice -testuali, autorevolissime-, tratte dalle “Memorie” personali di Henry Kissinger (1), segretario di Stato del presidente Nixon.
Unidad Popular al governo
Sull’avvio funestato da minacce e morte, spontaneamente proruppe a un tratto l’euforia. Strade gonfie di folle e bandiere. Nel momento dell’ingresso al palazzo de la Moneda, il volto sorridente di Allende a inspirare fiducia in un socialismo di empanadas e vino tinto, il volontarismo ebbe la meglio sul pessimismo della ragione e della situazione. Senza nessun avventurismo, tuttavia. Venne completata la nazionalizzazione delle miniere e ampliata la riforma agraria, acquisite alcune banche allo stato. Con qualche contraddizione, seguì la riorganizzazione dei contratti nazionali dei lavoratori industriali. Nel primo anno la produzione e tutta l’economia segnarono un vigoroso balzo in avanti. Contemporaneamente, però, cominciarono a ballare gli equilibri finanziari. L’incremento della spesa pubblica accese l’inflazione.
Sebbene insufficiente, il potere conquistato con il governo aveva intanto innescato nella sinistra un antagonismo non del tutto inedito. Già sperimentato nella Spagna del 1936. “Massimalismo” (Avanzar sin transar) contro “gradualismo” (Avanzar consolidando). Ciascuna delle due tendenze aveva i propri argomenti: la prima per sostenere l’irriducibilità dell’avversario di classe e quindi del conflitto senza quartiere; l’altra in favore del disegno di costringere l’opposizione a un continuo negoziato attraverso la costruzione di sempre più avanzati rapporti di forza. Tanto all’interno quanto a livello internazionale. Dialettiche entrambe insidiate dalla veloce radicalizzazione del contesto, provocata dal moltiplicarsi quotidiano delle difficoltà economiche e del conseguente inasprirsi delle tensioni sociali. La democrazia cristiana andava prendendone progressiva distanza.
Ne ho ricordi diretti, personali. In quei mesi ed anni facevo il corrispondente dal Sudamerica per il giornale La Stampa di Torino. Gli scioperi dei camionisti impedivano il rinnovo delle scorte nei negozi, nelle case mancavano alimenti. Gli ospedali scarseggiavano di farmaci e materiali sanitari. Gli stessi minatori, nazionalizzati, protestavano perché ricevevano salari nominalmente maggiori, di fatto corrosi dall’inflazione. Nelle trattorie il cibo era sempre meno variato e i proprietari sempre più nemici inveleniti del governo. Aumentava anche la frequenza con cui i taxi che mi trasportavano per Santiago si rompevano cammin facendo, abbandonandomi appiedato al mio destino. I pezzi di ricambio erano introvabili. Un po’ per le difficoltà dell’import, un po’ l’inevitabile mercato nero. Il rischio del golpe era sulla bocca di tutti e nella reale coscienza di pochissimi.
Le giornate trascorrevano veloci in un’emergenza continua. Unica regola, la provvisorietà. Lo stesso governo non poteva sfuggirne. Nell’ultimo anno, i ministri lavoravano assediati da problemi e postulanti. Un pomeriggio andai puntuale a un’intervista con il responsabile dell’Economia, Jose’ Luis Cademartori, uno scrupoloso accademico comunista. Il ministro era impegnato. Arrivò la sera, poi la notte ed ero sempre lì che aspettavo, sopravanzato da gruppi, talvolta colonne di operai e dirigenti sindacali che venivano a sollecitare la nazionalizzazione dell’azienda in cui lavoravano, spesso imprese di poche decine di dipendenti. Non per sottrarre un ormai inesistente plus-valore al proprietario, bensì per la necessità di assicurarsi un salario. “Un’assurdità!”, convenne Cademartori, che per spiegarmene le dimensioni abnormi fu costretto a portarmi a casa sua e – visto che ormai albeggiava – offrirmi una frugalissima prima colazione. Il ministero era rimasto deserto.
Uno dei pochi luoghi che conservava una sua solennità e in cui l’ansia generale sembrava quanto meno ben dissimulata, era -sorprendentemente-, la Casa di Governo, la Moneda, nel pieno centro storico di Santiago. Le conferenze-stampa del presidente, che con l’intensificarsi della crisi diventavano sempre più frequenti e inquietanti, avevano dei momenti surrealisti. Poiché Salvador Allende vi si presentava puntuale, con un aspetto ineccepibile, un padrone di casa gentile fino alla premura. Ci informava con disinvoltura di situazioni politiche a cui non negava affatto drammaticità. Ma illustrando sempre il modo in cui se ne sarebbe usciti. Che negli ultimi mesi, in effetti, era un nuovo generale in sostituzione di quello dimissionario.
Conosceva i giornalisti più assidui, ad essere accreditati eravamo un paio di dozzine, arrivati da mezzo mondo. Talvolta, sul fatto del giorno, chiedeva l’opinione di qualcuno di noi. Ovvio che avesse la sua. Era un idealista abile anche a rimestare nel fondo torbido della politica. Come il suo compagno e amico Pablo Neruda, avrebbe potuto dire: “Confieso que he vivido”. Ma non gli dispiaceva ascoltare. La presenza femminile lo rendeva poi visibilmente felice. Se arrivava una nuova collega, appena possibile s’interrompeva per andarle a stringere la mano. Nel rispetto pieno dei ruoli e delle prerogative di ciascuno. Tra noi ricordo qualche sorriso, mai uno sguardo malizioso. A Frida Modak, la sua fedele addetta all’Informazione, ho sentito dire una volta sottovoce: “Non crediate che si conceda frivolezze, semplicemente lui è incapace di allontanarsi dalla vita…”.
Ferite da rimarginare
Qualche tempo prima del’11 settembre 1983, il responsabile dei Servizi Speciali della RAI-TG1, Alberto La Volpe, e l’inviato-principe in America Latina, Franco Catucci, mi invitarono a realizzare con loro un programma sul decennale del golpe. Un impegno informativo di rievocazione e analisi non comune: quasi 4 ore di trasmissione in diretta con molti dei maggiori protagonisti della tragedia cilena. Dalla vedova del presidente Allende, la signora Hortensia Bussi, 69, al segretario del Partido Socialista de Chile e leader dell’ala intransigente, Carlos Altamirano, 61, al capo del maggior sindacato dei camionisti, Leon Villarin, 68, affiliato al gruppo terrorista d’estrema destra Patria y Libertad, a numerosi altri esponenti politici e della cultura cileni delle diverse parti politiche.
Un’esperienza interessante anche e innanzitutto dal punto di vista umano, le cui difficoltà di ospitarla superarono però le previsioni. Certificando le ferite profonde e ancora sanguinanti che l’esperienza di Unidad Popular aveva procurato al proprio interno, forse non meno che nel confronto con le parti dichiaratamente avverse. La sera precedente alla messa in onda, a cena, nel primo momento di relativa calma, dopo l’affanno di mettere insieme tante persone e situazioni diverse, la Signora Allende, non appena seduta, ci disse accigliata: “Voglio credere che il signor Altamirano non sarà presente in studio quando ci sarò anch’io; poiché in tal caso sarò costretta ad andarmene”. Con La Volpe e Catucci ci guardammo come se ci avesse rovesciato di colpo la tavola.
Altamirano, di fatto e simbolicamente, rappresentava (non solo agli occhi della vedova di Salvador Allende) l’estremismo che aveva offerto pretesti al golpe, indirettamente corresponsabile quindi di tante morti, atrocità e sofferenze. Tencha, come veniva familiarmente chiamata Ortensia Bussi, memore della fraternità di partito tra i due (Allende ne era stato prima di Altamirano il massimo esponente), e per la loro assiduità personale, lo considerava praticamente un traditore. Non fu semplice indurla a considerare che aveva il diritto pieno di non rivolgerli la parola, se così riteneva di dover fare. Ma che la sua stessa immagine non avrebbe guadagnato nulla nel caso in cui avesse rifiutato di essere presente. Prima, durante e dopo la trasmissione, Altamirano evitò a sua volta ogni possibile spunto di polemica personale.
Ferite sempre vive
La virulenza dei dissensi che dividono oggi il governo dall’opposizione, così come le rispettive coalizioni al loro interno, è imparagonabile con quella degli anni Settanta. Detto ciò e senza mai dimenticarlo, la partita rimane doppia: tra avversari, ma anche tra gli stessi alleati. E le distanze non si riducono, né perdono significato. Nel recente scambio di visite tra parlamentari di sinistra cileni e degli Stati Uniti, ne hanno parlato a Santiago anche la democratico-socialista Alexandria Ocasio-Cortez e la portavoce del governo Boric, l’ex parlamentare comunista Camila Vallejo, attualmente portavoce del governo. Della quale il presidente, che con lei e altri ha guidato la storica protesta studentesca di dieci anni fa, per indicare lo stato dei loro attuali rapporti politici ama dire: “No vamos en el mismo auto; pero si, por el mismo camino”.
Viaggiando su auto diverse lungo la medesima strada può accadere che più o meno involontariamente una tocchi l’altra e tutt’e due subiscano una sbandata. L’ultima è che lo scrittore Patricio Fernandez, socialista e membro della Costituente, consigliere personale del Presidente per le manifestazioni del Cinquantenario, ha dovuto dimettersi alla vigilia della storica ricorrenza per aver convenuto in un’intervista che nel golpe ci furono – ancorchè evidentemente minori -, responsabilità di Unidad Popular. Trasparente e non inedita, l’allusione era diretta ai massimalisti di allora per colpire quelli di oggi, che però non sono gli stessi. Anzi, non pochi di quelli si sono ravveduti da tempo; e affiancano quanti dal centro-sinistra spingono per un’intesa con la destra moderata al fine di uscire dalla crisi in atto. Le associazioni di difesa dei diritti umani, i comunisti e personalità diverse del centro-sinistra sono però insorti.
Già vent’anni addietro, il prestigioso sociologo Hugo Villela, espressione riconosciuta della ricerca accademica indipendente, perseguitato negli anni bui del pinochetismo, aveva lanciato l’avvertimento: “Il dubbio dell’anniversario è sempre che con la necessità politica si finisca per patteggiare i diritti di tutti con i delitti della dittatura”. Ora c’è un pragmatismo che da sinistra ragiona a partire dai diritti del libero mercato, per arrivare ad ammonire sui pericoli di lasciare spazio di manovra a un’estrema destra ormai determinante nella Convenzione che deve varare il testo della nuova Costituzione. Nella quale i republikaner di Josè Antonio Kast, tanto per cominciare, vogliono negare ai nativi araucani ogni diritto sui loro territori ancestrali, che animosamente rivendicano nel centro-sud del paese. Equivarrebbe a un’aperta dichiarazione di guerra.
Da decenni e con crescente intensità le diverse famiglie indigene cilene, dai quechuas ai collas, ai rapanui, agli aymaras (in totale un 13 per cento circa dell’attuale popolazione nazionale di circa 20 milioni di cittadini) si oppongono con ogni mezzo allo sfruttamento economico dei loro territori, i più ricchi di risorse naturali e tra gli ultimi negli indici di reddito degli abitanti. Denunce all’autorità giudiziaria e all’opinione pubblica internazionale, battaglie parlamentari e campali. Ci sono incendi nei boschi per impedire la raccolta del legname, incidenti nelle miniere, scontri a fuoco tra indigeni e carabineros. Al momento della Conquista, nel 1500, i loro avi impedirono per cent’anni agli spagnoli di Pedro de Valdivia d’oltrepassare il fiume Bio-Bio. L’ Araucania è una bomba a orologeria, concordano adesso storici di sinistra e di destra.
Per venirne fuori, Michelle Bachelet, nel secondo mandato, si era impegnata a riconoscere i diritti dei mapuches; e l’anno scorso, la prima assemblea costituente ne aveva recepito i principi fondamentali con la formula tanto auspicata: il Cile è una Repubblica multietnica e multiculturale, il suo è uno stato regionale. Molti hanno pensato che fosse la fine del centralismo e dell’emarginazione delle minoranze, sebbene rimanessero da definire le norme applicative (e: in cauda venenum). Ma il previsto referendum popolare ha invece spazzato via tutto con la furia d’un terremoto. Capovolgendo anzi la maggioranza della Convenzione in favore della destra, che considera un privilegio inaccettabile qualsiasi riconoscimento specifico in favore dei popoli originari.
Dopo un simile rovescio, la questione sta riprendendo adesso piena centralità nel dibattito politico. Tanto da catalizzare tutti gli altri diritti, la cui rivendicazione dilagò nelle gigantesche (un milione di manifestanti in piazza solo a Santiago) e tragiche (20 morti e migliaia di feriti) proteste del 2019. In una rinnovata vertenza che va dalla denuncia dello stato sussidiario, sul quale ha prosperato il modello neo-liberista con le sue gravi ineguaglianze, al mancato riconoscimento dei diritti umani violati dalla dittatura militare, malgrado l’impegno dei governi di centro-sinistra dal 1990 a oggi. E’ l’agenda che in una dozzina d’anni ha portato Gabriel Boric alla presidenza. E spiega la drammaticità che la cronaca quotidiana di quest’immediata vigilia imprime alla celebrazione del Cinquantenario.
Le associazioni per la difesa dei diritti umani ricordano che neppure la stato democratico ha perseguito con coerenza i crimini di Augusto Pinochet. Lo hanno fatto, senza successo, soltanto singoli magistrati, singoli cittadini. Non c’è stato alcun pentimento delle Forze Armate in quanto tali per le atrocità compiute e comprovate con definitiva certezza giuridica. Sono 1600 i desaparecidos dei quali non si trova traccia. Lo stesso presidente conservatore Sebastian Piñera ha chiamato “complici passivi” quei politici, alti funzionari civili e militari, quella parte di opinione pubblica che hanno reso possibile tanta inerzia. Né può essere considerato casuale che intervengano a interromperla, proprio ora che il presidente Boric annuncia un’inchiesta riparatrice, episodi sorprendenti e clamorosi.
Dopo mezzo secolo di dilazioni, un tribunale penale ha condannato in via definitiva a diverse e pesanti pene carcerarie 7 ufficiali dell’Esercito, per aver sequestrato, torturato e assassinato il 16 settembre 1973 Littrè Quiroga, un funzionario giudiziario, e il famoso musicista Victor Jara, oltraggiandone inoltre i cadaveri. Erano entrambi quarantenni e del tutto incolpevoli. Si tratta dei medesimi militari che ebbero il comando dell’Estadio Nacional, dove per innumerevoli mesi hanno deciso la vita o la morte di 5 mila detenuti, esercitando una violenza arbitraria e spesso estrema. Nel tempo, hanno tutti raggiunto le gerarchie più alte dell’Esercito e sono ormai a riposo. Il più anziano di loro e il più alto in grado, Hernan Chacon Soto, 86, che alcuni ex prigionieri non riescono a dimenticare, si è suicidato con un colpo alla tempia della sua pistola d’ordinanza per non affrontare il carcere.
Con Roberto Toscano
“Vibrante e penosissimo, comunque lo si guardi, il passato continua a incidere sul presente: è vero In Cile, nei Balcani, in Russia…”, commenta Roberto Toscano, che sull’etica nella politica, nella diplomazia e nel giornalismo, ragiona da decenni, proprio a partire dal golpe militar del 1973 in Cile, di cui è diretto, attivo e prezioso testimone. Ci conosciamo da allora. L’ho visto per la prima volta allo Stadio Nazionale, tentando di persuadere un capitano affinchè liberasse un detenuto di nazionalità italiana. Entrambi calmi, malgrado la circostanza; e il volto del militare mostrasse una certa voglia di arrestare anche lui. “Forse era uno degli ufficiali condannati adesso per l’assassinio di Victor Jara e Littrè Quiroga: erano tutti allo Stadio…”, azzardo io. “Chissà, potrebbe essere… Allora i gradi sulle spalline contavano più dei nomi, sempre che fossero veri…”, fa lui.
Vari anni ambasciatore in Iran e in India, Toscano ha avuto una brillante carriera diplomatica che dal Cile lo ha portato a Mosca, Madrid, Ginevra, con esperienze dirigenti anche al ministero degli Esteri a Roma. Senza mai trascurare di integrarla con studi e ricerche accademici tra le università di Parma, Harvard e Pisa, che gli hanno permesso di alimentare un’intensa attività pubblicistica negli Stati Uniti, e in Italia collaborando ai quotidiani La Stampa e La Repubblica. Ricorda: “In Cile ero al mio primo incarico all’estero: ho dovuto imparare a mangiare senza masticare, non ce n’era il tempo e bisognava deglutire con la testa invece che con la gola… Platone, Machiavelli, George Kennan, Huntington… civiltà e barbarie, tutto in un boccone. L’imperativo era salvare vite. In un anno, con Piero De Masi, il vicario dell’ambasciatore assente giustificato, e Damiano Spinola, come me secondo segretario, abbiamo ospitato in ambasciata 600 rifugiati. Da Roma non davano direttive precise, né riconoscevano la Giunta militare”.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, un colpo di stato militare in quanto tale non è una guerra civile, non lo è neppure l’eventuale dittatura militare che può conseguirne, malgrado l’evidente coercizione attraverso cui viene esercitato il potere. Sono violazioni della legalità istituzionale. In Cile, di fatto, fu un po’ di tutto questo, con l’aggiunta di radicati pregiudizi ideologici ed etnici: una miscela micidiale. A questa sintesi, Roberto Toscano acconsente con un cenno della testa che tuttavia comprende qualche perplessità, mentre tra le mani sfoglia le pagine del New York Times che sono la sua prima lettura quotidiana. Precisa: “In Cile il colpo di stato ha scatenato una violenza inusitata e la dittatura ha represso senza pietà. Tuttavia non c’è stata una guerra totale, una polemos (secondo Platone), che non riconosce l’altro, negandogli ogni umanità; si è trattato di una stasis, un conflitto organizzato contro una parte con cui si è sviluppata una divergenza valutata risolvibile solo con le armi. Ma con la quale si è consapevoli di dover prima o poi tornare a trattare”.
“Del resto – racconta –, fu un episodio selvaggio a costringere me, mia moglie Francesca e Manuel, il nostro primo figlio, nato durante la permanenza a Santiago, a lasciare il Cile. Era novembre del 1974, un anno dal golpe. Il cadavere di una giovane donna venne scaraventato nel giardino della nostra ambasciata attraverso il muro di cinta, vigilato all’esterno giorno e notte da militari armati. Era il corpo di Lumi Videla, una giovane militante della sinistra rivoluzionaria morta sotto le torture della polizia di Pinochet, subito riconosciuta da suoi compagni rifugiati in ambasciata. La propaganda dei golpisti disse che era stata uccisa dai suoi stessi compagni, in una rissa all’interno dell’ambasciata. Ma per fortuna mi fu possibile smentirlo inconfutabilmente. La capacità di mediazione che mi aveva permesso di salvare tanti perseguitati era però compromessa. Chiesi a Roma di essere sostituito. Ma non ho mai cessato di riflettere su quell’esperienza tanto terribile e significativa, che come vediamo continua viva.”
(1) Annota Kissinger (Gli Anni della Casa Bianca, giugno 1979, Sugarco, pag.545):
“(…) La Commissione d’inchiesta senatoriale (di Washington, ndr.), indagando apparentemente sul complotto dell’assassinio da parte del governo degli Stati Uniti, arzigogolò lungamente nel rapporto del 1975 sull’eventualità che Al Haig o io stesso avessimo ingannato la Commissione, quando testimoniammo che la progettazione del colpo di stato era stata sospesa il 15 ottobre (1970 ndr.) o che la CIA avesse proceduto senza autorizzazione. I fatti sono questi. La Commissione scoprì un secondo gruppo di cospiratori, oltre al gruppo del (generale, ndr.) Viaux, con il quale la CIA era in contatto e che aveva anch’esso in programma il rapimento del generale Schneider.
Né Haig né io fummo mai messi al corrente della loro esistenza per l’ottima ragione che essi non fecero mai nulla. Quando io ordinai che il progetto di colpo di stato fosse sospeso, il 15 ottobre 1970, Nixon, Haig e io pensammo che ciò sancisse la conclusione di tutto. Gli agenti CIA in Cile apparentemente ritennero che l’ordine riguardasse solo Viaux; si sentirono liberi di proseguire con il secondo gruppo di cospiratori dei quali la Casa Bianca ignorava l’esistenza. (…) Il 22 ottobre, il gruppo Viaux, a cui la CIA aveva esplicitamente ordinato di desistere, continuò ad agire di propria iniziativa e senza che noi lo sapessimo. Tentò di rapire Schneider e fece un pasticcio. Il generale estrasse la pistola per difendersi e fu ferito mortalmente da un colpo di fucile. (…)”.