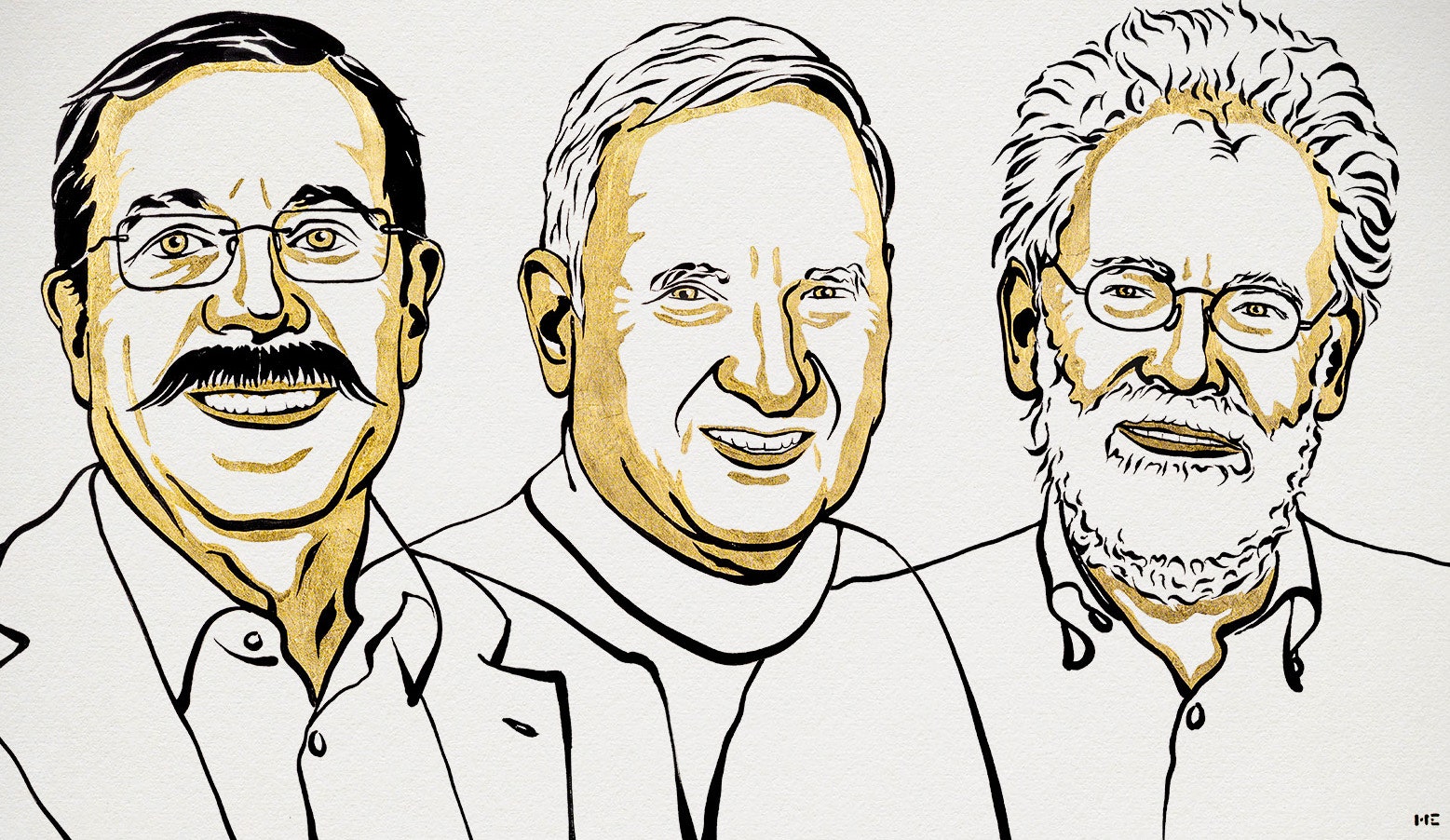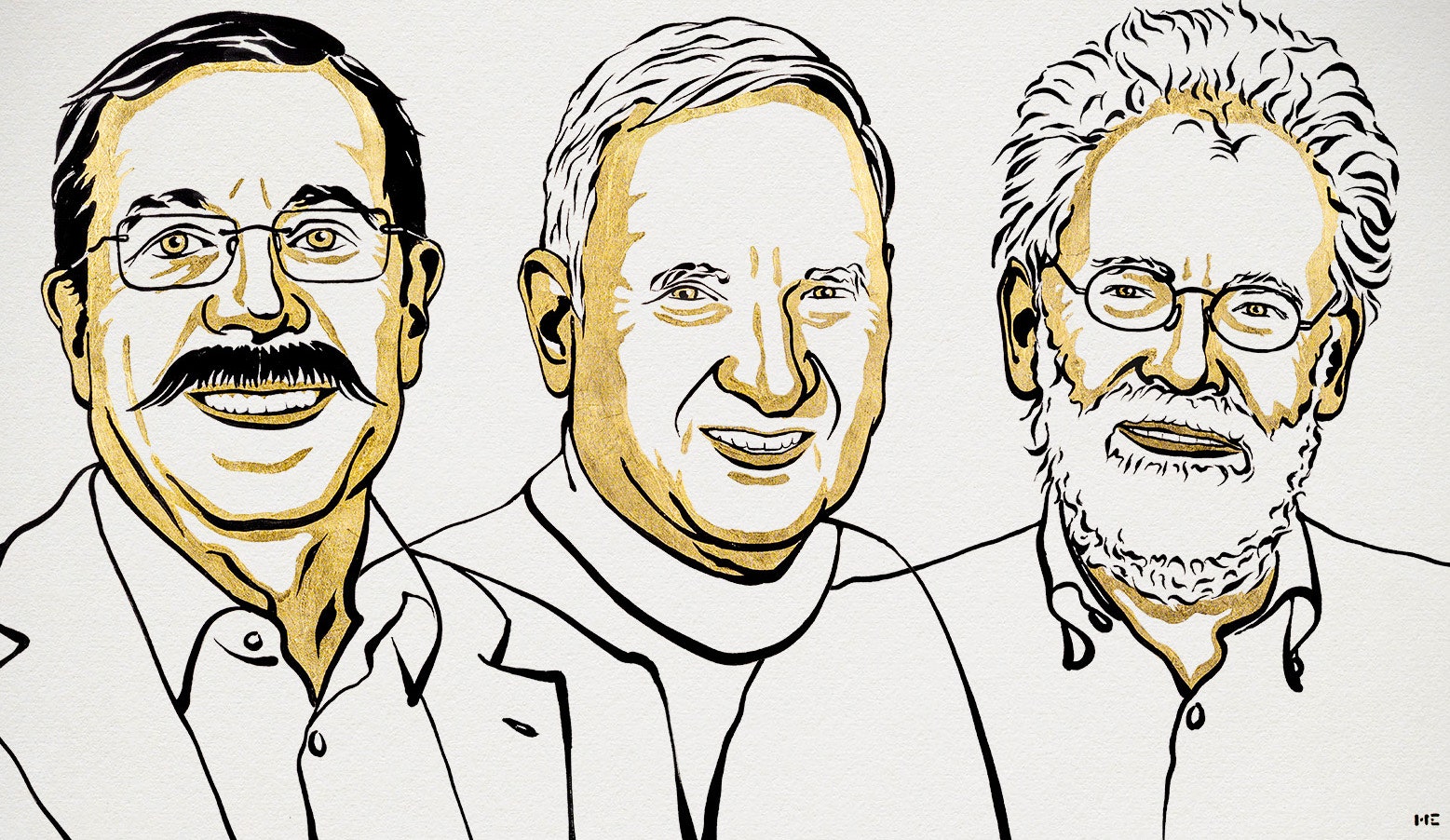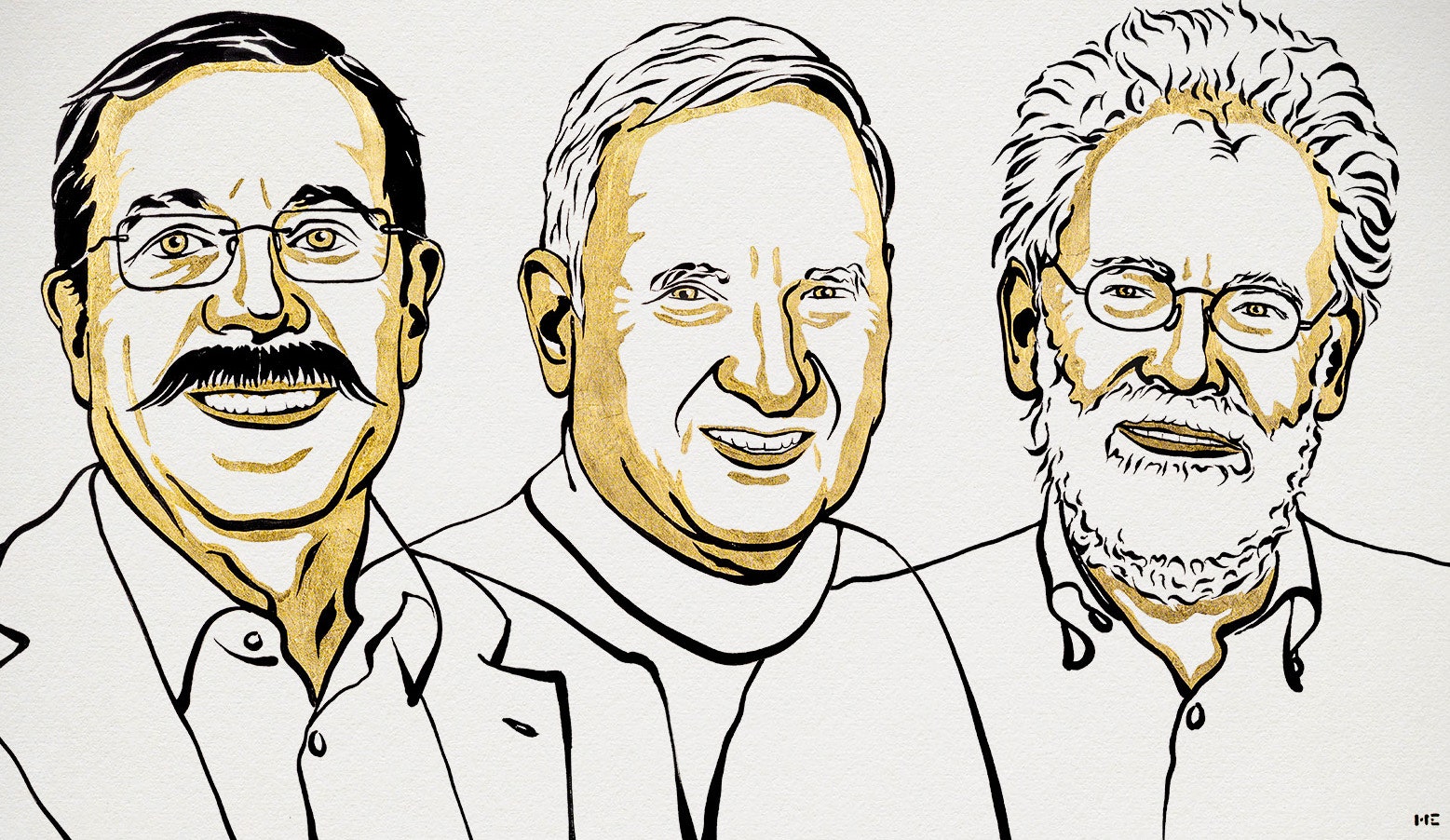Nel 2001, anno fatidico per molti motivi, il Nobel per l’Economia andò a Joseph Stiglitz, esponente dell’ala ultra-liberal che fin dagli anni Novanta aveva messo in discussione, nelle sue opere, la globalizzazione post-’89 che all’epoca, in tutto l’Occidente, era considerata una specie di dogma. E così, nei giorni che seguirono il G8 di Genova, in cui i mastini della deregulation mostrarono il loro vero volto, e mentre assistevamo alla “missione di pace” di Bush in Afghanistan, in seguito alla tragedia dell’11 settembre, il prestigioso riconoscimento venne assegnato a una personalità che aveva sempre messo in discussione i capisaldi del pensiero unico neo-liberista, ritenendolo pericoloso per l’avvenire dell’umanità.
Nel 2008, mentre infuriava la crisi economica, esplosa con il tracollo dei mutui subprime e l’implosione della Lehman Brothers, e mentre si cominciava ad assistere alle prime ricadute del disastro sulla cosiddetta “economia reale”, l’Accademia svedese premiò Paul Krugman, un altro critico delle disuguaglianze e della crescita senza controlli e senza alcun rapporto con l’andamento della democrazia. Due scelte di rottura, dunque, due precise indicazioni di una rotta alternativa che avrebbero costituito, negli anni successivi, altrettante bussole per orientarsi nel mare procelloso di una deriva senza precedenti, talmente pericolosa da mettere a repentaglio la tenuta stessa dell’Occidente. Stupisce, a tal riguardo, che quest’anno, in un altro momento di svolta planetaria, mentre assistiamo attoniti alle conseguenze del collasso dell’Occidente e ci rendiamo conto di quanto non funzioni più il tessuto sociale e politico dello stesso, siano stati premiati tre personaggi, Bernanke, Diamond e Dybvig, che invece continuano a porsi come cantori delle “magnifiche sorti e progressive” di un sistema bancario, in particolare quello delle banche centrali, che è fra i principali responsabili del declino che stiamo vivendo.
Una scelta difensiva, un arrocco, una forma di protezione disperata e inutile, come se l’Occidente, sentendosi in guerra con se stesso, oltre che con il resto del mondo, avvertisse la necessità di imprimere un colpo di coda, di far sentire il peso del proprio prestigio e della propria autorevolezza, di rivendicare con una certa arroganza la bontà delle proprie scelte, quando sono proprio quelle scelte, invece, ad averci condotto nella spirale di crisi sistemica e perenne di cui la guerra in Ucraina costituisce una delle mie sfaccettature. Un Nobel in contrasto, oltretutto, con la scelta meritoria di aver premiato, qualche giorno fa, il dissidente bielorusso Bialiatski e due associazioni da sempre in lotta contro ogni regime e autocrazia come la russa Memorial e il Center for Civil Liberties, esempio ucraino di dialogo e desiderio di pace, ormai rara avis in un contesto in cui risuonano prepotentemente i tamburi di guerra e si profila uno scenario simile a quello che caratterizzò il periodo fra il settembre del ’39 e l’estate del ’40, quando si compì il destino di una generazione e di un continente ed ebbe inizio una follia che è costata, complessivamente, oltre sessanta milioni di morti. Come ha affermato Riccardo Noury, portavoce italiano di Amnesty International, raramente un Nobel per la Pace è stato più appropriato di quest’anno, in quanto ottiene l’effetto che vorremmo vedere ogni giorno: una netta condanna dell’invasione russa ma, al tempo stesso, la ripresa del dialogo e il ritorno in auge del concetto di trattativa e di confronto, senza il quale le sofferenze della popolazione ucraina continueranno e, anzi, si acuiranno e ad esse si sommeranno le nostre e quelle del popolo russo, a cominciare dai dissidenti. A tal riguardo, va nella stessa direzione il meritatissimo Nobel per la Letteratura conferito giovedì scorso alla scrittrice francese Annie Ernaux, capace di mescolare pubblico e privato, intimità e analisi socio-politica, dando vita a un’opera di ampio respiro che unisce i temi globali e la psicologia interiore di una comunità che si sente messa fortemente in discussione. Non solo: alla Ernaux va il merito di aver reso protagonista la battaglia femminista, senza alcuna retorica e senza stucchevoli cedimenti all’estremismo, ponendo al centro temi essenziali come la partita di genere e i diritti civili, su tutti l’aborto, oggi minacciati dalla deriva retrograda e disumana cui stiamo assistendo pressoché ovunque.
Al che, sorge spontanea una serie di domande: perché l’Occidente ha paura del progresso? Perché ha paura di incamminarsi senza remore lungo la strada della convivenza pacifica? Perché il mondo della cultura e del sapere non si oppone all’oscurantismo imperante e alle scelte dissennate di alcuni governi? E perché avvertiamo un così forte senso di solitudine e sconforto collettivo? Il tutto, può essere riassunto in un solo quesito: perché non riusciamo a essere più la casa dei diritti e della dignità umana che avevano immaginato coloro che avevano dato vita al sogno di un’Europa unita e coloro che avevano pianificato un modello economico che ponesse l’essere umano al centro del modello di sviluppo, negli anni di Bretton Woods e della redazione delle Costituzioni democratiche e anti-fasciste del dopoguerra? L’affievolirsi di quello spirito di ribellione corale all’abisso è alla base della perdita di ogni utopia, della fine del senso profondo del nostro stare insieme e della nostra incapacità di immaginare un futuro diverso e altro per l’umanità nel suo insieme. Peccato che, con meno di questo, venga meno la nostra stessa ragione di esistere. E il Nobel timoroso, benché positivo, di questo triste 2022 è la conferma del malessere che pervade le nostre società, al bivio fra il ritrovare se stesse e il perdersi definitivamente.
Iscriviti alla Newsletter di Articolo21