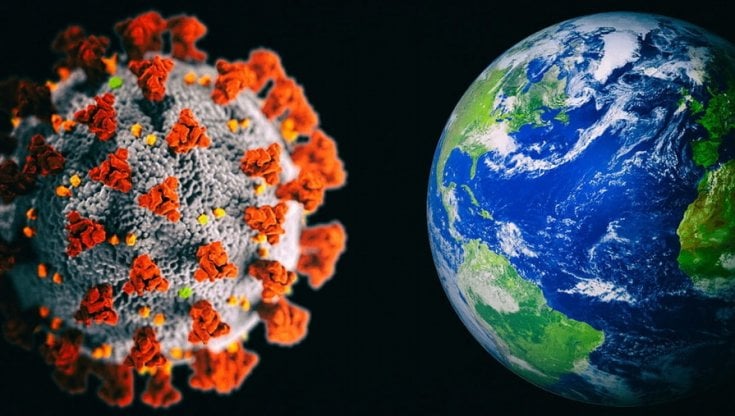Viviamo prigionieri del presente, in una sorta di “dittatura dell’istantaneo”. Ne abbiamo fatto esperienza in questa lunga stagione di pandemia con l’informazione che ci ha “confinato” in un tempo “senza profondità”. Ogni giornata è stata presentata come quella decisiva, del verdetto definitivo, allarmi e momenti di euforia si sono alternati in modo caotico\casuale privo di sintesi logica, un approccio che ha privilegiato su tutto l’emotività. Non si è colto che eravamo (e siamo) invece dentro una sequenza di eventi che avrebbe richiesto ben altra narrazione, non potendo essere letta seriamente con questa logica nevrotica e nevrotizzante. Lo stesso termine infodemia, usato per definire una diffusione eccessiva di notizie produttrice di confusione piuttosto che di conoscenza, è stato esibito come un neologismo, strettamente connesso alla contemporanea “egemonia” esercitata su di noi essenzialmente dai social network. Niente di più falso, “infodemic” è un’espressione del 2003 usata da un ricercatore sul Washington Post in occasione della precedente epidemia di Sars. Si riferiva alle notizie rilanciate dalle tv, dai blog, dagli stessi quotidiani. Ricordo che nel 2003 non c’erano smartphone, Facebook e Twitter, tanto meno Instagram. Cosa ci fa comprendere questo piccolo esempio? In primo luogo un fatto inoppugnabile: che occuparsi di storia e dunque pure di tecniche e effetti del giornalismo vuol dire andare all’origine delle questioni, dare un contesto ai “problemi dell’informazione”. Significa, come ci ha insegnato il prezioso lavoro di Paolo Murialdi, uscire dalla gabbia dell’immediato senza memoria. Sulla sua fondamentale rivista (così utile alla riflessione perché capace di superare la distinzione fra teoria e pratica della professione) ho avuto modo di pubblicare un estratto della mia tesi di laurea dedicata al Corriere della Sera degli anni di Salò diretto da Ermanno Amicucci. Una pagina drammaticamente oscura del nostro giornalismo che mi ha trasmesso però una convinzione: anche dalle fasi più torbide possiamo imparare cose importanti, basti provare a immaginare quanto potrebbe essere utile adesso uno studio comparato su assonanze e differenze fra allora e oggi sul tema del razzismo, dominante nella pubblicistica fascista e così attuale nella nostra Italia del 2021.
Ciò che intendo dire è che noi, anche quando ci occupiamo di storia, parliamo sempre con lo sguardo rivolto al futuro. I riferimenti storici ci aiutano a comprendere meglio quanto stiamo facendo, ci liberano dall’errore di credere che quanto ci accada sia totalmente inedito, ma il nostro sguardo poi, alla fine, resta sempre inevitabilmente proiettato verso l’avvenire. Non può che essere così perché questa è l’esperienza di vita di noi umani. La parola chiave è contesto, un’informazione che ne sia priva è simile a una nave senza timone, che navighi alla deriva senza una rotta. Per avvicinarli alla comprensione del peso esistenziale del passato, mi è capitato spesso a lezione di proporre agli studenti dei corsi universitari un approccio genealogico, che si ponesse cioè il problema di ragionare sull’origine e il senso del mondo nel quale “erano stati gettati”. Piuttosto che fare discorsi retorici sull’importanza della memoria, li ho invitati a vedersi come i protagonisti di una serie televisiva. Potevano comprendere realmente ciò che li circondava e che stava loro accadendo senza sapere nulla del contenuto delle puntate precedenti? Senza contestualizzare la loro esperienza di vita?
Eccoci allora al merito. Noi dobbiamo guardare dentro le dinamiche del giornalismo d’oggi senza dimenticare le lezioni che ci vengono da quello di ieri ma occorre farlo superando ogni sterile atteggiamento nostalgico. Non si può assolutamente eludere un grande problema, quello della velocità con cui viaggia la evoluzione tecnologico/digitale. Le fratture generazionali paiono enormi, per tanti aspetti sembra che chi è venuto prima abbia ben poco da trasmettere/insegnare a chi si affacci ora alla vita professionale nel campo dell’informazione. E’ questa la ragione per la quale il passato, erroneamente, non appare più ai giovani come “un deposito di esperienze cui attingere”. “Dobbiamo accettare le sfide dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale, padroneggiare nuovi strumenti” si sente ripetere da alcuni. Personalmente sono sempre stato affascinato dalle frontiere più avanzate della comunicazione e dunque sono il primo a ritenere ( lo ho appena ribadito) che una “visione nostalgica” non porti da nessuna parte. Ma a chi esalta le potenzialità degli algoritmi nell’informazione chiedo di spiegarmi con chiarezza quale sia poi, nei suoi schemi interpretativi, il ruolo degli umani. Quanti restano al lavoro? Cosa fanno? Che compiti svolgono? Quanto sono pagati? Fanno i “pastori/sorveglianti” delle macchine o sviluppano la propria creatività?
Detto questo, occorre guardare dentro il giornalismo odierno con un’attenzione mirata ai fenomeni concreti. Dividersi fra chi vive di rimpianti e chi fa il profeta del “sol dell’avvenire tecnologico” è sostanzialmente inutile, un gioco delle parti che peraltro si ripete (anche se i polemisti d’oggi proprio non lo sanno) quantomeno dall’inizio del novecento. Per orientarsi nel labirinto delle abitudini mediatiche odierne, può essere indispensabile invece alle volte arricchire se non addirittura ribaltare la prospettiva. Prendete la faccenda delle fake news e della post verità. Quanto se ne è parlato dal 2016 a oggi? Avendo personalmente dedicato molta attenzione/studio al tema sono giunto a una conclusione che si è riflessa in un libro (“La Passione per la Verità”, Franco Angeli Editore, Roma 2020). Il “punto di arrivo” è che la denuncia del falso e strumenti come il fact checking o il debunking (lo smascheramento delle menzogne) sono sì utili come forma di autodifesa ma non incidono sulla diffusione delle bufale. E cosa serve allora? Occorre invece esattamente quanto in Italia proprio ci manca: una strutturata educazione critica all’uso dei media, all’analisi di tutta la galassia degli strumenti mediatici oggi esistenti. Per i giornalisti, per chi vive di informazione, c’è un passaggio in più. E’ qui che va rovesciata la prospettiva. Ciascuno di noi, prima ancora di denunciare gli errori altrui, deve interrogare se stesso, porsi una domanda centrale: cos’è per me la verità, quella che io credo di trasmettere tutti i giorni?
Guardate che rispondere che è la verità dei fatti (come è scritto peraltro opportunamente nella legge istitutiva dell’Ordine) non basta assolutamente. Perché c’è il fatto che è un avvenimento incontrovertibile (il terremoto, l’alluvione, la rapina) ma c’è anche quello “costruito” come prodotto di un’operazione comunicativa. Faccio un esempio concreto. Il messaggio video su Facebook di un politico è un fatto o una comunicazione promozionale, marketing propagandistico, un “artefatto”? Perché viene rilanciato ovunque, mentre ad esempio magari nemmeno si parla dell’approvazione di una legge varata lo stesso giorno in Parlamento? Chi decide cosa merita una discussione pubblica e cosa no? Oppure, guardando dalla parte opposta del nostro spettro sociale, agli “invisibili”, perché ci sono argomenti che hanno immediatamente un’enorme rilevanza e altri che scompaiono? Prendete le stragi negli Stati Uniti provocate dalla incredibile libera diffusione delle armi automatiche, ormai finiscono nelle brevi di cronaca. Lo stesso accade per le cosiddette guerre dimenticate o per i morti sul lavoro in Italia, un autentico “rosario di martiri” del cosiddetto progresso. Perché le notizie sul loro sacrificio non diventano storie da raccontare, se non in casi assolutamente eccezionali?
Quindi è una “risposta facile” parlare di “verità dei fatti” ma non è per nulla sufficiente. Ce lo conferma pure la sostanziale marginalizzazione delle inchieste giornalistiche e dei servizi accurati che abbiamo registrato nei lunghi mesi della pandemia. In questo mio intervento, dato lo spazio a disposizione, sono costretto inevitabilmente a procedere semplificando. Ma c’è un punto al quale non possiamo sfuggire perché è un dato di realtà: che la grande differenza rispetto al passato è l’enorme rumore mediatico odierno, con la moltiplicazione dei messaggi e delle voci, quella che la straordinaria immaginazione di Borges rappresentò come una labirintica “Biblioteca di Babele” ora divenuta realtà. Anche per questo è impossibile pensare di tornare ai “bei tempi andati”. E’ poi parallelamente cresciuta, in maniera esponenziale, la cosiddetta società dello spettacolo, espressione che ebbe il suo “battesimo del fuoco” addirittura nel 1967 col titolo di un libro profetico di Guy Debord. Un fenomeno che nel ventunesimo secolo si è dilatato a dismisura nel “villaggio globale” che contrassegna la nostra epoca con la Rete che alimenta il continuo “rimbalzare” dei filmati su ogni tipo di piattaforma o di device. Tutto corre a grandissima velocità e mutano pure gli attori dell’informazione. Servono conferme? Basti pensare alla citazione speciale che il Premio Pulitzer 2021 ha voluto assegnare a Darnella Frazier una ragazza di 17 anni che ha avuto il grande merito di filmare per sette minuti col proprio telefono il momento in cui a Minneapolis l’agente Derek Chauvin uccideva il povero George Floyd. Una lunga ripresa che ha certificato la gratuita violenza verso un ormai inerme afroamericano e che è stato determinante in tribunale per la condanna del poliziotto per omicidio. Non le è stato assegnato direttamente il Pulitzer, conferito invece a un giornale locale di Minneapolis, ma questa citazione a Darnella ha voluto attribuire un esplicito riconoscimento al contributo che singoli cittadini possono fornire oggi, con gli strumenti in loro possesso, alla ricostruzione dei fatti e conseguentemente alla giustizia e all’informazione. E qui siamo a un punto decisivo, sul quale tornerò pure in conclusione, perché il giornalismo del nostro secolo non può escludere, anzi deve valorizzare, l’apporto che può arrivare dai singoli cittadini, da chi è in grado di documentare gli eventi. Quello informativo è oggi un ecosistema complesso e frammentato nel quale dobbiamo operare senza arroganza e presunzione, con uno sguardo critico anche verso i nostri tradizionali comportamenti.
E siamo alla questione al centro di questo appuntamento dedicato alla “perenne transizione del giornalismo”. Che si può tradurre in due domande: Cosa sta accadendo? Dove stiamo andando? L’espressione che ci è stata suggerita richiede una risposta articolata. Le semplificazioni ci portano a un riduzionismo che poi imprigiona il nostro spirito critico. In sedi come questa dobbiamo invece osservare e descrivere le cose come stanno senza pudori del tutto controproducenti. Per questo partirei con un approccio fenomenologico chiedendomi soprattutto come oggi la nostra professione venga percepita dal grande pubblico. E’ un passaggio fondamentale per “fotografare” l’identità giornalistica calata nella dimensione sociale. Per tutti quei cittadini che ogni giorno seguono gli eventi attraverso i dibattiti televisivi, i talk show, chi sono questi “personaggi pubblici” chiamati giornalisti? Per molta gente sono percepiti come i grandi esperti d’oggi, i “sapienti” che, dalla mattina alla sera, pontificano su ogni materia, dal coronavirus all’economia, dalla politica nazionale all’Europa, da Biden ai migranti, a qualsiasi cosa. Questi “predicatori” sono inevitabilmente vissuti dalle persone come espressione del “potere di indirizzo” che arriva dalle elité che guidano la vita pubblica italiana da studi televisivi che trasmettono la loro voce in tutte le case. Non sto esagerando e nemmeno sto parlando soltanto dei conduttori ma dell’intera compagnia di giro (nella quale sono entrati a pieno titolo anche presunti scienziati e virologi) che ti spiega cosa si debba fare con le mascherine, che è pronta poi a “stigmatizzare” i giovani e la movida e subito dopo passa a illustrare come debba essere impostato e gestito il recovery plan. Ricordate il Socrate del “so di non sapere”? Il tuttologo, che oggi sentenzia su ogni argomento, fa esattamente l’opposto, senza un minimo di ritegno. Si è trasformato in una sorta di profeta/oracolo del nostro tempo. Al pubblico rimane solo la scelta del proprio campione all’interno del gruppo di questi attori, stabilire per chi fare tifo e poi rilanciare questa decisione nei propri commenti sui social in un circuito di chiacchiere che si autoalimenta.
Quello che mi preme segnalare è che questa compagnia di giro, espressione piena delle logiche della società dello spettacolo, è composta da poche decine di persone (sempre le stesse, è una delle regole del gioco). Una volta si diceva che i fatti dovevano restare separati dalle opinioni, ora invece, in questo territorio televisivo che peraltro impatta le abitudini di oltre il 90% degli italiani, sono rimasti soltanto i commenti. Spesso addirittura ridotti a profezie e pronostici. Paradigmatica la domanda del conduttore che, di fronte alla complessità dei temi, per sintetizzare il tutto in una formula, chiede al collega ospite: “Secondo te come va a finire?”.
Non si tratta di colpevolizzare nessuno, stiamo parlando di un sviluppo naturale quasi inevitabile della spettacolarizzazione mediatica della dimensione pubblica (determinato dall’interazione fra Tv e Rete e che, a cascata, arriva fino ai quotidiani) dove il valore più importante non è il contenuto che proponi, ma la parte che reciti, che poi ti procura visibilità, fama, popolarità. Monete che puoi spendere in vari modi (ci sono giornalisti che, oltre a sfornare libri a raffica, recitano a pagamento nei teatri delle nostre città), la cosa importante è che tu stia saldamente al vertice della piramide, che tu appaia sugli schermi con continuità.
E’ una dimensione commerciale dell’informazione che non va condannata pregiudizialmente. I punti da considerare sono piuttosto due. Il primo lo abbiamo anticipato, è che (piaccia o non piaccia) l’immagine pubblica della professione oggi è determinata da queste esibizioni. Se domandate a un italiano chi sia il giornalista non vi darà una definizione, vi risponderà facendovi dei nomi. E’ un meccanismo analogo a quello della politica dove contano i volti dei leader non certo i programmi.
Il secondo punto verte su una domanda: questo prevalere delle opinioni su tutto il resto produce conoscenza? La risposta non può che essere negativa. Negli Stati Uniti questi tuttologi che pontificano su ogni branca dello scibile umano li chiamano “sociologi da finestrino”, un’espressione illuminante che indica le persone che, dopo essere velocemente transitate in macchina per un luogo, si sentono in diritto di parlarne come se avessero vissuto in quella realtà, l’avessero vista da vicino. Il problema è stato posto con acutezza da Papa Francesco che, nel suo messaggio per la giornata delle Comunicazioni Sociali del 2021, ha denunciato il rischio dell’informazione fotocopia, preconfezionata, e ha evidenziato piuttosto l’importanza della testimonianza giornalistica, del riferire ciò che si è visto, di non ripetere formule stereotipate.
Possiamo dare la colpa di tutto questo ai social? Se lo facessimo dimostreremmo solo una sorta di ipocrita, ridicola miopia. In realtà, come è noto ormai da decenni, in campo mediatico quelle che contano sono le contaminazioni crossmediali. E’ vero dunque che le logiche social abbiano sicuramente inciso in questa proliferazione incontrollata dei “commenti senza verifica” delle notizie. Certo però non sono stati Facebook e Twitter a determinare la scomparsa, qui denunciata anche in altri interventi, delle inchieste giornalistiche sul territorio. La Lombardia, tutto il Nord Italia nel 2020 sono stati colpiti da un autentico inaudito tsunami sanitario che ha portato a una strage di anziani senza precedenti. Quante inchieste hanno documentato le situazioni che si erano create negli ospedali, nelle case di riposo, le responsabilità di chi aveva smantellato la medicina territoriale? Quante cose forti sono venute alla luce per merito dell’informazione professionale?
E questo ci porta a parlare degli altri giornalisti, quelli che sono posizionati in posizioni di minore visibilità rispetto al vertice della piramide dei direttori/opinionisti televisivo/social. Siamo peraltro in un territorio che non è per nulla omogeneo. Ci sono, nella “fascia intermedia”, le figure professionali legate ai desk, alle macchine redazionali, che operano al chiuso, assemblano i prodotti, fanno i titoli, impaginano, montano i filmati. Siamo lontani dalla dimensione della “professione liberale” di un tempo, su molti incombono minacciose ristrutturazioni aziendali, contrazioni del numero di occupati, ovunque vengono richieste prestazioni quantitative piuttosto che apporti di qualità. Anche se c’è molta frustrazione fra queste persone per il regime di incertezza che concerne il loro futuro, va detto che godono tuttora di meccanismi di garanzia contrattuali e in taluni casi pure della possibilità di esprimere il proprio punto di vista, di poter esercitare margini di autonomia. Ben più pesante e problematico è invece quanto accade nella ultima fascia della professione, quella dello sfacciato sfruttamento. Si tratta soprattutto di giovani. Qualcuno, a livello sindacale, ha giustamente cominciato a chiamarli i “rider dell’informazione” perché ( sul piano retributivo e dei diritti) sono molte le analogie riscontrabili fra questi colleghi e i fattorini che consegnano le merci, i pacchi, le pizze. Giornalisti (le aziende li chiamano collaboratori) che vengono fatti lavorare per 4 euro a pezzo dalle gerarchie redazionali. Coi miei occhi ho visto la busta paga di una ragazza di Rovigo, peraltro laureata in legge, che certificava un netto mensile di 87 euro. Sono gli “invisibili” di un sistema editoriale che a parole rivendica l’importanza della qualità ( rispetto alla comunicazione priva di intermediazione) ma nei fatti non è in grado di garantire standard di lavoro dignitosi e quindi nemmeno un prodotto decente. Pesano, nel dilagare di queste pratiche di lavoro “degradanti”, i costanti cali delle vendite delle copie di carta dei giornali, l’arretratezza con cui si è proceduto nel riformulare la propria offerta su Internet, le crescenti perdite economiche. Sono cose note, quello che è meno conosciuto è che non poche testate provinciali stanno cercando di rilanciarsi come brand (un nome e una riconoscibilità sociale ce l’hanno ancora malgrado il crollo di copie in edicola) diventando promotori di eventi commerciali sul territorio. Cosa abbia questo a che fare col giornalismo è tutto, ovviamente, da dimostrare.
Ho parlato di approccio fenomenologico, dell’importanza di analizzare le cose come stanno. La parola “transizione” implica la capacità di leggere le stratificazioni che si sono sovrapposte. Siamo giunti al passaggio forse più delicato di tutto il discorso. Descritti i termini della situazione esistente che futuro possiamo vedere per il giornalismo? Credo che in primo luogo il nostro orizzonte debba allargarsi. Non dobbiamo fermarci ai nominalismi. La domanda deve diventare un’altra: se esistano margini concreti anche nell’avvenire, nel tempo delle cosiddetta intelligenza artificiale, per persone che esercitino una professione che si assume il compito di informare gli altri cittadini. Non so se nel 2050 si chiameranno ancora giornalisti ma ipotizzo che questo tipo di attività (la storia dell’umanità è lì a dimostrarlo, i cronisti sono sempre esistiti) non scomparirà neanche al tempo della moltiplicazione esponenziale delle fonti e degli algoritmi. Ci sarà sempre qualcuno che svolgerà il compito ermeneutico, di interpretare fatti e notizie. A proposito degli algoritmi ripeto che trovo “stucchevole” ogni contrapposizione fra chi li rifiuta (quasi sempre per pigrizia mentale) e chi li esalta (magari per accreditarsi come innovatore). E’ un dibattito sostanzialmente inutile, sicuramente sterile. Ribadisco ancora che gli algoritmi sono strumenti (programmi, in senso lato) pensati e costruiti da persone/società con intenti precisi che vanno studiati e compresi. Il loro uso che effetti produce su chi li adopera? E’ questo il punto centrale. Così, se la programmazione dei social ha lo scopo di aumentare il traffico sulla piattaforma, di profilare i comportamenti degli utenti, possiamo poi meravigliarci che valorizzino la emotività delle persone che li utilizzano piuttosto che la loro riflessione?
Non è il tema di questo incontro e dunque mi fermo. Il ruolo degli “umani” nel campo dell’informazione, comunque decideremo di chiamare questi redattori, resta quello di raccogliere le notizie, metterle insieme, organizzarle, svelare ciò che il potere vuole resti nascosto, dare agli eventi narrati un contesto. Segnali positivi che questo stia continuando ad avvenire ce ne sono, basta saperli leggere. Spazi di approfondimento nei quotidiani esistono, come pure trasmissioni televisive di inchiesta coraggiose e importanti. Non viviamo in una “notte dove tutte le vacche sono nere”. Quello che vorrei qui segnalare è però soprattutto l’attività in Italia di alcuni siti di news nati in Rete dove lavorano soprattutto giovani colleghi che hanno fatto (pure sui temi della emergenza sanitaria) un ottimo lavoro di divulgazione/informazione. Chi ha studiato la storia italiana ha ben presente le connessioni iniziali del giornalismo delle origini (ottocento, primo novecento) con la narrativa, le lettere, la scrittura. Oggi se ne profila un’altra di contaminazione, quella con i ricercatori, sociali o scientifici che siano, che non entrano nel grande circuito degli esperti tv ma proprio per questo comunicano distinguendosi per competenza, conoscenza dei temi, visione. Rispetto ai “sociologi da finestrino” siamo a un salto di qualità enorme: queste persone sanno di cosa parlano. Le fonti di finanziamento di queste attività possono essere variegate. Un’esperienza particolare, che voglio segnalare non solo perché l’ho conosciuta direttamente, è quella del Bo Live, il giornale online dell’Università di Padova. Ci lavora un gruppo di giovani, sostanzialmente dei ricercatori che fanno un lavoro mirato alla divulgazione, che ha ottenuto riscontri rilevanti pure a livello europeo. Si occupano dei grandi temi che riguardano il presente/futuro della nostra società, dalle migrazioni, alle crisi internazionali, al rapporto scienza politica così rilevante (pandemia a parte) su questioni di assoluta urgenza come la crisi climatica e il riscaldamento del pianeta. La segnalazione è importante, non solo perché si tratta di un’esperienza di successo, ma perché in questo caso è stata la formazione universitaria a finanziare l’informazione, una delle soluzioni possibili. Ma non certo l’unica.
L’altra strada possibile è quella del crowdfunding, della raccolta di fondi dal basso, dei microfinanziamenti, di chi invita gli utenti a donare piccole somme di denaro per sostenere un’attività editoriale. Ma qui c’è un ragionamento “strategico” da fare sul concetto in senso esteso di marketing. Per il dizionario Treccani “il marketing è il complesso dei metodi atti a collocare col massimo profitto i prodotti in un dato mercato”. Tutto chiaro? No, ci resta un’altra domanda: qual è il mercato cui ci si rivolge? Che cosa si propone in realtà di promuovere un’attività editoriale per garantirsi un’indipendenza economica? La risposta tradizionale è quella che si vendono “appetitose notizie”, magari fatti di nera gonfiati all’inverosimile. Contemporaneamente si offrono agli inserzionisti pubblicitari i propri lettori o (con maggior successo) i telespettatori. Ovvio che in situazioni di crisi questo meccanismo si avviti su se stesso. Anche perché c’è la concorrenza dei giganti del Web ( Google e Facebook in testa) che “vendono” invece i profili di navigazione di chi fa ricerche o posta le proprie opinioni. Monopolisti che offrono la pubblicità mirata, cosiddetta predittiva, che prevede cioè gli interessi futuri dei navigatori sulla base dei comportamenti passati.
Ma c’è anche un altro modo di concepire il marketing, l’offerta informativa. Lo illustro facendo un esempio concreto. Ha fatto molto rumore a inizio giugno 2021 un’inchiesta realizzata negli Stati Uniti dal sito di giornalismo investigativo ProPublica a proposito della sostanziale esenzione fiscale di cui godono i 25 americani più ricchi. Siamo davanti allo 0,001% della popolazione che praticamente non paga alcuna tassa sui redditi pur avendo accumulato in 5 anni entrate pari a quelle realizzate da decine di milioni di cittadini statunitensi che le tasse le pagano eccome. Sia chiaro che non stiamo parlando di patrimoni preesistenti ma di aumento della ricchezza. Addirittura Jeff Bezos (storico fondatore di Amazon) ha ottenuto persino un credito fiscale di 4.000 dollari per il mantenimento dei figli tanto risultava privo di entrate. Si tratta dello stesso Bezos che negli ultimi cinque anni ha guadagnato 99 miliardi di dollari. Se non è reddito questa crescita patrimoniale che cos’è il reddito? Bene, il punto che qui ci interessa non sono gli strumenti di elusione fiscale che sfruttano i miliardari ma come lavorano questi di ProPublica. Hanno ottenuto i documenti dell’Agenzia delle Entrate americana da una fonte anonima che ovviamente loro proteggono. Hanno poi esaminato migliaia e migliaia di pagine, lavorato mesi e mesi, con un preciso messaggio rivolto ai lettori “vi facciamo vedere fisicamente, materialmente, in maniera documentata, quanto il sistema sia iniquo. Non è vero che ogni americano paga le tasse in rapporto al reddito che ha. C’è una estrema minoranza che non paga assolutamente nulla rispetto al tartassato ceto medio”.
La cosa potrà avere effetti dirompenti. Ma perché ho fatto riferimento al marketing? Perché se voi andate nel loro sito vedete che ProPublica (pur essendo nata con l’apporto di una Fondazione) di promozione ne fa, eccome. Ripetutamente chiedono agli utenti di fare donazioni che sostengano la loro attività di giornalismo investigativo. La loro parola d’ordine è “noi non stiamo zitti”. Non si deve tacere davanti alle iniquità, agli abusi, alle sopraffazioni. Ma non si fermano alla richiesta di un contributo, fanno molto di più. Promuovono la partecipazione degli utenti alla “costruzione della storia” e lo fanno in due direzioni. Da un lato chiedono a chi ha delle notizie da segnalare sulla vicenda raccontata di contribuire a arricchirla, dall’altro sollecitano chi abbia competenze in materia fiscale a metterle a disposizione del lavoro di lettura e ricerca dei dati degli stessi redattori. Lo chiamerei marketing partecipativo, il messaggio agli utenti è quello di contribuire attivamente alla costruzione del lavoro giornalistico. La sollecitazione ovviamente è anche quella di proporre altre storie ma questo non è del tutto originale, lo fanno pure altre testate, persino in Italia. Il punto che vorrei segnalare è che ProPublica ha cento giornalisti, paga stipendi che arrivano anche a 250mila dollari l’anno, tutt’altro che disprezzabili, non stiamo proprio parlando di “rider dell’informazione”. Il sito ha un rapporto di collaborazione con testate tradizionali cui fornisce i materiali senza pretenderne i diritti, semplicemente per usufruire del ritorno promozionale che questa collaborazione determina. Ecco perché sostengo che c’è marketing e marketing. Il punto è cosa un editore effettivamente vuole, Se cerca la pubblicità della Tim o di altre compagnie telefoniche si comporterà in un modo, se vuole avere finanziamenti dagli imprenditori locali in un altro ancora moltiplicando gli eventi promozionali. E l’alternativa allora qual è? E’ invece quella di proporre un’idea di alleanza con il pubblico, con i lettori, con i cittadini. Se volete è la antica tesi del giornale che ha per unico padrone il lettore, ma coniugata in termini contemporanei, portata avanti seriamente e non per finta. Altro che algoritmi, qui si che sfruttiamo le potenzialità offerte dalla Rete e dalla diffusione degli strumenti tecnologici. E’ riproducibile questo modello in Italia? Volendo, sicuramente si. Esempi non mancano nel nostro paese e pure nella vicina Francia. C’è pero un “prerequisito” tutt’altro che banale:per ottenere una risposta come sito\giornale devi avere una forte identità e aver maturato una credibilità. Non possono fare queste operazioni testate che strizzano gli occhi agli allarmismi, al pressappochismo, che sostengono il potente di turno con acefalo conformismo. In poche parole il punto è dove una testata intenda collocarsi. Se pensi di essere un soggetto che cerca profitti immediati, allora fai informazione di tipo commerciale, cerchi i clickbait in Rete, fai un certo tipo di operazione e vai in una direzione. Se invece ti proponi come un servizio per la comunità e per il cittadino fai un altro tipo di marketing, che coinvolge istanze, giudizi e contributi (anche finanziari) dei lettori/navigatori. Lo puoi fare perché oggi la Rete consente interazioni sconosciute in passato.
In poche parole, più che affidarci a “magici strumenti”, davanti alla “rivoluzione digitale” dobbiamo ripensare le nostre mappe mentali di operatori dell’informazione. Non si tratta soltanto di introdurre tecniche innovative (infografica e multimedialità) ma del superamento della frattura fra chi “fa il giornale e chi lo legge”. La “forma di vita” del giornalismo è cambiata e continuerà a mutare sempre di più proprio perché la comunicazione è al centro dei processi evolutivi del nostro tempo. Qui però, e la cosa va detta, emergono evidenti pure le pesanti responsabilità della politica perché in Italia si parla tanto di autostrade digitali ma non si fa sostanzialmente nulla per la educazione digitale come se il comunicare non fosse meritevole di spazi di riflessione/studio supportati da adeguati investimenti.
E il “restiamo umani” rimane un punto di riferimento assoluto. Un giornalismo che voglia avere un futuro davanti a sé deve fare della accuratezza la propria arma principale. Non possediamo verità, siamo persone che cercano di riportare correttamente fatti, di essere utili alla comunità nella quale sono inserite, pronte a accettare critiche, integrazioni, apporti esterni. Guardarci dentro è ciò che di più importante possiamo fare. Ce lo sta dimostrando un’esperienza che abbiamo realizzato nel Veneto col fondamentale apporto del Sindacato Giornalisti Regionale e dell’Università di Padova che ha firmato con la Fnsi una convenzione per dare vita a un laboratorio in cui ricerca e informazione lavorano finalmente insieme. Ne sono nati un convegno nazionale, un libro, ma soprattutto un corso di “educazione permanente” articolato in ben dieci appuntamenti. Quello che mi preme segnalare è la “diversità” di questo corso che va ben oltre gli appuntamenti formativi isolati e occasionali. Linguaggio inclusivo, disuguaglianze, innovazione, giornalismo investigativo, ricerca della verità (qualunque cosa voglia dire) , libertà di espressione, diritti, conflitti, algoritmi, sono i grandi temi su cui riflettiamo. Con l’apporto di docenti del Corso di laurea di Psicologia dell’Ateneo, e di relatori da tutta Italia, cinquanta giornalisti stanno, in questo non certo facile 2021, rileggendo il loro modo di stare nella professione. La cosa veramente clamorosa, che smentisce tanti luoghi comuni, è la crescente soddisfazione dei corsisti.
Che l’informazione professionale sia in pericolo è cosa indubbia, ma è proprio nelle situazioni di crisi, nelle tempeste più pericolose, che possono svilupparsi gli anticorpi che ci indicano la strada per salvarci. La cosa più importante di tutte è quella di affrontare a viso aperto il cambiamento ripensando noi stessi, seriamente. Con un occhio attento alla cittadinanza che non è un soggetto passivo cui vendere delle spazzole/bufale ma un interlocutore attivo con cui condividere impegno civile, progetti, speranze.