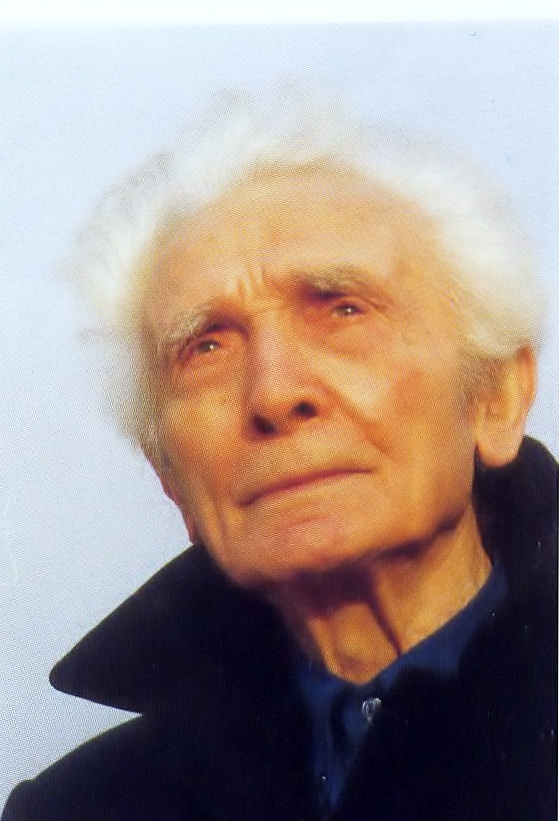Quando il regista passò a miglior vita, padre Arpa fu chiamato a officiare insieme al cardinale Monsignor Achille Silvestrini, prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali, la messa funebre in Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la basilica romana di Piazza della Repubblica (già piazza Esedra) nella quale si celebrano i funerali di Stato.
Amico di Federico fin dai tempi di La Strada, Angelo aveva salvato dal rogo Le notti di Cabiria, e difeso a viso aperto La dolce vita contro la curia vaticana, a rischio di gravi conseguenze disciplinari, prima fra tutte la già ricordata sospensione ‘a divinis’, che consiste nell’interdizione per il sacerdote a recitare la Messa e a consacrare l’Ostia. Padre Arpa era stato allontanato persino dal proprio ordine, al quale rimase indissolubilmente legato, ottenendo la riammissione solo in ‘articulo mortis’, poche ore prima della dipartita, grazie alla strenua tenacia di padre Michele Lavra, prefetto dei Gesuiti, e amico devoto del venerato confratello.
Nell’aneddotica felliniana al tempo de La dolce vita Federico si era rivolto a lui per ottenere un colloquio risanatore nelle alte sfere della Chiesa. Era amareggiato per la violenta campagna clericale contro il suo film e la sua persona, culminata nei manifesti a lutto affissi nella diocesi di Padova in cui si invitava a “pregare per il pubblico peccatore Federico Fellini”. A Rimini, assistendo alla messa nella propria parrocchia dei Santi Bartolomeo e Marino, la madre Ida era stata costretta ad abbandonare in lacrime la cerimonia a causa delle dure parole che, durante la predica, il parroco aveva lanciato come folgori contro quel figlio scellerato.
Fellini, tramite padre Arpa, aveva ottenuto un’udienza presso il cardinale Giovanni Montini; si era recato a Milano, all’arcivescovato, e insieme all’amico sacerdote aveva atteso a lungo seduto sulle panche nell’attesa vana di essere ricevuto. Poi raccontò: «Dopo alcune ore Montini passò rapidamente in corridoio, mi rivolse uno sguardo gelido che aveva i bagliori dell’acciaio, e sussurrò: “Pregherò per lei”, dileguandosi in fretta e senza permettermi si pronunciare una sola parola in difesa del mio film.»
Singolari contraddizioni venivano alla luce all’interno degli stessi esponenti dell’ortodossia. Con l’ala più reazionaria e retriva dei cattolici si era schierato l’arcivescovo lombardo, di Concesio, considerato al tempo l’esponente progressista e illuminato della Chiesa. Il capo dell’episcopato milanese aveva infatti scritto in un impeto di rigetto:
“Un film di tale immoralità e di tale cattivo esempio della depravazione umana, che ci vorrebbe qualche intervento dell’autorità ecclesiastica per farlo togliere dagli schermi.”
Di lì a tre anni sarebbe stato eletto Pontefice con il nome di Paolo VI.
In controtendenza il cardinale Giuseppe Siri di Genova, che rappresentava l’ala oscurantista del clero, e nondimeno aveva già salvato dal rogo La notti di Cabiria, mostrava un’apertura moderna e consapevole nei confronti dell’artista che, con la sua opera, affrescava uno scenario ‘scandaloso’ ma denso di verità e utile alla riflessione morale. Sul Giornale di Genova era apparso un articolo di piena assoluzione da lui ispirato o forse scritto di sua mano:
“Il film è veritiero, ed è perché colpisce orribilmente la vita di molti, che taluni hanno reagito anche sulla stampa: vi si sono visti descritti ed hanno avuto paura di sé stessi.”
Un’analisi perspicace dell’opera cinematografica, e inoltre dall’imprevisto taglio psicanalitico.
Vero è che dietro Giuseppe Siri c’era pur sempre Padre Arpa, che infatti i malevoli un po’ burloni’, parodiando il titolo di un celebre film dell’epoca, avevano ribattezzato: L’ARPA SIRIANA.
Arpa era un autentico religioso ma anche un uomo libero, che contribuì con il suo pensiero e la sua costante, generosa testimonianza di fede e di rigore culturale a rendere migliore il nostro Paese. Personaggio un po’ fatato e persino letterario, amò profondamente il cinema come arte eccezionalmente capace di avvicinare i popoli e le anime. Negli anni Cinquanta aveva fondato e animato in Liguria i primi cineforum d’Italia, e nelle ultime stagioni di vita si dedicò a una “Fondazione Europa” concepita per aggregare tutti gli stati dell’Unione attorno a un progetto culturale unico e riconoscibile.
Era nato il primo giorno di primavera, Padre Angelo Arpa, e aveva speso i suoi 94 anni interamente nella causa del cinema, oltre che nella pratica di un sacerdozio a immagine di Gesù.
Poco prima della sua scomparsa gli era stato assegnato il vitalizio della Legge Bacchelli, a integrazione di una modestissima pensione che negli ultimi anni non gli aveva consentito neppure di continuare a soggiornare nella Casa del Clero di via Traspontina; da decenni un punto di riferimento per chiunque – ed erano davvero in tanti – fosse in cerca di un aiuto nella sua inesausta disponibilità, un conforto nel suo sorriso accogliente.
Roberto Rossellini, Pier Paolo Pasolini, si pregiavano della sua amicizia, ricorrevano ai suoi consigli per capolavori entrati nella Storia del Cinema. Sciami di ragazzi, da tutta Italia, passavano a trovarlo per una parola di incoraggiamento, di sostegno alle loro turbolente aspirazioni artistiche, ai loro impazienti progetti.
I confratelli della Casa del Clero, frequentata da sacerdoti di tutto il mondo, lo onoravano come un archimandrita, affidandogli in confessione le loro debolezze e inchinandosi alla sua assoluzione in nome di quell’Amore che “non bada tanto a quello che facciamo ma a ciò che siamo, perché Dio non ama intrufolarsi fra le lenzuola, ma nel cuore dell’uomo”.
Così continuava a ripetere padre Arpa, delicatamente ma a volte sarcasticamente polemico nei confronti di quella Chiesa che troppo a lungo aveva avvilito il proprio insegnamento alla repressione del peccato della carne, la più naturale e inoffensiva manifestazione dell’istinto umano.
Dal letto d’ospedale, dove da ultimo era ricoverato, Arpa non si stancava mai di ricevere gli amici, con immutata serenità e scintillio di pensiero, in attesa dell’ultima chiamata. Parlava di Papa Woytila con accenti di devota ammirazione; e della Compagnia di Gesù come della sua unica vera famiglia, con un fiero sentimento di appartenenza che non conobbe incertezze.
I giovani della “Fondazione Europa”, – l’ultimo istituto da lui creato per raccontare nel cinema le radici religiose del Vecchio Continente, e parallelamente la Storia del Papato – andavano a trovarlo a turno. Con loro Padre Arpa si abbandonava talvolta ai ricordi, intercalando qualche parola in veneto, la sua terra d’origine. La famiglia di Angelo proveniva da Castelfranco, ma suo nonno Arpad era arrivato dalle steppe ungheresi, lasciandogli in eredità un cognome italianizzato nel più scenografico degli strumenti musicali, e una pericolosa inclinazione alle voci di dentro: l’arte, la religione, la indecifrabile avventura umana.
Primo tra sette sorelle e fratelli di una famiglia contadina educata al rispetto del sacro, Angelo era stato sfiorato dalla Grazia fin da bambino, quando servendo messa era svenuto ai piedi dell’altare perché gli era apparsa la Vergine Maria. Un colloquio ultrafanico del quale non aveva mai voluto rivelare i particolari, ma che l’aveva indotto ancora ragazzo ad abbandonare gli studi musicali, ai quali era prodigiosamente inclinato, per abbracciare il sacerdozio. I superiori, riconoscendone la precoce brillantezza e profondità d’ingegno, lo avevano avviato alla Compagnia di Gesù, presagendo per lui un apostolato nel mondo della cultura. Come avvenne, con un’impronta originale che resterà a lungo nelle sue opere e nel ricordo di chi l’ha incontrato.
Era familiarmente conosciuto come il prete de La Dolce Vita, una definizione alla quale si era alla fine rassegnato: “Così ormai sono noto a tutti, – bisbigliava in un guizzo di ironia – ma senza colpa.”
Accomunati nel capace alveo felliniano, con Angelo Arpa non ci siamo persi mai di vista; appena un anno prima del suo congedo avevamo partecipato insieme a un omaggio a lui dedicato da Lorenzo Codelli presso la splendida e meritoria Cineteca di Gemona in Friuli.
Dopo un’intera esistenza trascorsa nella Residenza del Clero a Porta Castello, quando le condizioni di salute si erano aggravate, Angelo era stato trasferito in un ricovero ecclesiastico per lungodegenti, e in ospedale aveva terminato i suoi giorni. Accanto al suo letto, appoggiate sulla stretta soglia della finestra, c’erano tre fotografie a portata dei suoi occhi: la madre, Fellini e lui stesso.
In un gruppo di amici, andammo a trovarlo insieme a Padre Michele Lavra, che al tempo era Prefetto della Compagnia di Gesù per l’Italia Centrale, oltre che Superiore della Casa Madre, la dimora in cui era vissuto a Roma Sant’Ignazio di Loyola.
Angelo era in coma, sembrava una statua di cera. Facemmo corona intorno al letto, qualcuno cercò di parlargli, di accarezzargli una mano, ma non c’erano reazioni. Padre Lavra aveva un’impellente notizia da comunicargli, era riuscito finalmente a ottenere per lui la riammissione nell’Ordine da cui era stato allontanato decenni prima. Ma le sue parole infervorate non trovavano ascolto. Si accostò un medico che spiegò a tutti noi con sollecita partecipazione: “Il paziente non può sentirvi perché è ormai sceso al terzo stadio di coma, uno dei più profondi. Per sperare di raggiungerlo è necessario che vi rivolgiate a lui alzando molto la voce, se necessario gridando”. E scivolò via.
Padre Lavra si fece animo e ricominciò a urlargli vicino all’orecchio: “Angeloooo! Torni a casa!”
E la vastissima camerata, vuota, risuonava amplificando le sue frasi.
“Angelooooo!!!! – ripeteva a pieni polmoni – Sei di nuovo a casa, nella tua casa! Sei contento!?”.
Ero in fondo al letto, quasi appoggiato alla pediera, e fissavo in viso il sacerdote morente. Dopo alcuni tentativi del più giovane confratello di richiamarlo in superficie, sulla sua maschera di alabastro comparve l’ombra sfumata di un sorriso, appena un barlume, un nimbo di luce che subito si spense. Quasi senza accorgermi mi ritrovai in ginocchio, sopraffatto dalla commozione di fronte a quella tenue traccia di coscienza che ci aveva raggiunto all’improvviso, prova tangibile del contatto con il mistero da cui eravamo avvolti: la sacralità della vita e della morte, della sparizione e dello spirito eterno, dell’errare alla cieca e dell’abbagliante inesorabile meta.
Molti anni prima, in un momento di profonda crisi personale, ero rimasto folgorato da una ammonizione con cui Angelo mi aveva investito senza accomodanti perifrasi, e che da allora non ha smesso di accompagnarmi: “Nella vita non c’è garanzia”.
Tutto mi parve chiaro: nella vita quel poco o tanto che crediamo, anzi pretendiamo di possedere immutabilmente, può svanire in un soffio. Nulla ci appartiene, di nulla siamo padroni: “Nessuna garanzia”.
Da Angelo ebbi in dono il presidio più prezioso.
Padre Arpa è stato sepolto nel cimitero monumentale del Verano, a San Lorenzo, nella Tomba Generalizia dei Gesuiti. In basso a sinistra, entrando, c’è il suo loculo: sulla lastra di marmo soltanto il suo nome, una piccola croce di bronzo e la data della sua morte; perché per i Gesuiti, e per ogni credente, essa rappresenta il giorno della vera nascita.