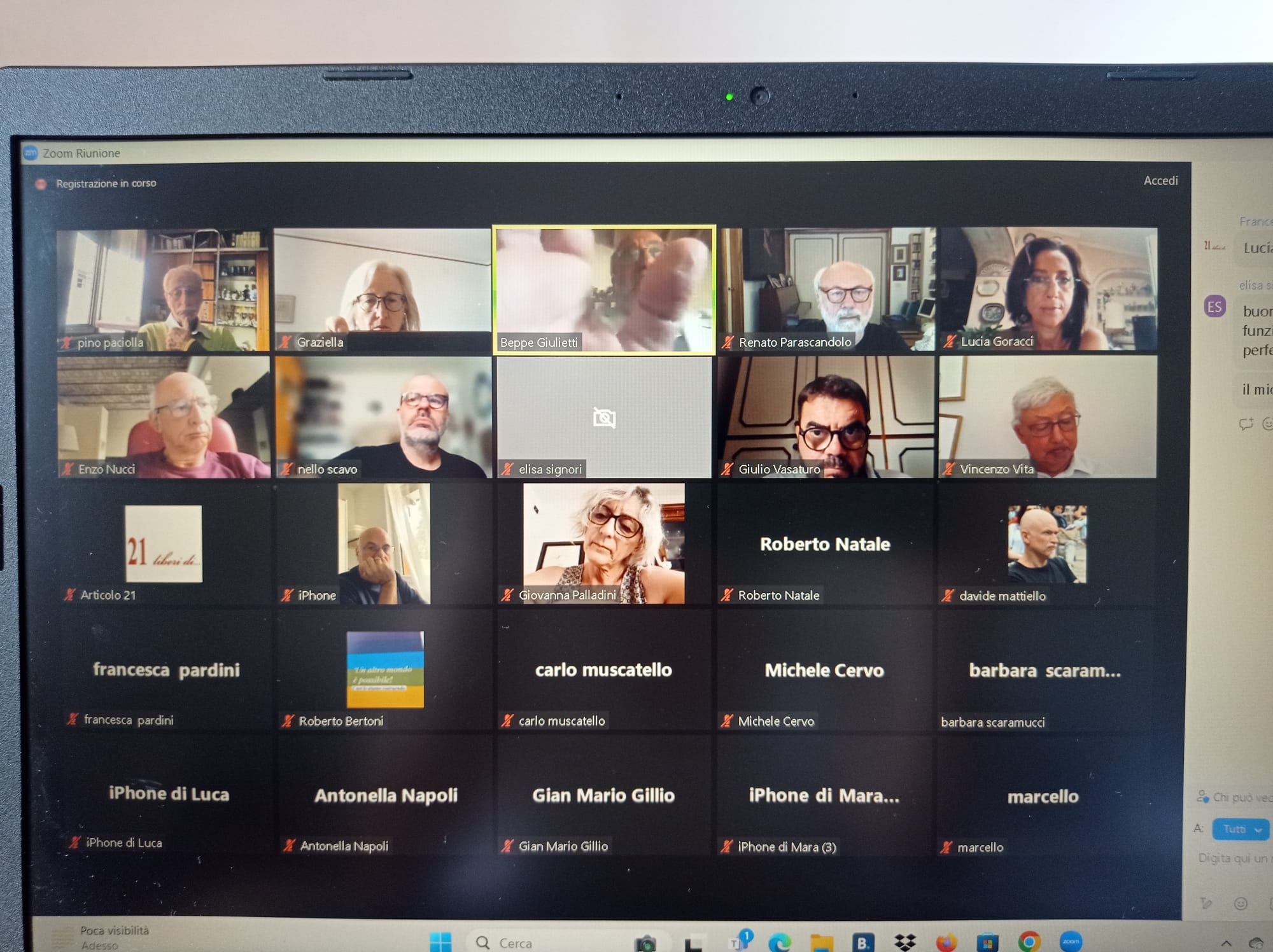Lo scorso 14 agosto la polizia del Regno Unito ha arrestato Richard Medhurst, giornalista indipendente nato in Siria e di nazionalità britannica, in base alla legge sul Terrorism Act. L’accusa si basa sulle denunce attraverso Youtube dei crimini di Israele a Gaza.
Vicende come questa non vanno considerate una mera patologia repressiva. Il caso di Julian Assange, pur conclusosi con un mezzo lieto fine, dovrebbe averci ammonito che chi fa cronaca e inchieste senza remore o timidezze e mette il naso nelle cose segrete delle guerre rischia. Tanto. Sembra, anzi, che proprio l’eccidio in corso a Gaza abbia addomesticato il concetto di omicidio, di cui si parla come di un normale accidente del destino. Naturalmente, migliaia di vittime in quella parte del mondo considerata minore e lontana dai luoghi importanti valgono poco. Quante centinaia se ne devono contare per eguagliare l’intensità politica ed emozionale di una vittima bianca occidentale? Tanti anni or sono un celebre testo di teoria delle comunicazioni di massa di Mauro Wolf scriveva di un rapporto di 300 a 1. Ora pare che la proporzione sia assai superiore. Oltre quarantamila sono i palestinesi che hanno perso la vita a Gaza, e tra questi (secondo fonti recenti) circa 170 giornaliste e giornalisti defunti per mano dell’esercito israeliano, con una spietatezza davvero inedita.
Tra l’altro, l’accesso a Gaza è interdetto ai reporter internazionali, perché non si permette che si conoscano attraverso occhi estranei le atrocità in corso. Coloro che stanno dentro la Striscia, per lo più palestinesi, sono quotidianamente nel mirino e le testate estere non possono passare il varco di Rafah. Malgrado l’intervento delle organizzazioni internazionali di categoria e diversi appelli la situazione è bloccata. Almeno un’indagine andrebbe svolta, per fornire un quadro adeguato di un vero e proprio genocidio. La segretezza è parte integrante del massacro e guai ad uscire dall’informazione per forza di cose costretta e -quindi- paludata, non per colpa di chi con coraggio è lì ma con i vincoli posti dalle truppe di occupazione.
Ne hanno parlato lunedì 19 agosto nel forum settimanale dell’associazione Articolo21 Lucia Goracci e Nello Scavo, da anni impegnati nel racconto sui e nei teatri di guerra. Si vuole impedire di narrare ciò che avviene e si cerca di screditare i giornalisti palestinesi, trattati alla stregua di terroristi pericolosi. Un allarme è stato lanciato e gli appelli ricominciano a trovare adesioni. Indubbiamente, invece, è assai differente l’avventura di Stefania Battisti e Simone Traini della Rai, curiosamente richiamati in Italia da un vertice aziendale alquanto fragile: oggi qua, domani là. Contro gli attacchi dell’autoritarismo russo durissimo verso le libertà si è sollevata giustamente la protesta delle organizzazioni sindacali italiane e non solo. Tuttavia, senza nulla togliere all’impegno di chi ha provato a narrare la contro-invasione ucraina, siamo di fronte a un caso ben dissimile dalla tragedia di Gaza, trattandosi di inviati embedded. Nulla da eccepire: in certi territori o si accetta simile limitazione o non ci si muove.
Va sottolineata, però, l’asimmetria negli atteggiamenti istituzionali: notizione contro notiziole, difese appassionate e cenni fugaci. Gli schieramenti geopolitici determinano il resto, come si vede. Eppure, la Rai creò problemi al proprio corrispondente a Mosca Marc Innaro, che osò non seguire il pensiero unico diventato una giaculatoria inneggiante alla Nato. I due cronisti Andrea Sceresini e Alfredo Bosco, da tempo attivi in quel teatro, si videro rifiutata l’autorizzazione delle autorità ucraine a rimanere. Censura preventiva.
Insomma, lungi da qui ogni (impossibile) simpatia putiniana – basti rileggere qualche scritto di Rossana Rossanda pubblicato nello speciale del manifesto – è bene urlare la verità: il diritto ad informare e ad essere informati è tra i primi bersagli delle guerre.
(Nella foto la riunione di Articolo 21 sul racconto difficile della guerra Gaza)