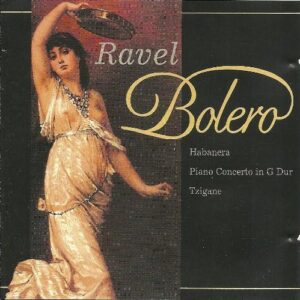A sfogliare le storie della musica, che dal dopoguerra si sono moltiplicate, si resta delusi sul senso del Bolero di Ravel: nessuno sa svelarne il segreto, perché un’opera così strana deve avere un segreto. Era stata Ida Rubinstein a commissionare ciò che la danzatrice presentò al pubblico dell’Opéra di Parigi il 20 novembre 1928, con la coreografia di Bronislava Nijinska, sorella di Vaslav. In platea, di fianco a Ravel, sedeva una signora che per tutto il tempo rimase avvinghiata alla poltrona borbottando che l’autore di «quella cosa» era senza dubbio un pazzo. Ravel non osò svelare che il pazzo era lui, e le dette ragione. Eppure, chiacchierando tempo dopo con Arthur Honegger, confessò di aver composto un solo capolavoro, Bolero, e che questo non conteneva musica. Perché allora la signora all’Opéra era rimasta turbata? Ascoltiamolo dallo stesso Ravel: «È una danza in movimento moderatissimo e costantemente uniforme, tanto nell’armonia quanto nel ritmo, quest’ultimo scandito senza tregua dal tamburo. Il solo elemento di diversità è fornito dal crescendo orchestrale».
Ravel dubitava che un’opera fuori dalle regole della classicità potesse avere successo. Ma fu proprio ciò che capitò grazie a due sole idee melodiche che si rivestono di ogni timbro orchestrale e grazie a un’accumulazione strumentale che ipnotizza l’ascoltatore fino al conclusivo parossismo degli ottoni. Ascoltando Bolero ci si chiede da cosa scaturisca la sua carica di moderna follia: dall’intima geometria cubista? Dal fatto che suona come un gesto malandrino, la rottura di un lampione? O forse perché vagamente soddisfa una certa morbosità “iberica”?
Tante le ipotesi, tra cui la mia (peraltro non isolata): Bolero descrive semplicemente la consumazione di una carica erotica. L’esile compositore s’era trasformato d’un tratto nel vettore di una semplicità esplosiva, di una musica ambigua e incantatoria, che invita a calarsi in sensazioni primordiali. Ma cosa descrive per l’esattezza Bolero nella geografia dell’erotico? Forse il coraggio di esprimerlo l’ha avuto solo il regista di quel filmetto d’evasione che alla fine degli anni Settanta circolava col titolo “Hai mai provato col Bolero?”. Già, se viviamo la fase della stanchezza erotica, perché non provare col Bolero?
 Sorprendente esempio di poetica dell’akmé, la musica si gonfia per apposizione successiva di legni e ottoni ma resta ostinata sul Do maggiore. Cresce fino a raggiungere un livello molto alto, e non le basta: si fa invadente e strombazzante, fino a toccare l’apice dell’energia. In quel punto c’è una violenta modulazione sul Mi maggiore e una rapida caduta sul Do: l’evento finale è il risultato d’una crescita ritmicamente ossessiva.
Sorprendente esempio di poetica dell’akmé, la musica si gonfia per apposizione successiva di legni e ottoni ma resta ostinata sul Do maggiore. Cresce fino a raggiungere un livello molto alto, e non le basta: si fa invadente e strombazzante, fino a toccare l’apice dell’energia. In quel punto c’è una violenta modulazione sul Mi maggiore e una rapida caduta sul Do: l’evento finale è il risultato d’una crescita ritmicamente ossessiva.
L’arcano è risolto: Bolero mette in musica un rapporto sessuale concluso da un ansimante orgasmo. Non basta: raggiunto l’acme, non segue alcuna discesa. Nel Bolero non è soddisfatta la norma che l’apice debba collocarsi verso il centro, per lasciare poi lo spazio a una “crisi”: no, qui tutto è incremento, oliato meccanismo che porta verso un’eccitazione panica. Abbandoniamo ogni puritanesimo e andiamo oltre: se di accoppiamento si tratta, Bolero simbolizza la crescita verso l’orgasmo e nulla più. Avendo rinunciato alla finale caduta, Ravel esprime un preciso modulo di eros: un accoppiamento in crescendo del quale non fa parte il tedium, l’insofferenza successiva al piacere.
Tutto si svolge secondo un ordine naturalissimo, e forse perciò il risultato è così moderno: pur essendo il motivo di Bolero sempre uguale e reiterato, non è mai stucchevole. Proprio come nell’amore fisico, dove la meccanicità muscolare non è noiosa, e suggerisce una sorta di ritmo cosmico. Non a caso Ravel, per evitare un erotismo superfluo, sostituisce alla piena libertà della musica una misura, disegna un impulso orientato, e dona all’insieme la bellezza di un ordine: scelse insomma per Ida Rubinstein l’erotismo, ma aggiunse che la radice del piacere è nel ritmo misurato. Ciò che nacque – Bolero appunto – non è che una straordinaria alchimia di regola e istinto.