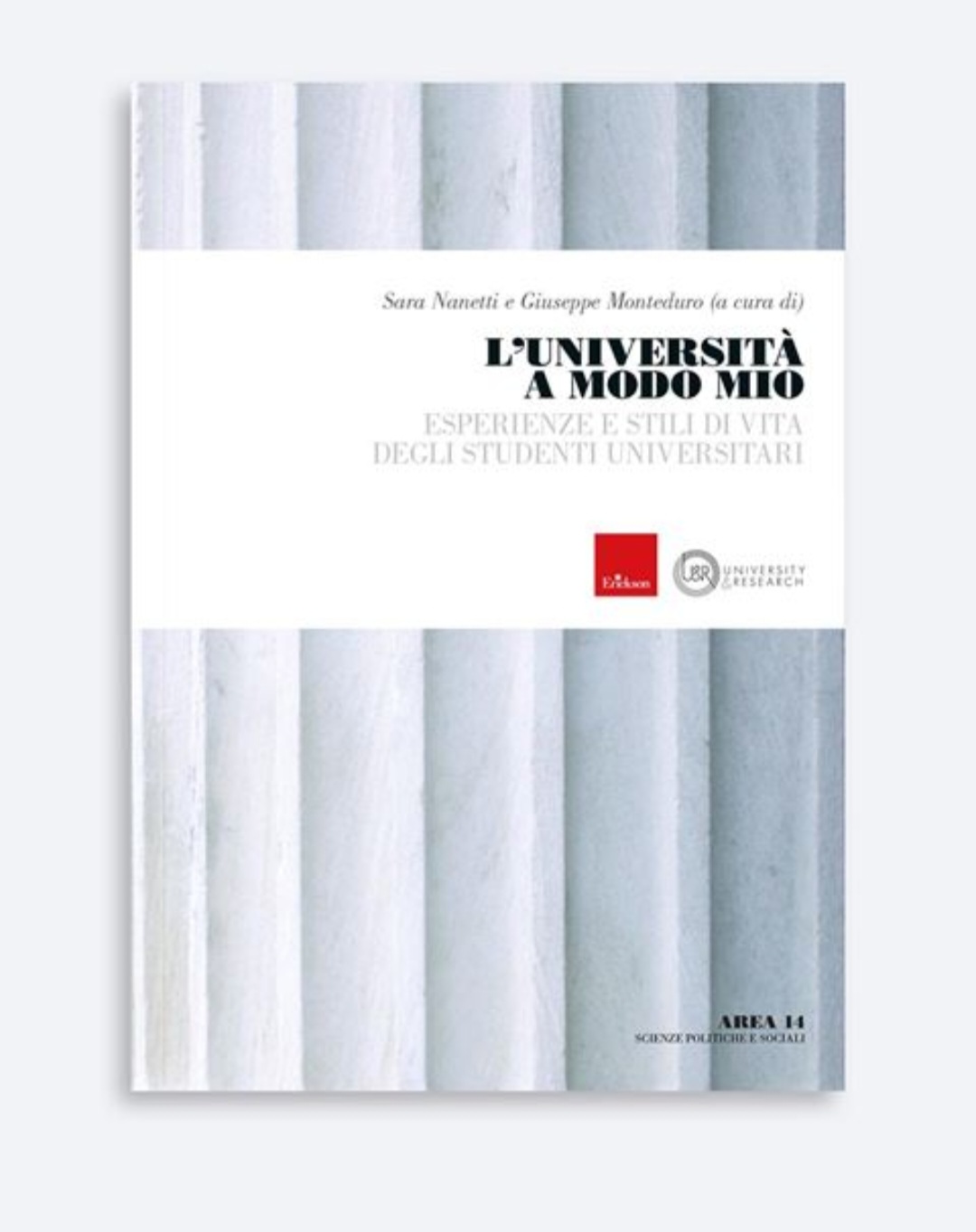L’approccio dei giovani rispetto all’emergenza Covid-19 è stato, ed è, un nodo-chiave per capire l’impatto della malattia, le sue conseguenze e le sue implicazioni mediche, economiche e sociali anche nel medio-lungo termine. La pandemia, per le nuove generazioni, non è stata solo la minaccia alla salute, ma anche una chiamata importante a un senso condiviso di responsabilità.
In grande prevalenza giovani, gli studenti universitari rappresentano la futura classe dirigente e la “prima linea” sul fronte del progresso. Sono giovani impegnati nello studio e nella ricerca, cioè in quegli ambiti che hanno fatto i conti con la pandemia e che dovranno affrontarne le conseguenze nel tempo, misurandosi con il rischio di nuove possibili emergenze sanitarie, ora una ipotesi non più tanto remota e astratta.
Per Messa, la società si adatta e cambia con efficacia se l’università riesce ad avere un ruolo guida, e se di questa duttilità sa esserne consapevole interprete.
Tornare indietro al periodo pre-Covid non è un’opzione tanto semplice: alcune delle opportunità/vincoli vissute in pandemia ci accompagneranno ancora. Soprattutto daranno, o hanno dato, forma a nuove radicate abitudini mentali. Per esempio, immaginare di non poter partecipare a una riunione collegandosi da casa sarà quantomeno visto come “fuori tempo”.
L’università chiusa, o meglio l’università anche digitale non è stata per tutti un danno o per tutti un beneficio. Per certo però, durante i due anni di lockdown alternato, la frequenza alle lezioni è andata aumentando in proporzione significativa.
Ne hanno giovato gli studenti lavoratori e quelli economicamente più fragili, i fuori sede e quelli con vari carichi di impegno. Ma l’università non è solo luogo del sapere scientifico, è anche un luogo di formazione delle coscienze individuali e collettive.
La società civile deve molto a chi afferisce al mondo universitario perché in esso gli individui interagiscono condividendo idee, progetti, speranze e orizzonti valoriali comuni o in costruzione comune.
È doveroso, sottolineano gli autori, riflettere sul concetto di parità di condizioni per l’accesso al diritto allo studio. Mentre il diritto allo studio tradizionale si pone l’obiettivo di permettere a un numero più ampio di persone di essere uguali all’interno del sistema universitario, la didattica a distanza prelude alla creazione di un doppio sistema, in realtà fortemente classista, in cui gli spazi universitari – di crescita umana e sociale, oltre che professionale – il rapporto con i colleghi e con i docenti e la vita delle città universitarie sarebbero riservati solo a chi può permettersi le spese per frequentare in presenza.
Lo scopo è quello di allargare la concettualizzazione del diritto allo studio per garantire l’accesso all’università in termini di sostegno economico e anche nei termini di accessibilità tout court.
Per Chiapparino, si tratta di valutare e costruire una rete di trasporti locali adeguata e funzionale, di riconoscere i carichi di cura degli studenti che hanno responsabilità come caregiver famigliari, e di offrire servizi bibliotecari/spazi di studio che siano funzionali agli orari didattici e alle esigenze degli studenti.
Il tutto nell’ottica di ridurre il divario che separa l’Italia dal resto d’Europa, che vede la prima con una percentuale di laureati ferma a quota 28 contro la media europea che sfonda la soglia del 40.
L’università a modo mio è un’opera collettiva che mira a dare uno sguardo panoramico della condizione degli studenti universitari italiani anche oltre l’emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19. Un lavoro destinato e programmato per continuare, con l’intento di monitorare l’andamento della situazione. Una ricerca davvero interessante che invita alla riflessione sul mondo universitario e sui giovani che lo animano.
Il libro
Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro (a cura di), L’università a modo mio. Esperienze e stili di vita degli studenti universitari, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2022.
Prefazione di Maria Cristina Messa (già Ministro dell’Università e della ricerca).
Postfazione di Luigi Leone Chiapparino (Presidente del Consiglio Nazionale Studenti Universitari – CNSU).
Gli autori
Sara Nanetti e Giuseppe Monteduro (curatori), Michele Bertani, Matteo Moscatelli, Daria Panebianco, Livia Petti, Davide Ruggeri.