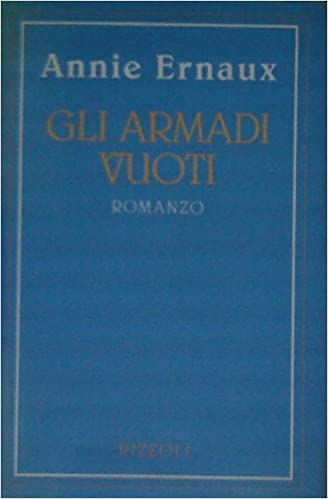Annie Ernaux racconta sempre e soltanto di sé, inesorabilmente di sé, ma i suoi sono veri romanzi, come accade con la maggior parte dei grandi scrittori. Titolo dopo titolo lei si mette allo scoperto senza riguardi, si espone senza alcun diaframma, passando dall’infanzia alla prima giovinezza, alla maturità, e all’età matura, nella quale finalmente la sua onestà, questa sua spietata sincerità, questo stile diretto e privo di fronzoli, le viene riconosciuto come merito di eccellenza dall’Accademia di Svezia. È stata lei la prescelta per il Premio Nobel in questo nostro fatidico 2022. Chissà se in segreto l’aveva mai sognato, se l’aveva mai sperato.
Sono andato a recuperare dallo scaffale degli autori stranieri il suo primo romanzo affondato nella memoria, Gli armadi vuoti, che risale al 1974, Edizioni Gallimard, stampato in Italia da Rizzoli nel 1996. Ero troppo curioso di scoprire l’impressione che mi avrebbe suscitato. L’ho iniziato senza riuscire più a staccarmi, lei non stava scrivendo, stava parlando con me, a tu per tu, senza alcuna reticenza, senza nessuna vergogna. “Senza vergogna non c’è letteratura” si è soliti affermare.
Nel romanzo Annie racconta dolorosamente la sua infanzia, la sua crescita faticosa, spinosa, fino all’episodio che ne condizionerà per sempre la vita, l’aborto clandestino a cui è costretta a sottoporsi a vent’anni; quando in Francia, come del resto in Italia, due paesi formalmente di stretta confessione cattolica, la pratica era un reato contro Dio e contro la legge. Quindi contava poco se la ragazza sotto i ferri perdesse la vita per setticemia o dissanguamento. Se l’era cercata, colpa sua, non delle mammane.
Ernaux nasce nel 1940, il 1° settembre sotto il segno della Vergine, quando il Sessantotto benché alle porte era ancora da venire, trascinato presto dal vento impetuoso del boom economico, dell’edonismo, della inarrestabile società dei consumi, del neopaganesimo in cui i bisogni superflui avrebbero spodestato quelli elementari, dopo troppi secoli governati dai santi della penitenza.
Annie non ha altra scelta e si fa strappare dalle viscere la sua creatura; ma ci arriveremo a quel bagno di sangue che non lascia scampo al lettore e che lei ci annuncia così:
“Tutto è cominciato con una frase nemmeno divertente, e poi mi sono trovata coinvolta fino in fondo, fino alla sonda che mi sono fatta infilare, tutto per colpa mia. Inferiore, certamente, mi sentivo inferiore. La prova è che ero entusiasta anche solo di andare a bere qualcosa con lui al caffè della stazione. Di andare a ballare in un locale simpatico. Un moccioso di lusso, di quelli che hanno l’ombrello nero, la ventiquattrore di cuoio e la cravatta tipo vecchia tappezzeria. La parlantina, il bel parlare, ne sono stata sempre attratta”.
Prima c’è l’infanzia in un piccolo borgo della Normandia dove i suoi gestiscono il misero bar-drogheria Lesur. Il padre è l’oste che serve il vino a ubriaconi, vecchietti viziosi, derelitti che lasciano a tarda sera il locale fumoso vacillando sulle gambe; la madre vende in bottega ai clienti che appartengono alla loro infima classe sociale, in cui si parla solo il dialetto e le spese vengono segnate sul quaderno in attesa della paga settimanale. Il destino della bambina sembra già segnato, finire le scuole elementari e andare a lavorare in fabbrica, come le sue coetanee; o in alternativa restare tutta la vita a versare vino, come i suoi genitori rozzi e sguaiati: “Ho avuto una paura folle di essere simile a loro”.
Per fortuna è intelligentissima, apprende come una spugna, impara senza fatica, tutti dieci a scuola, è sempre la prima della classe, pur nel costante sprezzo delle compagne più evolute; lei resta pur sempre la figlia dell’oste e per strada non la salutano nemmeno. I genitori capiscono confusamente che la bambina deve andare avanti negli studi, ne vantano i successi tra i parenti, vagheggiano per Annie un avvenire meno squallido, mettono da parte l’avarizia dei bottegai e le comprano libri su libri all’edicola del paese. Annie non fa altro che leggere, non possiede giochi, non ha fratelli, vive con irrequietezza l’ambiente sordido in cui trascorre giornate vuote, sempre uguali; per appoggiare sul tavolo da cucina il libro di studio, deve sistemare un foglio di giornale, tanto è lorda di grasso appiccicoso la tela cerata che lo ricopre. Detesta la sua abitazione, vorrebbe assomigliare alle “compagne che vivevano in un mondo più bello, più puro, più ricco del mio”. Gli insegnanti ne tessono sinceramente le lodi, con distacco. Più progredisce la sua istruzione, più in lei aumenta il senso di ripugnanza verso il padre e la madre, e la sub umanità che affolla l’osteria; nei fumi dell’alcol qualcuno comincia già a metterle gli occhi addosso, a valutarne la crescita con battute odiose, ad allungare le mani. Presto iniziano i primi turbamenti, le pulsioni ignote, le allusioni sconce dei maschi, le oscenità dell’abbietto confessore: “Ne sono uscita sporca e sola. Ero solo io a infilarmi il dito nel sesso e a guardarmi nello specchio, solo io che immaginavo di fare pipì davanti a tutti”.
Poi i primi incontri segreti con i compagni che le piacciono, le liti furiose con i genitori, la smania di libertà, di affrancamento, l’ansia di lasciare quel mondo di oscura provincia, chiuso e irrespirabile, e correre incontro alla vita. Quale? Non lo sa, nessuno può saperlo, meno che mai in quell’età ingrata. E Annie rimane incinta, quando frequenta già l’università, a Rouen.
Il resto lo apprenderà il lettore da una scrittura di spietata crudezza, i dettagli di una via crucis che tante ragazze hanno dovuto affrontare in tempi in cui non esistevano presidi di alcun genere, e una ragazza incinta era solo una puttana, una donna perduta, abbandonata dalla famiglia, dagli amici, dalla chiesa, dai medici che addirittura ne tradiscono la fiducia con ignobili raggiri, o chiedono cifre da ricatto. I famosi “cucchiai d’oro, che si arricchiscono illegalmente.
Quante donne ricordano oggi quei tempi sciagurati, in cui a Roma non esisteva neppure il consultorio dell’Aied, in via Gorizia, presso cui cercare un aiuto disperato, e si finiva nei tuguri delle mammane munite di ferri da calza o di qualche altro raccapricciante strumento di macelleria. Distese sul tavolo di cucina, con i soldi in mano prestati da un’anima caritatevole, perché se qualcosa andava storto – la perdita di coscienza o peggio la morte della sventurata di turno – le “fabbricatrici di angeli” nulla avessero a rischiare sul proprio compenso.
Ma non voglio insistere su questo orrore, a cui l’autrice dedicherà un libro a parte intitolato L’evento, uscito in Italia nel 2019, a quarant’anni dall’accaduto, e tradotto come quasi tutta l’opera della Ernaux dal medesimo editore Lorenzo Flabbi. Quasi in ogni libro la scrittrice ne fa riferimento specifico o indiretto, per accenni o ulteriori digressioni. È come un chiodo nella testa, un marchio che non riesce o non intende cancellare.
L’evento, sia pure così tragico, è solo l’ultimo passo di un affrancamento e parallelamente anche la rivelazione di una vocazione, di una missione, che la scrittrice avverte imprescindibile: “Forse il vero scopo della mia vita è soltanto questo: che il mio corpo, le mie sensazioni e i miei pensieri diventino scrittura”.
Scrivere sempre, a ogni costo, scrivere la vita, scrivere La vergogna (altro titolo di un suo libro), scrivere Gli armadi vuoti, cioè sottoporsi a quell’azione inevitabile tormentosa e amara di svuotare gli armadi da tutto ciò che contengono, rovistare in ogni angolo buio, anche tra le supposte nefandezze, da riportare alla luce per sconfiggere il loro potere occulto. Uno scrittore, che pretenda di essere tale, mai si spoglierà di un simile compito, fino al punto di concepire la vita stessa come lo sviluppo di una narrazione che non si può eludere.
Sono indispensabili i libri della Ernaux, tutte le donne dovrebbero leggerli, ogni individuo umano dovrebbe farlo. In Passione Semplice, appena riuscito nella BUR, la scrittrice racconta il suo innamoramento in età più che adulta – i due figli sono già all’università – per un uomo che quasi non conosce, viene dall’est Europa, e quando capita in Francia passa da lei per una notte d’amore. “Non avevo altro avvenire che la prossima telefonata per l’appuntamento”. In attesa della quale l’intera esistenza della protagonista si sospende, incapace di pensare ad altro:
“Ho misurato il tempo con il mio corpo. Ho scoperto di cosa si può essere capaci, cioè di tutto”.
O ancora: “Subito dopo la sua partenza, un’immensa spossatezza mi pietrificava. Non riordinavo immediatamente. Contemplavo i bicchieri, i piatti con i resti, il portacenere pieno, gli abiti, i capi di biancheria sparpagliati nel corridoio, la camera, le lenzuola penzoloni sulla moquette (…) Naturalmente non mi lavavo fino al giorno successivo, per serbare il suo sperma”.
Quest’anno quasi in sincronia con l’assegnazione del Nobel, è arrivato in libreria Il ragazzo, un elegante libricino tascabile di poche pagine, che si beve in un sorso, in cui la scrittrice ci mette al corrente del suo amore, ormai alla soglia dei sessanta, con uno studente universitario di trent’anni più giovane. Il libro inizia così:
“Cinque anni fa ho passato una notte impacciata con uno studente che mi scriveva da un anno e aveva voluto incontrarmi.”
“Voleva fare un figlio con me. Un desiderio che mi turbava, e percepivo come un’ingiustizia profonda il fatto di essere in piena forma e non poter più concepire”.
“Sotto molti aspetti – la letteratura, il teatro, le abitudini borghesi – ero la sua iniziatrice, ma ciò che mi faceva vivere lui era a sua volta un’esperienza iniziatica. La principale ragione per cui volevo continuare quella storia era che, in un certo senso, aveva già avuto luogo, che ne ero il personaggio fittizio.”
Narrando la scrittrice non fa segreto della disuguaglianza, dello stridore, dello scandalo che accompagna quel suo rapporto per gli altri indecente; lei annota ogni sensazione con tagliente lucidità, sa di star infrangendo le regole – ma quali regole, chi le ha scritte? – e che ne pagherà in qualche modo le conseguenze. Ma ciò che scrive in proposito, con una confessione incontrastabile, disarma all’istante ogni commento fuori luogo:
“Spesso ho fatto l’amore per obbligarmi a scrivere. Volevo trovare nella fatica, nella derelizione che ne segue, delle ragioni per non aspettare più niente dalla vita. Speravo che la fine dell’attesa più violenta che ci sia, l’attesa di godere, mi facesse provare la certezza che non esiste piacere superiore a quello della scrittura di un libro.”
C’è molto dolore tra le righe della Ernaux, ma è sempre un dolore di vita, la sofferenza di un parto, senza il quale non esiste alcuna nascita, nessuna espressione artistica. Scrivere è un dono di Dio, ma dentro c’è pur sempre anche lo zampino del demonio. La cacciata dall’Eden.
L’ultimo libro, appena rieditato, si chiama Gli anni, una galoppata vertiginosa attraverso mezzo secolo di cambiamenti sociali ancora più vertiginosi, in cui come in una moviola impazzita ci viene ripresentato davanti agli occhi, a doppia velocità, tutto ciò che è accaduto in questo arco di tempo, le vicende e le trasformazioni che ci hanno condotto alla nostra era, ancora magmatica e ingovernabile. Nella quale ci attende un futuro nel metaverso, cioè in un universo incorporeo, parallelo e digitale, quando non abbiamo ancora avuto il tempo di smaltire la sbornia di una libertà che si sta rapidamente sfigurando in una nuova tirannia di cui non scorgiamo strumenti e intenzioni. Ripercorrere attraverso l’intelligenza della scrittrice ciò che ci è accaduto negli ultimi sei o sette decenni facendoci capitombolare nel nuovo millennio, è un paracadute a cui tenersi afferrati con ambo le mani. Teniamo accanto a noi questi libri, sul comodino, sono un poderoso ricostituente, meglio dell’olio di fegato di merluzzo. Prima ancora delle leggi, è la letteratura, è la cultura, a renderci liberi: senza la scuola, senza scrittori, senza la lettura si resta fatalmente schiavi.