“Ginotti” … beh, un cognome non proprio eroico … diamo un’occhiata: fine Ottocento, scuola locale, una roba orientalista, niente di speciale.
Superficiale: lo sarà di certo l’impressione del pubblico colto di fronte alla sua scultura, chi ha familiarità di studi passione o lunga frequentazione con le vicende dell’arte è probabile non dedichi più che un’occhiata obliqua e svogliata alla “schiava”. È un prodotto mediocre, appena appena riscattato da una discreta esecuzione e dal suo essere un esempio quasi “da manuale” di cosa sia stato l’orientalismo. Minore ma pervasivo fenomeno culturale, arrivato anche qui a Torino.
Il percorso ottocentesco della Gam offre così tante emozioni che volentieri ci si scrolla di dosso quell’appiccicoso senso di disagio che un’opera non bella, con cui non si può stabilire alcun tipo di empatia, ti lascia sulla pelle. Meglio certo mettersi in fila tra le pecorelle di Pellizza, specchiarsi negli oli luccicanti di Hayez e lasciarsi portare a spasso per la Torino positivista di Bossoli.
Eppure tante volte nelle ultime settimane ho pensato alla Schiava di Ginotti.

Anzitutto è quello che dice di essere: la figura delineata nel marmo non ha la dignità di un nome, neppure di fantasia. È semplicemente la sua condizione, quella di essere proprietà; una stucchevole spolverata di decenza attribuisce a questa giovanissima donna il gesto perfettamente inutile di tirare le catene che le vincolano i polsi per liberarsi. L’unico effetto di questo sforzo è tendere la muscolatura, far avvicinare le braccia di modo che stringano tra di loro i seni prorompenti.
Riguardo alla sua origine si resta interdetti: il volto dovrebbe ricordare tratti africani, ma è come se si trattasse piuttosto di una vaga suggestione che non della vera trascrizione della bellezza di una ragazza nera. La stessa identità etnica utile all’artista per farcela riconoscere come schiava viene negata, attenuata, annacquata quando si tratta di descriverne le fattezze.

È un oggetto; un grazioso oggetto erotico. Su questo nessuno può nutrire alcun dubbio; è l’idea, resa plastica tangibile e pressoché eterna dal marmo, che una giovane donna nera, proprio perché giovane, donna e nera, possa e anzi debba essere un delizioso oggetto sessuale.
La mia impressione di fronte a questa scultura è sempre stata di fastidio, ma anche in qualche modo di vicinanza, per un fatto del tutto sciocco: è circa alta come me. Guardarla da vicino, occhi negli occhi, misurare il suo corpo e riconoscere la medesima dimensione a me ha sempre fatto grande tenerezza.
Torniamo al fastidio: quest’immagine non può, oggi, non essere profondamente disturbante. O forse può? Il piccolo corredo scientifico cui è affidata la spiegazione dell’opera sul sito della Gam non pare offrirci nessun appiglio per una lettura critica. Nulla che vada oltre un’alzata di spalle; si allargano le braccia, si sospira… è orientalista.

Beh, tutto qui? Davvero? Certo
è un dato di fatto, figurarsi se ce lo dimentichiamo; come potremmo? Sarebbe tedioso ripeterlo e ribadirlo per ogni opera, dall’antichità ad oggi. Non sia mai …
Eppure io non riesco a non pensare alla piccola Schiava in queste settimane; cosa sono i nostri musei, oggi. A cosa servono? Ci servono davvero? A chi servono?
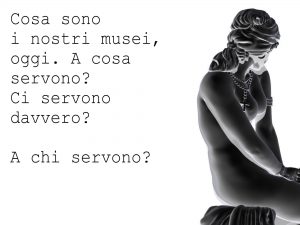
Vorrei chiederlo a quella ragazza raffigurata nel marmo; vorrei chiederlo a un’adoloscente nera del 2020 che visita la Gam con la propria classe. Vorrei chiederlo ai curatori.
Ho sempre pensato che fosse un’opera da destinare al deposito: la qualità è mediocre, il messaggio, ove mai ce ne sia stato uno degno, ampiamente cristallizzato nella propria epoca. Se c’è una cosa che gli studi storico artistici insegnano molto bene è che nessuna scelta è inevitabile: tutto è cultura, tutto è selezione, tutto è soggettivo. Perché dovrebbe restare lì? Per nessuna valida ragione: via, deposito! Un Medardo Rosso, un Gemito, un paesaggino qualunque in più sarebbe meglio.
Che statue, ma persino interi monumenti, vengano buttati giù, rifatti, modificati più o meno drasticamente, i dipinti messi, tolti, spostati, tagliati, coperti e ridipinti non è davvero qualcosa di tanto bizzarro.
Tutto ben prima che si confezionasse il concetto di “cancel culture”.
Mettere in deposito la Schiava davvero sarebbe davvero tanto pericoloso? Davvero dovrei disperarmi perché mi viene sottratto un tassello determinante della mia identità culturale? Io credo proprio di no; nessun uomo del Rinascimento si sarebbe scandalizzato di vedere cancellate splendide opere gotiche.
Però forse sarebbe troppo semplice.
Cos’è un museo? È un posto che rappresenta, anzi celebra, anzi consolida il privilegio, e quindi l’oppressione?
Sì, può esserlo di certo, non ce lo nascondiamo. Il Louvre di Napoleone afferma la superiorità militare della Francia sul resto dell’Europa e perpetua questo privilegio garantendo agli artisti francesi dell’Ottocento una formazione eccezionale. Il Museo Pio Clementino rende evidente come il papato sia l’istituzione che si è appropriata del ruolo di mediare ogni possibile rapporto con l’antichità, soprattutto romana, esercitando una sorta di monopolio culturale sull’eredità classica.
Ma non siamo più nel XIX secolo; allora cos’è il museo, oggi?
Mi viene in mente un’altra opera, una che nessun sano di mente confinerebbe in deposito, l’Olympia; mi viene in mente soprattutto perché nessuno l’ha citata nel dibattito più recente.

È come se la deliziosa glassa di cui viene ricoperta, ingiustamente, l’esperienza impressionista, avesse ottuso la violenza di questo dipinto.
Che, anzitutto, pare banale dirlo, non è affatto impressionista.
Victorine Meurent esibisce un corpo tutt’altro che bello; aspro, senza curve, quasi maschile. Guarda dritto senza imbarazzo ma senza compiacimento, con uno sguardo lucido e del tutto disincantato.
Se qualcuno ha mai creduto all’amore romantico gli occhi di Victorine / Olympia paiono fatti apposta per deluderlo. Anche lei un oggetto: gli uomini la usano, la omaggiano, ma poi si vergognano di lei e non vogliono vederla rappresentata al Salon. Peggio di lei, solo la sua domestica. Ve la ricordate? Porge a Olympia un bel mazzo di fiori colorati, l’unico soggetto felice di tutta la scena. Di solito la si commenta dicendo “beh guarda che bel contrasto ha creato Manet: il bianco abbacinante di Olympia, la pelle nera della domestica, l’esplosione di colore del mazzo di fiori”.

A me questa descrizione ha sempre fatto venire i brividi: davvero? Spendiamo parole sull’ipocrisia denunciata dal nudo di una prostituta che Manet eleva al rango delle Veneri rinascimentali e taciamo sulla figura della domestica? Come se la sua fosse una condizione del tutto naturale? A me pare evidente che si tratti di uno schiavismo “blando”, forse non sancito per legge ma attuato nella pratica, che tutto sommato non arriva a disturbare la sensibilità di un uomo intelligente ed empatico come Manet.
Dicevo: non penso affatto che l’Olympia vada messa in deposito. Ma quando la esponiamo con tanto orgoglio cosa stiamo comunicando?
Mi viene in mente un’ultima opera per chiudere questo terzetto: il Davide e Golia di Caravaggio.
La testa di Golia fa letteralmente orrore: un viso brutto, di un uomo consumato dalla vita, che per questo appare più vecchio della sua età, la smorfia dolente deformata dalla violenza della morte, gli occhi aperti e terribilmente vacui. Lo guarda con schifo e preoccupazione il suo stesso assassino, bello di una bellezza tenera e luminosa. Ed entrambi sono Caravaggio: lui che aveva assassinato un uomo per un motivo del tutto futile, lui che ha fatto i conti con ogni sfaccettatura del suo animo e che ci racconta cosa ha capito.

Ecco, io credo che le opere che non ci rappresentano più, che ci disturbano e ci danno la nausea, vadano esposte: purché siamo in grado di farlo come Caravaggio-Davide espone la testa di Caravaggio-Golia.
Siamo questo, siamo stati questo e in parte lo siamo ancora. La nostra cultura, quella che ha costruito i nostri cervelli, è fatta (anche) di cose orrende, oscene. Di violenza, sopraffazione, pregiudizio. Anche di grande bellezza e aspirazione a una dimensione più alta dello spirito: ma questa non cancella e non giustifica l’altra. Dobbiamo farci i conti, dobbiamo osservarla con la stessa preoccupata costernazione del Davide caravaggesco.
Finché terremo gli occhi fissi su quella figura deforme sapremo riconoscere la bellezza che possiamo salvare.
Il titolo di questo articolo, Pareti bianche, cita una frase pronunciata da Patti Astor sul razzismo nel mondo dell’arte: “the art world was white walls, white people and white wine”.
Mentre lo scrivevo Anish Kapoor aggiunge un interessantissimo tassello a queste riflessioni; credo che la sua lettera finirà nei libri di storia.
Ringrazio Marco che trova inspiegabilmente immagini efficaci nei miei testi, così anche i testi sembrano più sensati.

