Premessa di Adriana Chemello
Il primo appuntamento di questa nuova rubrica si apre sotto un buon auspicio, una coincidenza che possiamo interpretare come beneaugurante: è uscita proprio in questi giorni, nella collana degli “Oscar” Mondadori, la ristampa, tanto attesa e auspicata, del romanzo di Alba De Cespedes, Dalla parte di lei, da cui abbiamo preso spunto per la nostra titolazione.
E la figura che vi proponiamo in questo primo appuntamento è quella della scrittrice di origini venete, Paola Drigo, ingiustamente dimenticata e lasciata a lungo nell’oblio.
Vogliamo ridare voce a questa donna che nei suoi racconti ha saputo auscultare e narrare i sentimenti più reconditi della vita delle donne, in particolare le violenze domestiche nascoste e taciute, denunciando, senza enfasi ma con aderenza alla realtà delle cose, gli invisibili pregiudizi e le ataviche violazioni della dignità di cui sono tappezzate le vite delle donne. Il suo racconto Maria Zef ha avuto anche una trasposizione cinematografica ad opera del regista Vittorio Cottafavi e la pellicola, dopo un accurato restauro, è stata presentata al Festival di Venezia 2019.
Rossana Melis, dottore di ricerca in italianistica, studiosa rigorosa e attenta in particolare del secondo Ottocento italiano e della figura di Matilde Serao, ha collaborato a ridare voce alla scrittrice Paola Drigo con la recente pubblicazione del carteggio inedito con il critico d’arte Bernard Berenson: Come un fiore fatato. Lettere di Paola Drigo a Bernard Berenson, a cura di Rossana Melis, Padova, Il Poligrafo, 2016.
Una strada per Paola Drigo di Rossana Melis
Perché quella che è ormai considerata, dagli addetti ai lavori, come la scrittrice più importante e originale dei primi decenni del Novecento, non solo veneto, Paola Drigo, in realtà è una scrittrice sconosciuta?
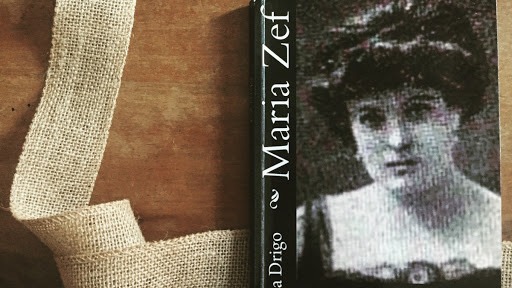
Perché la stessa cittadina dove è nata, Castelfranco Veneto, non le ha dedicato neanche una piazza, un viuzzo, insomma un luogo pubblico per celebrarla? Oppure perché non l’ha fatto la città dove è morta, Padova?
I motivi, oltre la smemoratezza che in genere colpisce le figure delle donne che pure hanno lasciato dietro di sé tracce importanti, ci sono. Vediamoli.
Paola Bianchetti (che firmerà sempre i suoi scritti con il cognome del marito) era nata appunto a Castelfranco Veneto nel 1876, in un periodo in cui l’educazione femminile era quasi sempre trascurata, o comunque avveniva sempre, nelle famiglie aristocratiche o borghesi colte, non certo in scuole pubbliche.
Ma Paola aveva una fortuna: un padre, Valerio Bianchetti, avvocato mazziniano, repubblicano e laico, che credeva nell’educazione pubblica anche per le ragazze; aveva per questo avviato agli studi ginnasiali la primogenita Paola, che fu quindi la prima ragazza a frequentare il Ginnasio-Liceo Canova, a Treviso.
Nel corso della quinta ginnasio il padre morì, la famiglia non si ritrovò più nell’agiatezza di prima. La madre, che aveva altri tre figli maschi più piccoli da far studiare, dopo qualche anno si trovò costretta a tenerla a casa.
Nel frattempo la famiglia si era trasferita a Padova, dove studieranno i fratelli di Paola. Lei è una ragazza bellissima. Nel 1898, a 22 anni, sposa l’ingegnere Giulio Drigo, ricco possidente padovano. Tra loro corrono quasi vent’anni. L’anno dopo nasce il figlio Paolo, e poi una bambina, che subito muore. I coniugi trascorrono parecchi mesi a Mussolente, in una bella villa ai piedi del Grappa, Ca’ Soderini.
Insomma: una storia dai tratti comuni a quelli di molte giovani signore degli inizi del Novecento.
Ma Paola ha qualcosa da dire, anche se è molto timida e insicura. O forse no, perché ha dentro di sé l’immagine di un padre amato, che l’ha educata alla verità, al coraggio. Scrive racconti, dallo stile sicuro, soprattutto angolati sempre da un occhio femminile, di chi dice quello che pensa e che vede.
Sono anche storie di donne infelici.
Gli anni Venti sono per lei molto pesanti. Il figlio è lontano, il marito, nel 1922, muore. Paola se ne sta molto spesso in solitudine a Mussolente, ma anche viaggia, e continua a scrivere. Ama i classici, si tiene al corrente della narrativa più recente, francese o inglese o tedesca. Un critico che l’ha seguita benevolmente dagli inizi, Pietro Pancrazi, la giudica ormai in declino.
Ma Paola ha in mente un racconto lungo, la protagonista è una povera montanara della Carnia, Mariutine, ne scrive parecchie pagine. Però lo interrompe, non si sente la forza di proseguire. Intanto i rapporti con il figlio, che abita e lavora a Roma, entusiasta del regime di quegli anni, non sono facili. Si mette allora a narrare in prima persona, in uno stile piano e conversevole, la sua vita degli ultimi mesi.
Ne esce un racconto, Fine d’anno in campagna, quasi una cronaca della crisi appena vissuta. Viene pubblicato, nella primavera del 1934, su «Pan», una rivista letteraria fiorentina molto seguita. Il racconto fa rumore, perché è scritto con tranquillo, minuto realismo e autoironia. Sia per il successo di Fine d’anno, poi pubblicato da Treves, che per gli incoraggiamenti che le vengono dal celebre critico d’arte Bernard Berenson, improvvisamente – e siamo ormai nell’autunno del 1935 – Paola Drigo riprende quel racconto interrotto, che ha come protagonista Mariutine. Ci lavora intensamente, ininterrottamente, stando anche male, e lo conclude nel febbraio del 1936.
Si chiamerà semplicemente Maria Zef. Il direttore della casa editrice Treves (che lavora in anonimato, perché, antico e fervido repubblicano, è contrario al regime) è entusiasta dell’opera. Il libro esce alla fine del 1936. E anche chi lo legge l’accoglie come un capolavoro. Nel corso dell’anno successivo se ne fanno ben quattro ristampe di qualche migliaio.
A leggerlo ora, ancora ci meravigliamo, e ci interroghiamo su come una signora (sulla cui vita esteriore mi sono così dilungata) abbia scritto, nel 1936, una storia dove esprime e domina con semplicità, insieme a descrizioni intense del mondo silenzioso della montagna, il dolore totale della condizione umana, vissuto attraverso l’esperienza di una ragazzina della Carnia.
Anche se credo che sia necessario leggerla tutta per capirne l’eccezionalità, ne trascrivo qualche brano. Anzitutto quello di apertura:
Erano due donne un carretto ed un cane.
Andavano lungo l’argine del fiume, dopo il tramonto, verso una grossa borgata di cui si vedeva appena brillar qualche lume sull’altra sponda.
Il carretto a due ruote, carico di mestoli, scodelle, càndole e candolini, e di altri oggetti in legno, era trascinato da una delle donne che, attaccata alle stanghe per mezzo d’una cinghia che le passava sotto le ascelle, tirava innanzi animosamente tra le buche e il fango della strada.
Veramente, benché alta e complessa con larghe spalle di montanara, ella era piuttosto una bambina che una donna, di tredici o quattordici anni appena, con un visotto tondo ed ingenuo, e due begli occhi azzurri dall’espressione infantile.
Così ci viene incontro, in uno scenario arioso di pianura, Maria Zef, Mariutine. L’altra donna, la madre Catine, ha già un’aria affranta. Nel carretto, quasi nascosta, sta la sorellina Rosute, dal ciuffetto di capelli rossi.
Siamo agli inizi del Novecento (ma quasi nulla ce lo dice, lo scenario è senza tempo: sono le donne, che d’estate scendono dalla loro montagna quasi disabitata per vendere nella ricca pianura i prodotti che hanno messo insieme nel lungo inverno).
In questo andare, la madre Catine si sente peggio, e muore. Arriva allora dalla casa di montagna, di là del Passo della Mauria, barbe Zef, lo zio delle bambine, cognato di Catine, il cui marito è morto in America molti anni prima. E si porta via nella casa poverissima e isolata della Carnia le sorelle.
Barbe Zef non parla quasi mai. Ma una sera, mezzo ubriaco, in giorni in cui anche Rosute è all’ospedale per curare una gamba malata, violenta Mariute. Questo diventa subito per l’uomo abitudine. Per lei:
“Questo” le aveva foggiato improvvisamente un volto duro, spento, l’aveva invecchiata in pochi giorni di molti anni. Ella, che non aveva mai assomigliato a sua madre, ora, malgrado i capelli biondi e la pelle chiara, nell’espressione senza luce le assomigliava.
Poi anche Mariute si sente male. Aiutata dalle parole di una guaritrice di montagna, capisce che lo zio le ha trasmesso la sifilide, e che della stessa malattia è morta la madre. Che la madre, aiutata da barbe Zef, ha abortito più volte. Che la sorellina, che non ha mai visto il padre, morto da molti anni, ha gli stessi capelli rossi dello zio, è sua figlia. Quando Rosute sta per tornare dall’ospedale, e barbe Zef ha già deciso a mandare a servizio in città Mariute, lei capisce che la sorellina avrebbe avuto la stessa sorte, e lei non l’avrebbe potuta difendere. La sera prima di partire fa ubriacare lo zio, gli va vicino, sente pietà per lui, che ha avuto quasi niente da una vita durissima e miserabile.
Ma l’idea di Rosute e dell’incesto la scuote:
La cucina era così piccola che le bastò senza muoversi, tendere il braccio, la mano, per afferrare la scure che era buttata sopra un mucchio di legna nell’angolo del focolare.
Ella l’afferrò e l’alzò quanto più alto poté.
La lama lampeggiò nell’ombra.
Mirò al collo, e vibrò il colpo.
Non un grido: solo un fiotto di sangue.
Così finisce il racconto.
Pur nella sua inequivocabile chiarezza narrativa, non troviamo nell’opera le parole sifilide o stupro, aborto, incesto, atti che pure dominavano allora più di adesso gli interni delle case di campagna e le città. Né le avevano nominate mai, sempre eludendole, i critici che allora, alla sua uscita, l’avevano accolta con molto favore. Solo uno, il triestino Silvio Benco, aveva detto a chiare lettere che Rosute era figlia di Barbe Zef.
La storia tragica, e così comune, di Mariutine avrebbe poi incontrato muri invalicabili a livello ufficiale già nel corso del 1937, quando Maria Zef concorse al Premio Viareggio. Se, fino al giorno prima della premiazione l’opera aveva avuto la stragrande maggioranza dei voti, l’ultimo giorno le decisioni cambiarono repentinamente, e il premio venne dato a Guelfo Civinini.
Paola Drigo stava già molto male, per una malattia che aveva trascurato. Morì pochi mesi dopo, nel gennaio del ’38, in una clinica di Padova. Disperse le sue carte, la guerra incombente e poi decisiva per l’ oblio.
Malgrado la casa Garzanti (erede di Treves) continuasse a pubblicare il libro, Maria Zef non è mai stata riconosciuta per il suo valore (basta guardare la voce che nel 1968 le è stata dedicata dal Dizionario Biografico degli Italiani). Voci accademiche si sono però alzate negli ultimi decenni per ricordare Maria Zef, di cui ora non è proprio necessario, direi, sottolineare l’attualità. In più, una piccola fiammata di notorietà si è riverberata su di lei quando, nel 1981, l’opera è stata portata in televisione dal regista Vittorio Cottafavi, che a Roma lavorava alla realizzazione del lavoro dal 1980. Forse anche per quello, o più probabilmente per altre sotterranee vie venete, che ne hanno tenuto aperto un carsico accesso, nel 1980 una strada è stata dedicata a Roma a Paola Drigo. C’erano infatti allora nella Commissione di Toponomastica romana due donne, una notoriamente femminista e una con antiche parentele venete, che vollero ricordarla.

