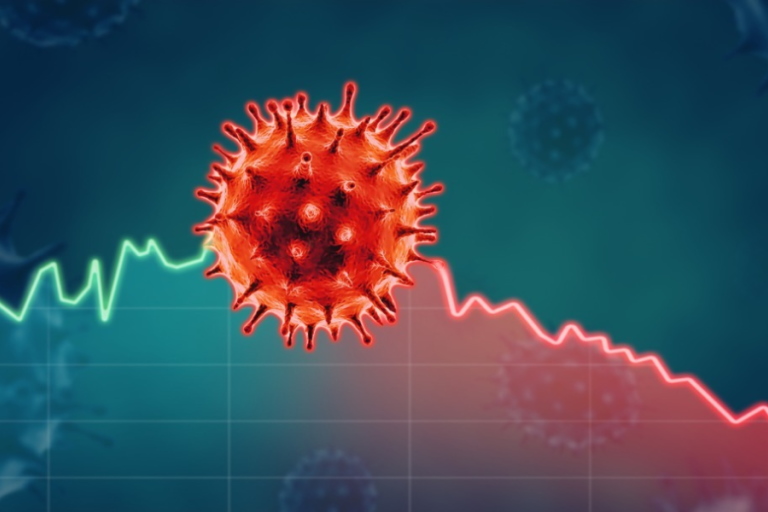La cautela con cui l’informazione internazionale ha dato notizia e commenta la dichiarata intenzione di Donald Trump di mettere in discussione la sua eventuale (ma indicata come probabile dai sondaggi) sconfitta nelle elezioni del prossimo 3 novembre, è forse ancor più allarmante delle stesse inaudite parole del Presidente. Né si tratta dell’alterazione di un momento, tanto meno di umorismo, ancorchè bellicoso. L’aperto rifiuto si presenta come lo sbocco conseguente di un atteggiamento eversivo dell’ordine costituzionale, di cui Trump ha fatto mostra fin dall’assunzione del suo mandato e perfino in precedenza nel corso della sua prima campagna elettorale. Questa in corso, comunque, ne risulta già seriamente turbata.
E’ una minaccia senza precedenti, tanto da preoccupare stampa, radio, TV, l’intero sistema dei media nel complesso, fino al punto da indurli a preferire di apparire distratti o intimiditi piuttosto che amplificare lo scenario apocalittico spalancato dalla possibilità che Trump ponga davvero in atto il proposito espresso. Potrebbe provocare immediatamente scontri sanguinosi negli Stati Uniti, crisi irrimediabili nelle zone più roventi del mondo, drammatiche tensioni e sconvolgimenti economici globali. Parliamo non solo della prima potenza economica e militare del mondo, per quanto non più del tutto egemone; bensì anche del modello di riferimento delle democrazie capitaliste di tutto il nostro pianeta. Parlare di irresponsabilità suona riduttivo.
In un improvviso sussulto d’inconsueta ragionevolezza (dovuto anch’esso all’approssimarsi dell’esame elettorale), Donald Trump aveva detto in precedenza di aver sempre saputo che il coronavirus era maligno, ma di averlo deliberatamente sottovalutato per non creare allarmismi. “Non si poteva fare di più”, ha subito aggiunto per assolversi allo stesso tempo disdicendosi. Di sicuro, non solo possibile e auspicabile, bensì dovuto (alla responsabilità di un capo di stato se non al semplice senso comune) fare meno, meno autoritarismo demagogico e strampalato, affinchè fosse ridotta l’enormità dei lutti prodotti al paese dall’avventurismo del Presidente, dal suo spregiudicato gioco d’azzardo sulla salute pubblica.
L’irresistibile inclinazione all’opportunismo, alla disinvolta speculazione, marca del resto l’intera esistenza di Donald Trump, dai non sempre trasparenti affari immobiliari all’ingresso (anche questo tutt’altro che limpido) alla Casa Bianca. Il negazionismo è l’altra faccia della sua cifra culturale, di cui s’è fatto campione fin dal momento in cui (giugno 2017) ha denunciato l’Accordo di Parigi per la riduzione del surriscaldamento globale, sottoscritto dal predecessore, Barak Obama. Le procedure previste rendono effettivo lo svincolo dal patto soltanto alla fine di quest’anno; ma già dal 2018 gli Stati Uniti hanno intensificato tra il 2 e il 3% l’emissione di diossido di carbonio. Inquinamento certo in cambio di pochi, poveri ed effimeri posti di lavoro.
Oltre 6 milioni e mezzo di contagi hanno causato negli Stati Uniti più di 200mila morti in meno di 6 mesi (sommano a un milione nel mondo intero). Senza risparmiare -a parere di autorevoli specialisti tanto democratici quanto repubblicani- danni drammatici all’economia materiale così come a quella finanziaria (chiusura d’imprese, disoccupazione, crolli nelle borse già in precedenza contaminate da conclamate bolle speculative). I fumi degli incendi che bruciano decine di migliaia di ettari di boschi, campi e abitati dalla California all’Oregon sorvolano il paese fino ad annebbiare con la bassa pressione l’aria di New York. Nel sud i nubifragi devastano intere zone dell’Alabama. Nella speranza di rianimare investimenti, occupazione e consumi, la Federal Reserve blocca a zero il tasso d’interesse fino al 2023.
* * * * *
Non è forse un caso che dopo gli USA, il paese occidentale più dolorosamente colpito sia il Brasile (oltre 133mila deceduti), il cui presidente –Jair Bolsonaro– è quello che più vistosamente si è spinto a imitare gli atteggiamenti di Trump, gonfiandone inoltre gli aspetti maggiormente grotteschi. Né va meglio l’economia: a tal punto che il Presidente, circondato dalle critiche e in picchiata nei sondaggi, in guerra aperta con i governatori degli stati di Rio e San Paolo, ex alleati, adesso accusa d’inefficienza il suo ministro dell’Economia, Paulo Guedes, accreditato neoliberista e fiduciario del grande capitale nazionale nel governo. Ma che in effetti non è riuscito finora a portare a termine nessuna delle riforme promesse. Mentre avanzano i processi penali contro i figli di Bolsonaro, malgrado i suoi interventi illegali per proteggerli.
Segue il Messico (e a breve distanza Bolivia, Colombia, Perù, Equador, Argentina), dove il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pur animato dalle migliori e instancabilmente declamate intenzioni (ogni mattina, dalla sua paternalista pedagogia radiofonica), soccombe alla propria retorica nazionalista, incancrenita dalle metastasi accumulate nei trascorsi decenni di governi conservatori (PRI), corruzione e narcotraffico. Dalla gloria (del trionfo elettorale) alla vanagloria (dei programmi irrealizzati) il passo è stato breve. Per la seconda economia dell’America Latina ne consegue una forte e pericolosa instabilità. La strage compiuta dal Covid si riflette su produzione, occupazione e consumi. E non frenano le violenze della grande criminalità organizzata contro istituzioni e singoli cittadini.
Si tratta, è pur vero, di grandissimi paesi, con enormi popolazioni, in parti notevoli concentrate in aree urbane. Pertantoproporzionalmente al numero di abitanti e alla loro distribuzione sul territorio le vittime del Covid appaiono meno smisurate. Questo non è tuttavia l’unico parametro da tenere in conto, per farci un’idea ponderata dei danni umani e materiali inferti alle diverse realtà socioeconomiche dalla pandemia, che non ha risparmiato nessun angolo del pianeta terra. E delle rispettive possibilità di meglio difendersene. Brasile e Messico, malgrado le pesanti contraddizioni interne, sono paesi non pienamente sviluppati, ma tutt’altro che poveri. Costituiscono le maggiori realtà industriali dell’America Latina e sono nelle prime 15 economie del mondo.
Sebbene d’incomparabile portata rispetto a quelle degli Stati Uniti, altre significative consultazioni si approssimano nel subcontinente, da un capo all’altro agitato da tensioni e crisi, tutte accentuate dalla pandemia del Covid: il 18 ottobre, le elezioni generali in Bolivia decideranno la istituzionalizzazione del colpo di stato del novembre scorso o più probabilmente -se i pronostici dicono il vero-, ne ribadiranno la condanna popolare, portando alla Presidenza Luis Arce, l’ex ministro dell’economia del defenestrato Evo Morales, candidato del suo partito, il Movimientoal Socialismo (MAS); una settimana dopo, il 25, saranno i cileni ad andare alle urne per decidere se e con quali modalità darsi una nuova Costituzione, sostitutiva di quella imposta dalla dittatura di Pinochet. In dicembre, voterà anche il Venezuela, per rinnovare il Parlamento, estrema possibilità per Nicolas Maduro di ricondurre il paese stremato sulla via di un’accettabile convivenza.
Senza essere mai venuta meno, la polarizzazione politica è stata infiammata dall’approfondirsi delle disuguaglianze che impediscono alle società latinoamericane di uscire dalla perenne emergenza. Con effetti univoci anche se impari. In Argentina hanno riunito l’opposizione al neoliberismo, portando al governo un centrosinistra di marca peronista. Il tramonto di Sebastian Piñera, che tanto poco conosceva le condizioni del paese da finire costretto a cambiare la Costituzione per fronteggiare la protesta senza precedenti contro il rincaro dei trasporti pubblici, ha portato alla ribalta in Cile un candidato neo-comunista. E’ la prima volta. Si chiama Daniel Jadue e sebbene appaia divisivo nella coalizione di centro-sinistra, pisa fuerte, secondo i sondaggi. Il Covid sembra aver spostato la percezione dei bisogni verso temi d’interesse collettivo, accentuandone l’urgenza.