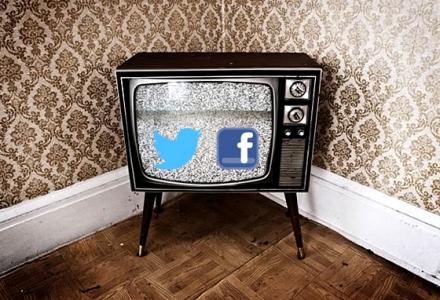Che cosa s’intende, al tempo dei social network, per “discorso pubblico”? Chi ne fa parte? A partire dal XVIII secolo il discorso pubblico ha coinciso con l’opinione pubblica, quella che legge i giornali e i libri, che frequenta convegni e luoghi d’arte. E’ il momento di chiedersi: il variegato e caotico popolo della rete che spesso si lascia trascinare da suggestioni e luoghi comuni spalancando la porta a notizie false e inverosimili o a ingenui manicheismi, fa parte dell’opinione pubblica? Alcuni intenzionalmente, altri inconsapevolmente, diffondono verità di comodo, denunciano complotti, negano l’evidenza dei fatti storici, delle leggi della fisica e della biologia. In buona misura questa moltitudine frastagliata rappresenta, “una massa resa insicura e guidata dall’angoscia, che facilmente si fa monopolizzare dalle forze nazionaliste e razziste” (Byung-Chul-Han). Costoro concorrono alla composizione del discorso pubblico al pari degli “ottimati” oppure sono soltanto la versione moderna della plebe e del sottoproletariato?
Prima di esprimere un giudizio sull’opinione di massa, vale la pena di sottolineare che con la nascita dei social network, appena quindici anni fa, per la prima volta nella storia del genere umano, un terzo dei suoi componenti ha “preso la parola” nella sfera del dibattito pubblico. La comunicazione da molti-a- molti (4,3 miliardi di persone) è una rivoluzione più che epocale: termini come opinione pubblica, masse, popolo della rete, folle, gente si rivelano sempre più inadeguati per descrivere questo rassemblement atomizzato e magmatico che assume un identità precisa solo all’interno di un circuito commerciale sotto la veste di consumatori, utenti, audience, target, followers, influencer.
Nei confronti di questi “disturbatori” del discorso pubblico si tende ad assumere un atteggiamento indignato e snobistico che sfiora il disprezzo (senza tener conto che cittadini, a differenza dei signori di cui parlava il grande Totò, si diventa e non si nasce) appellandosi, di volta in volta, a un presunto senso di responsabilità di chi su questa ignoranza diffusa accumula profitti colossali (gli Over The Top) oppure al legislatore perché limiti la libertà d’espressione.
Questa indignazione, non accompagnata da realistiche strategie di contrasto, sfocia inevitabilmente nella rassegnazione alimentando una visione apocalittica della rete.
Ma è davvero impensabile un programma politico che consideri internet un bene pubblico, un componente del welfare, come la Tv pubblica europea? Internet è prevalentemente un colossale mercato che vende utenti alle agenzie di pubblicità. È impossibile ridimensionarlo, ad esempio frazionandolo, per fare spazio a una rete ispirata a un’ economia del disinteresse che competa con la sedicente economia del gratis?
Ma fino a quando ciò che si intende comunemente per pubblico – lo Stato e le sue istituzioni, gli organismi internazionali, in special modo quelli europei, il ricchissimo mondo dell’open source, le organizzazioni non profit come Wikipedia, progetto Gutenberg, Free Software Foundation, i servizi pubblici europei (EBU), ecc. – non mostrerà una consistenza e una coesione d’intenti tale da rendersi competitivo con i “padroni della rete” in nome dell’interesse generale, la locuzione internet bene comune sarà solo uno slogan. Invece, la politica, a tutti i livelli, mostra un encefalogramma piatto a questo riguardo, alimentando così lo spirito di rassegnazione e una sorta di luddismo digitale nei confronti di un rivolgimento sociale rilevante almeno quanto la prima rivoluzione industriale.
I grandi partiti di massa del XX secolo sono stati, tra l’altro, delle straordinarie palestre di pedagogia che hanno dato a decine di milioni di contadini e operai la consapevolezza della loro condizione sociale e dei loro diritti ascoltandoli e meritando di farsi ascoltare. Non si potrebbe fare altrettanto con l’opinione di massa che è appena approdata nella sfera del dibattito pubblico? Che almeno se ne parli.