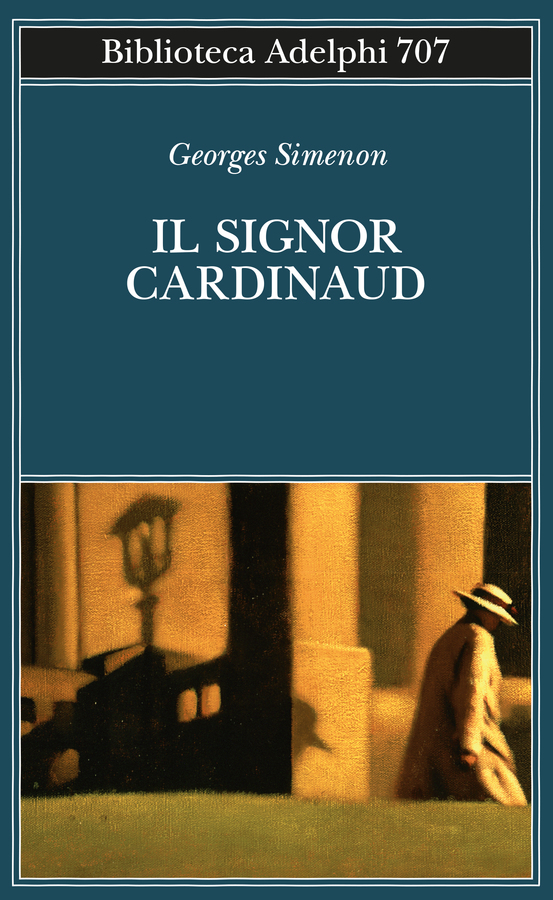Uscito per la prima volta nel 1942 e ristampato da Adelphi lo scorso gennaio, appare con la riapertura delle librerie Il signor Cardinaud di Georges Simenon, un romanzo emozionante, che irrompe a proposito in questa inaspettata stagione di travaglio in cui i valori da tempo smarriti tornano improvvisamente a rifiorire, si rimescolano le carte, e la riflessione riprende il suo posto nel bilancio delle vite. E’ un romanzo di appena 136 pagine che trascina il lettore alla conclusione senza concedere tregua e che il prodigioso scrittore belga sembra comporre non alla macchina da scrivere ma alla tavolozza, per macchie di colore, personaggi sbozzati dalla luce, scorci dai contorni sfumati per quanto esattissimi nel sentimento; insomma il suo stile più autenticamente ‘impressionista’, una narrazione che dalla suggestione letteraria trasfigura a tratti nel capolavoro visivo, e perfino musicale.
Al centro un personaggio che non dimenticheremo facilmente; si chiama Hubert Cardinaud, per tutti il signor Cardinaud, perché salito ormai a una posizione sociale più che rispettabile, benché figlio di una povera famiglia di cestai. Ha sempre vissuto nel suo paese in Vandea, Le Sables-d’Olonne, lì ha frequentato le scuole, è cresciuto, s’è distinto dai suoi compagni di classe, è diventato un elemento di punta della ditta di assicurazioni del signor Mandine, che lo stima al punto da lasciargli intravvedere, di tanto in tanto, la prospettiva di associarlo in affari. Impiegato modello, efficiente, preciso, impeccabile anche nel vestire e nel portamento, eretto e pacato, non ha mai un gesto o una parola fuori posto. Hubert è un uomo probo, ama sua moglie Marthe fin da adolescente, è circondato da una famiglia perfetta con due figli, il maschietto Jean e la femminuccia Denise, e abita in Avenue de la Gare in una bella casa nuova, “di mattoni rosa, la porta è di quercia verniciata: è stato lui a volerla così, con un pomo di ottone e due vetri tinti leggermente di giallo dietro una decorazione di ferro battuto”. La domenica, dopo la messa a Notre-Dame-de-Bon-Port, tenendo il figlio per mano si concede una passeggiata di svago: “Lentamente, con compostezza, facevano il solito giro lungo il Ramblai. Il mare era azzurro come il mantello della Vergine, i camerieri si affaccendavano attorno ai tavolini e, passando, si respirava un aroma di birra e di vermuth”. Nella pasticceria in cui entra a comprare i dolci è accolto con rispettosa familiarità: “I soliti signor Cardinaud?” I soliti certo, un’allegra confezione che affida al figlio, da portare con il dito infilato nel nastrino rosso a fiocchetto. Perché cambiare se la vita è così bella, così radiosa nel volgere di un ordine immutabile e rassicurante?
Ma quella domenica, rientrando a casa per il pranzo che l’attende, l’arrosto di carne con le patate, il nido è vuoto: Marthe, la moglie adorata non è lì ad aspettarli, è fuggita via, scomparsa, lasciando figli e marito senza neppure voltarsi indietro. Che orribile sciagura! Il signor Cardinaud ne è annientato, non vuole accettarlo, si rifiuta di credere che la sua esistenza sia improvvisamente distrutta, che il tetto della casa sia crollato, irreparabilmente. In lui non c’è alcuna arroganza, soltanto infinita umiltà e la caparbia resistenza degli spiriti semplici. Se sua moglie è fuggita con un altro uomo, come ogni apparenza suggerisce, bisognerà ri-trovarla (aggiungo il trattino di proposito), cioè trovarla di nuovo, ovunque lei si nasconda, qualsiasi sia la sua caduta. E se tutto il paese riderà di lui, o lo compatirà, pazienza, la ricerca di lei è un dovere verso sé stesso, i suoi figli, ma anche verso la donna che non ha mai smesso di amare.
Chiama in casa una governante, la signorina Trichet, che si prenda cura dei piccoli durante il giorno, la sera ci penserà egli stesso. E non cambia vita né atteggiamento, non domanda compassione, ogni giorno si reca al lavoro come sempre, sopportando il falso imbarazzo di chi incontra; anche del suo capo, al quale è costretto a chiedere un prestito perché Marthe, fuggendo, ha portato via tutti i soldi che tenevano in casa; una somma cospicua che il signor Mandine prima gli nega e poi gli accorda quando viene a sapere la vera ragione della sua disgrazia, ostentando una pietà di maniera che camuffa il dileggio, perché un cornuto è ridicolo. “Era per tutti pacifico che la moglie non sarebbe tornata mai più”. Ma a Hubert non importa, non è a sé che pensa, al proprio orgoglio ferito, alla dignità calpestata; soltanto una volta, quando si reca a trovare i vecchi genitori ai quali non nasconde nulla, sopraffatto da un momento di intrattenibile sconforto, appoggia la testa al muro come forse faceva da bambino e scoppia in silenziosi singhiozzi. La madre gli risparmia le parole che ha sulla lingua: “Te l’avevo detto io…”, si trattiene dall’infliggergli l’ultima ferita, lo invita a sedersi a tavola: “E’ rimasto un po’ di spezzatino… E se prima mangiassi un boccone?”
Da mattina a sera, svolgendo il suo lavoro come un automa, l’uomo non fa che ragionare tra sé, ruminare quel bolo avvelenato; come quando cadendo a terra si rompe un vaso prezioso e si va alla ricerca disperata anche della minima scheggia per rimetterlo insieme com’era. Hubert intuisce che deve indagare nei quartieri malfamati della cittadina, da cui si è sempre tenuto alla larga, se vuole diradare la caligine che lo opprime. Si reca al Petit Bar Vert, un locale malfamato sulla banchina del porto, indicato da una lettera anonima in cui viene tirato in ballo il figlio di Titine, la proprietaria, una vecchia ruffiana che gli sghignazza in faccia. Tuttavia qualcosa riesce ad apprendere; affiora una traccia su cui mettersi, dal momento che Mimile Chitard, il mascalzone, ex galeotto nelle colonie condannato a dieci anni di carcere duro e vent’anni di residenza coatta, sembra sia stato rivisto in paese. “Del resto, Cardinaud aveva la sensazione che Marthe non era partita, che non aveva lasciato la città. Non avrebbe saputo dire perché. Doveva essere da qualche parte, se avesse saputo cercare…”
Poiché non può affidarsi ad altri che a sé stesso, approfittando dell’estate alle porte chiede al principale di poter anticipare le ferie di due settimane; e si trasforma in un segugio, ma senza mai perdere la sua naturale gentilezza, il rispetto di sé e degli altri. Si comporta come se intendesse caricarsi sulle spalle l’intero pianeta, un Atlante con la schiena piegata dal peso ma ben lungi da spezzarsi. Si incolla un mondo che non gli piace, impastato di cattiveria, di crudeltà, di crimini, di sangue, di una umanità senza riscatto; la feccia in cui sua moglie è forse affondata. Nel suo calvario si rivolge spesso a lei: “Lo vedi Marthe che cosa hai combinato?” Non prova alcun rancore nei suoi confronti, soltanto una pietà da eroe arcaico, da uomo onesto e responsabile, che non ama il disordine, l’ hybris degli antichi greci, origine di ogni ingiustizia, sopruso, violenza, che conducono alla catastrofe; quando invece la società potrebbe essere il paradiso terrestre, se retta nel rispetto tra gli esseri umani. La sua è una discesa nei bassifondi, necessaria e riparatoria, avendo davanti agli occhi la sola stella polare della propria fede incrollabile. Non dubita di riuscire nell’impresa, incurante di tutti gli altri che lo reputano ormai un uomo finito, senza risorse, incapace di rialzare il capo:
“Sarebbe andato a riprendersi Marthe, l’avrebbe riportata a casa, perché il suo posto era lì, accanto a lui e ai bambini; ci sarebbe andato perché non credeva nel male o, per meglio dire, perché confidava nel trionfo del bene sul male, nella supremazia dell’ordine sul disordine, perché, in definitiva, confidava nell’inevitabile, fatale armonia.”
Vorrei raccontarvi l’intero romanzo per quanto mi urge la precisione imprescindibile del racconto, simile a un dipinto che si impone nella sua interezza; vorrei proporlo nella sua ineffabile integrità, come integro è il protagonista della storia. Ma non posso farlo, sarebbe uno sgarbo verso il lettore chiamato ad assistere, nella beata solitudine della pagina, al dissolversi del groviglio, in un giorno di pioggia a dirotto, in un paese della costa non troppo lontano da casa. Hubert infilato in un vestito zuppo d’acqua, davanti a un albergo che gli è troppo caro, Le Chên Vert, a Mareuil.
Dio, come può essere luminoso un romanzo! Leggerlo d’un fiato per smettere di discettare della vita credendo di conoscerla e non sapendone nulla, trincerati dietro logori luoghi comuni, dietro insipide certezze. I libri di Simenon sono bagni di pura salute perché non vogliono affidarci null’altro che lo sguardo sull’esistenza com’è, uno specchio immenso in cui ognuno può distinguere all’improvviso il proprio sembiante. Ecco perché Fellini amava tanto il suo amico Georges, ancora prima di conoscerlo, quando ancora giovane dichiarava sereno ai giornalisti: “Non voglio dimostrare niente, voglio solo mostrare”.