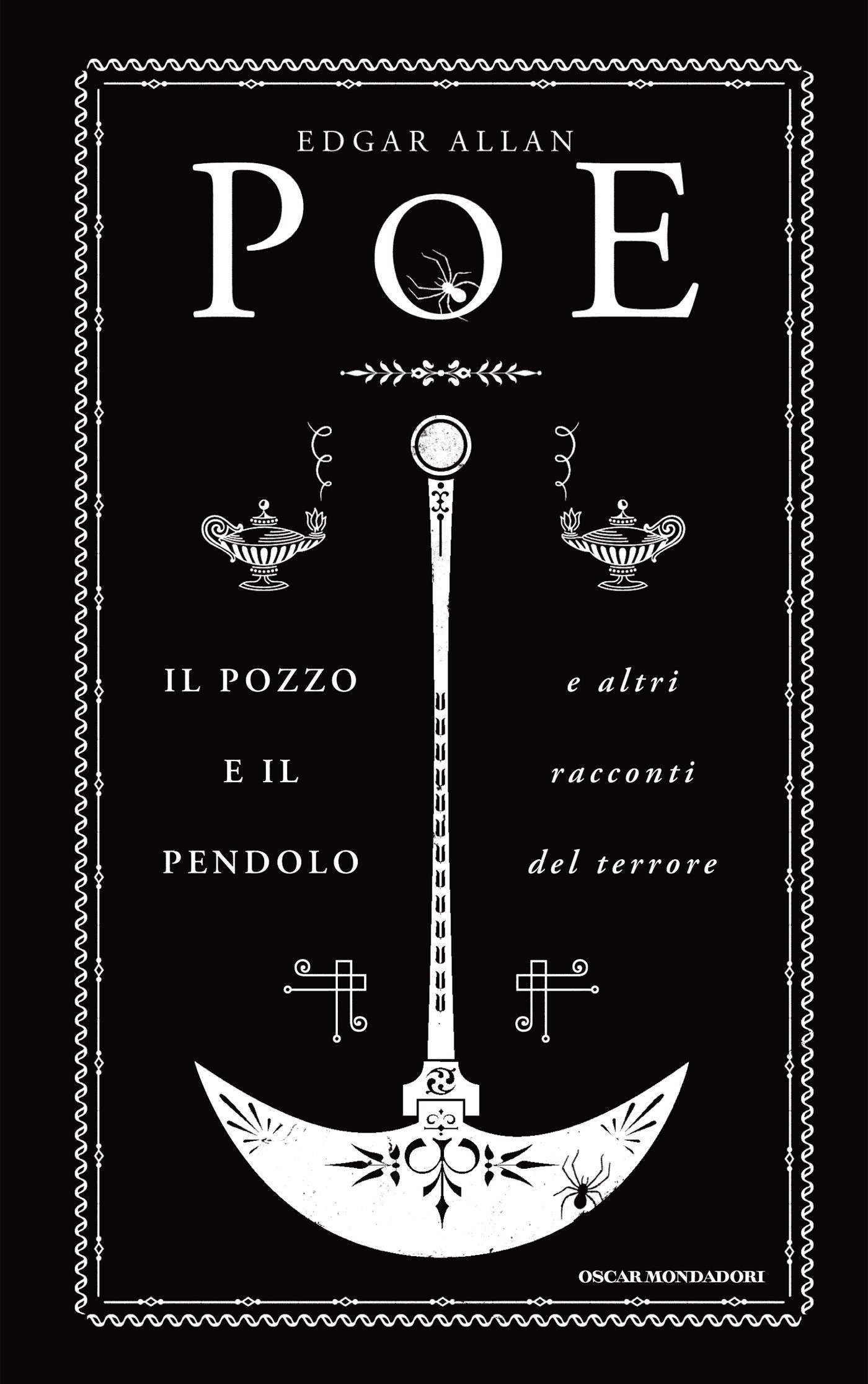Amplificazione sensoriale e difformità
Ciò che non riusciamo a dimenticare è di essere svenuti e aver ripreso conoscenza, in più fasi, nelle segrete dell’Inquisizione di Toledo insieme all’uomo condannato a morte per eresia. Di aver fissato lo sguardo, come ipnotizzati, sulle labbra bianche e sottili, senza suono, dei giudici e sulle sette candele disposte sul tavolo; di essere tornati, più tardi, a una forma puramente biologica e indistinta di vita (che è impossibile non accostare a quella descritta dalla Voce ondivaga del manganelliano “Dall’Inferno”, metafisico romanzo-trattato di umbratile terribilità sulla (im)percezione o alterata percezione organica), seguita dal pensiero articolato e dalla coscienza fisica complessa e definita; di aver provato la stretta soffocante di una tenebra inumana e poggiato le mani sul pavimento di pietra, coperto da un sottile strato di fango, di quel luogo misterioso; di aver camminato incespicando e scivolando e muovendo le braccia nel vuoto fino a raggiungere le pareti di metallo liscio.
Di aver vissuto insieme al condannato tutta la via crucis di orrori descritta da Poe in “Il pozzo e il pendolo” (1845) con una prosa di inarrivabile raziocinio. Proprio l’esattezza e la luce geometrica della forma fanno assumere alla natura ossessiva, onirica e perversa della materia narrativa un’evidenza inquietante.
Come in altri racconti di Poe (ma vengono in mente anche “Il ragazzo rapito” e “L’isola delle voci” di Stevenson), la disgregazione di tutto ciò che concerne il senso comune avviene attraverso l’esasperazione rituale e la graduale intensificazione della percezione sensoriale. L’identificazione di dimensioni, forme e consistenze dipende dalle capacità tattili acuite dalla solitudine, dal buio, dal silenzio e dal continuo stato di allarme. L’odore della lama di acciaio del pendolo si infila nelle narici dell’uomo, il sibilo sempre più forte delle oscillazioni gli ferisce l’udito e lo atterrisce, lo soffoca il ferro rovente delle pareti che muovendosi lo spingono verso il pozzo posto al centro della stanza.
“Il pozzo e il pendolo” arriva all’essenza stessa della persecuzione e, più di un secolo dopo, giungerà a questo risultato anche la scrittrice americana Shirley Jackson con il romanzo “Abbiamo sempre vissuto nel castello” (Adelphi). L’isolamento aristocratico, le fantasie, la levità allucinata e appena sarcastica di Mary Katherine e Constance, due sorelle che vivono insieme a uno zio invalido nella grande casa paterna, assumono agli occhi degli abitanti del vicino villaggio forme distorte, mostruose, appaiono sintomi di un Male non più tollerabile. Avviene con allarmante frequenza che i membri di comunità chiuse nella propria angustia interiore, cerchino di rintracciare all’esterno fantomatici “mostri” o capri espiatori [mentre la Bestia caproniana, si sa, “evanescente./La preda/mansueta e atroce/(vivida!) che nelle ore/del profitto (nelle ore/della perdita) appare/(s’inselva) nella nostra voce.”], trovandoli spesso in individui che si discostano semplicemente dal senso comune e da quelli che vengono considerati i normali commerci umani. E’ facile così che la sindrome paranoica collettiva inneschi un crescendo di inaudita violenza, trasformando i singoli in massa informe (manzoniana), o meglio in una bestiale folla di carnefici e distruttori (questo avviene anche in un altro racconto della Jackson “La lotteria”, sempre edito da Adelphi). Alle sopravvissute non resterà che spazzare i cocci delle stoviglie e degli oggetti di casa, sigillare le stanze violate e ricomporre quel che rimane dell’armonia perduta per mezzo dei “piccoli miracoli della follia”, mentre i rampicanti crescono sui resti combusti del castello. La frase finale di Mary Katherine: “Siamo così felici!” è un lampo struggente che accomuna il suo destino a quello della Winnie beckettiana (“E’ passata un’altra bella giornata, dopotutto!”).
Emarginazione e difformità sono anche i temi del film di Gavin Hood “X-Men le origini: Wolverine”. “Wolverine” non è sostenuto dal fascinoso, visionario apparato mitologico dell’indimenticabile “Il Cavaliere Oscuro”, non ne possiede la sontuosità dark, né l’inquietudine shakespeariana, né la tensione verso la follia (auto)distruttiva. Tuttavia c’è qualcosa che lo rende più vicino a noi e al nostro tempo: le creature dotate di particolari facoltà non sono luminosi o tenebrosi supereroi, bensì esseri marginali afflitti da caratteristiche fisiche o abilità bizzarre ai limiti dell’anomalia, individui che si nascondono e soffrono fino a sfiorare forme di derelizione. Ci troviamo a sprofondare in feritoie sbiadite del mondo reale, in quartieri fatiscenti, fra malinconici maghi da Luna Park, mostruosi boxeur bulimici, timidi studenti dallo sguardo laser, ragazze dalla pelle di diamante, uomini-lupo belli e immortali giunti fino a noi dopo aver attraversato tutte le guerre americane, da quella di secessione all’apocalisse del Vietnam.