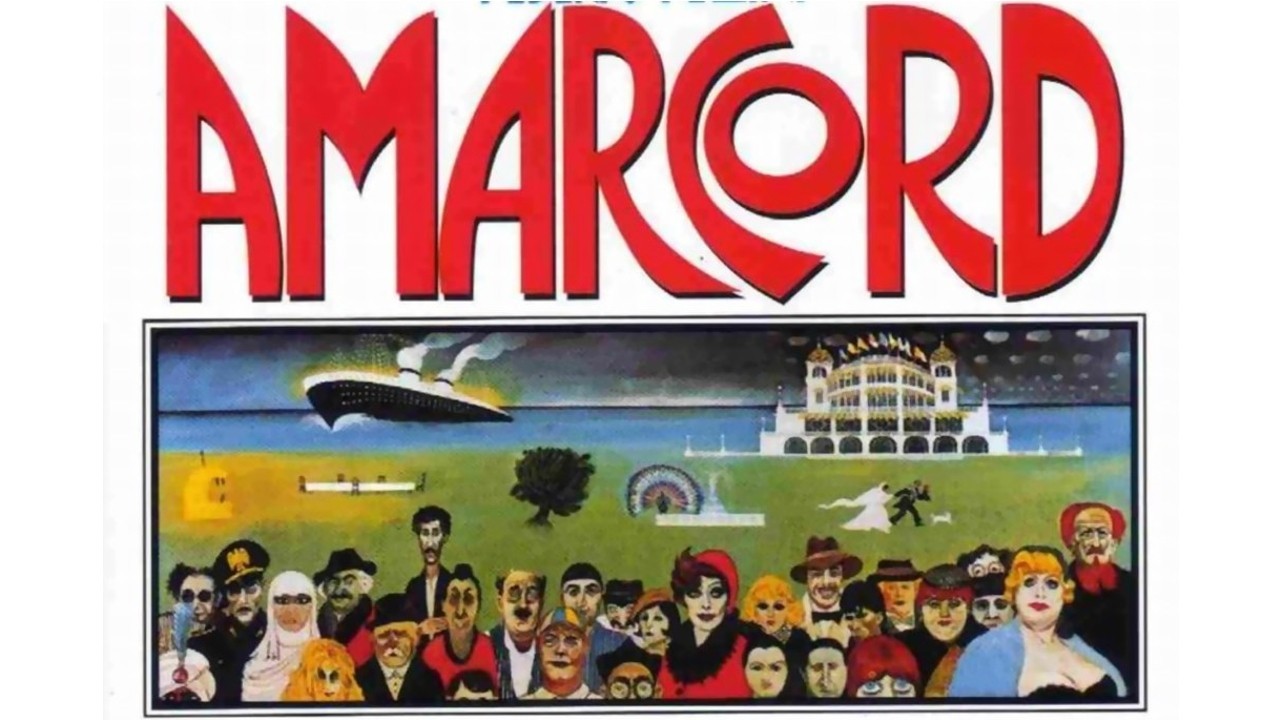Nel film Amarcord di Federico Fellini, il ‘narratore’ è un distinto avvocato sui sessanta, cappotto con collo di pelliccia, sciarpa, cappello, e bicicletta alla mano. Di notte passeggia per le strade della città e disquisisce direttamente con lo spettatore, guardando dritto all’obiettivo della macchina da presa. E’ una guida, un Virgilio, dal tono affabile, dal piglio erudito, accolto a ogni affermazione da sonore pernacchie. Per le quali però non si scompone, tira dritto per la sua strada, chiosando anzi gli sberleffi, quelle uscite maleducate, senza mutare una sola virgola del suo stile manierato, retorico, declamatorio:
“Anche questo fa parte del carattere beffardo di tale popolazione, la quale ha nelle vene sangue romano e celtico e un carattere esuberante, generoso, leale e tenace. Dal divino poeta Dante, a Pascoli e D’Annunzio numerosi sono gli alti ingegni che hanno cantato questa terra… e i suoi innumerevoli figli che hanno onorato con segni d’eternità l’arte, la scienza, la religione, la politica….” (pernacchia ritmata a commento).
L’avvocato dice cose sensate, ma anche risapute, è la fiera delle banalità, dei luoghi comuni, di verità convenzionali di cui si bea, si compiace apertamente. Nella stagione estiva indossando una sahariana alla moda (siamo in epoca coloniale) a maniche corte e il foulard al collo, frequenta la terrazza del Grand Hotel e quando adocchia una bella straniera sola, la corteggia a distanza, da un tavolino all’altro. Accenna un educato brindisi di benvenuto e attacca discorso ricorrendo, per strategia collaudata, ai grandi poeti del passato. Domanda all’ospite civettuola se conosce Leopardi. L’altra risponde in un italiano incerto che non conosce nessuno perché è appena arrivata; e questa ignoranza non lo scoraggia ma lo esalta, lieto dell’opportunità di sfoggiare la sua cultura da eterno ginnasiale; solleva il bicchiere a una certa altezza e spiega: “Dante è qui… Leopardi, qui, anzi qui!”. Con la mano libera indicando una posizione appena più in basso, per sottolineare la poca distanza che intercorre tra i due eccelsi letterati. Del tutto incurante che la sua interlocutrice non capisca nulla di quanto sta dicendo. Il modello era stato un amico comune, in compagnia di tanti altri di cui non c’è scarsità.
Ripenso al personaggio di Amarcord perché la figura dell’avvocato, in provincia, viene volentieri accostata al professionista eloquente e pedante, tutta esteriorità; è una maschera, alla pari del farmacista anarcoide, del medico somaro, del professore cripto poeta, dell’aristocratico babbeo, del politico maneggione. Caricature, di cui Fellini era maestro, schizzando con pochi tratti caratteri imperituri.
Ma a Rimini ci sono anche avvocati amabili, per nulla noiosi, che riversano sulla propria città un amore inesauribile e la gratificano di un’attenzione devota, immutabile nel tempo; nonostante il marchio a fuoco che il Duce le affibbiò: “Scarto della Romagna e rifiuto delle Marche”. Un ibrido poco onorevole. All’offesa risponde ora per le rime, ma non senza l’immancabile ironia, Giuliano Bonizzato, il penalista riminese vocato alle lettere, che dopo “Le Saraghine e l’immortalità dell’anima”, e “Succede prima a Rimini”, ci regala un nuovo volumetto di cronache malatestiane, croccante come una piadina ben cotta e profumato come il buon sangiovese: “Tu quoque Ariminum” (Edizione La stamperia, 118 pp. 8 euro; e tutto il guadagno in beneficenza).
L’autore rimbecca Mussolini: “Ritengo che questa avversione nascesse dal fatto che, tra tutti i romagnoli, solo i fascisti riminesi gli davano del pataca quando gonfiava il toracione nella battaglia del grano, o si pavoneggiava dal balcone di Palazzo Venezia con le mani a pentolino sui fianchi…” Il termine pataca, in questo caso spregiativo, possiede nel linguaggio quotidiano una interminabile serie di sfumature, persino in contrasto tra loro; ma la più elegiaca la riporta Bonizzato citando l’ineguagliato lessicografo Gianni Quondammatteo, il quale identifica il pataca in “chi sul treno, se trova un posto a sedere accanto a una bella donna, legge il giornale e guarda fuori dal finestrino…” Immagine folgorante e persino toccante, crepuscolare, che non esaurisce però la pluralità del termine. Il giornalista politico Bruno Sacchini, per esempio, accosta il pataca a “una figura di livello assoluto caratterizzato da gioia di vivere, follia ludica, provocazione onirica, sogni ad occhi aperti e guasconeria creativa”. Talché il riminese più pataca di tutti, commenta l’avv. Bonizzato, sarebbe addirittura Federico Fellini. Il quale, se pur adorato dall’autore, non aveva un buon feeling con i suoi concittadini: “La gente che incrociava sembrava quasi evitarlo”. Questione di “rusticità”, ci viene spiegato, “tanti grandi rustici, rimasti qui, tra il centro e la marina, con uno spropositato complesso di odio-amore” verso chi un giorno aveva preso il treno, come il giovane Federico, inseguendo i suoi sogni. Ma correggendo il tiro aggiunge: “E a pensarci bene era rustico anche Fellini che, a Rimini, preferiva arrivare di notte, per non incontrare nessuno, dopo aver svegliato con i sassolini alla finestra l’amico Titta”. Soprannome di Luigi Benzi, altro avvocato, altro penalista, chissà se anche lui spernacchiato come sarebbe piaciuto al discolo Fellini.
Così Bonizzato scrive un capitolo intitolato “Come diventare fellineschi”. Non nel significato del “fregnacciaro” romano, traduzione ludica dello stesso Fellini che si divertiva a storpiare l’ anglosassone “fellinesque”, entrato nei lemmi dei dizionari americani. E neppure per definire le tante imitazioni che la produzione cinematografica ci offre del presunto universo felliniano. Bensì come una inestricabile appartenenza alla città, al mondo, ai personaggi che il grande artista riminese ha saputo mettere insieme in Amarcord. Al punto da esclamare carduccianamente: Riminesi, fratelli, popol mio! Fellineschi si vince!”
E allora, per chi è nato sull’Adriatico, si crea una bolla sentimentale; viene in mente la bruma marina che si infittisce allo scendere della sera, le figure che diventano ombre d’Averno, e il suono rauco, prolungato del nautofono proteso a orientare l’entrata in porto dei pescatori. Un suono oggi sparito, caduto in disuso, superato nella sua funzione dai navigatori satellitari dall’era elettronica, che guidano la rotta e azionano il timone automatico. Dice Bonizzato: “Hanno assassinato anche la sirena che faceva sentire la sua voce asmatica e inconfondibile nelle giornate di nebbia (…) Altri ricordi perduti, collegati a quella sirena. Certe sere, al calduccio sotto le coperte…”
Fra i miti che spariscono c’è anche Giulio Cesare, che fermò le sue legioni sul Rubicone prima di decidersi a lanciare il dado fatale. Neanche lui è simpatico ai riminesi. Forse perché Mussolini aveva di propria volontà spostato il guado più a nord, a Savignano, verso la sua Forlì. Quando al Duce degli Italiani fu fatto notare da Don Domenico Garattoni, cappellano delle Camicie Nere, che Rimini era città romanissima con l’Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio, l’anfiteatro, il dittatore non tardò a inviare alla cittadinanza una copia in bronzo del condottiero da collocare nella piazza a lui intitolata. Ma poi ci fu la guerra e una damnatio memoriae che travolse anche il monumento. Nel ’45 la statua fu trasferita al capannone dell’acquedotto e interrata insieme ai tubi. Nel ’51 venne inumata da mani ignote nel greto del Marecchia tra i residuati bellici. Ritrovata per puro caso nel ’53 dagli Artiglieri della via Flaminia, fu sistemata amorevolmente in caserma. Finché dopo numerose peripezie nel 1996 l’effige del condottiero trovò pace in Piazza Tre Martiri, ma seminascosta dietro un’edicola a causa “del basamento originale, nel quale nonostante la laboriosa cancellatura, si scorgono ancora sui fianchi le parole «Ex dono Benito Mussolini»”.
L’avvocato Bonizzato che ama la bicicletta come l’avvocato di Amarcord, con ben altra dinamicità sfreccia sulla moderna pista ciclabile del lungomare, sole o pioggia che sia, e ci regala una nuova serenata a Rimini, da irriducibile amante, riuscendo con il suo stile limpido, sorridente, civile a far innamorare anche noi.