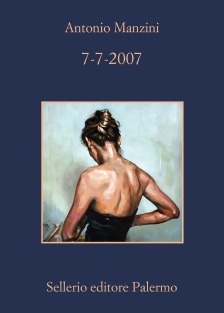Rocco Schiavone è un vice questore della Polizia di Stato; così si presenta per evitare che gli altri continuino a chiamarlo commissario, irritandolo. E’ un romano trasteverino, di origini umili, e i suoi amici più intimi, appartenenti alla stessa estrazione sociale, sopravvivono nel malaffare; come spesso accade nelle classi meno protette, dove dipende dal caso se diventi sbirro o malandrino. Lo stesso Rocco Schiavone, che pure ha scelto l’ordine e la legge, non si è però del tutto affrancato dal marchio di origine, e se riesce a condurre un’esistenza agiata, con un superattico al Gianicolo, è perché ha saputo arrotondare le entrate sequestrando a proprio uso privato, “ma senza fa’ piagne mai nessuno”, refurtiva scottante che gli amici lo aiutano a far sparire rapidamente nel mercato sommerso. La moglie Marina non lo sa e non lo sospetta; lei proviene da un altro mondo, è bellissima, appartiene al ceto medio-alto della Capitale, ha studiato arte, lavora nell’ambito del restauro, frequenta critici famosi, intellettuali, collezionisti, e naturalmente possiede un’etica personale intransigente. Così quando viene a scoprire che il marito non è esattamente quel ragazzo un po’ greve ma sostanzialmente buono onesto e coraggioso che ha sposato, il cielo le crolla addosso. Fa le valigie e torna a casa dai suoi, lasciando Rocco, innamoratissimo e incapace di fare a meno di lei, nella più nera disperazione. E per giunta nel bel mezzo di un caso che gli è piombato addosso come un macigno. In una cava di marmo sulla Tiburtina, un ragazzo di vent’anni è stato trovato sfracellato, dopo un salto di trenta metri, su un lastrone bianco che sembra uno specchio ustorio sotto il sole già spietato di fine giugno. Accanto c’è un laghetto, una pozza d’acqua celeste “che sembrava rubata al Mar dei Caraibi”, usata per bagnare e raffreddare le catene e il marmo da tagliare: perché non hanno occultato il cadavere lì dentro? Il patologo, Spartaco Pichi, spiega che qualcuno ha scaricato la vittima dall’alto dopo averla massacrata di botte e poi finita con una chiodata al cervelletto: “Un colpo solo, con una lama, uno stiletto. Zac! Secco”. Sembrerebbe una punizione atroce, una resa di conti. Ma per quale motivo?
Giovanni Ferri è un ragazzo di buona famiglia, serio, studioso, figlio di un giornalista di cronaca nera di cui sogna di ricalcare le orme una volta laureato. In che guaio s’è cacciato per meritare una fine così orribile? Nel malessere in cui si dibatte per la mancanza di Marina, una morsa allo stomaco che quasi gli impedisce di respirare, il vice questore indaga su piste esilissime; qualche minima traccia emerge dal pub in stile inglese, dalle parti di via Alessandria, frequentato quasi esclusivamente da giovanissimi; forse Giovanni insieme a Matteo Livolsi, suo amico inseparabile, e alla fidanzatina Isabella, di ottima famiglia pariolina, s’era infilato in un giro di piccolo spaccio; ma rifornendosi in che modo? Da chi? Il padre giornalista, che in seguito allo shock per la morte del figlio, è ricoverato in rianimazione per un blocco alle coronarie, aveva lasciato sulla propria scrivania un foglietto di appunti riferiti a un traffico di droga ai massimi livelli. Certo non a portata di mano dei due pischelli. Eppure non passano due giorni che l’amico Matteo viene trovato steso per strada, accanto al suo motorino, ammazzato in pieno quartiere Trieste con lo stesso buco alla base del cranio, come un capretto. Rocco Schiavone stenta a mettere insieme le schegge di un enigma che promette di seminare altre morti. Ma lo strazio maggiore resta la lontananza di Marina, a cui non sa proprio rassegnarsi; lei gli ha chiesto di stare alla larga, di non farsi più vivo, e non risponde al telefonino, sempre staccato. Inoltre una notte, appostandosi sotto casa, Rocco la vede scendere da una lussuosa BMW guidata da un uomo elegante, che Marina saluta affettuosamente prima di entrare nel portone. Si segna la targa e chiede al suo agente più anziano e fidato di risalire al proprietario, ha paura che lei lo stia veramente lasciando per un altro, cancellando tutto l’amore che li ha uniti. Non immagina quanto anche la moglie stia male, tentata a sua volta di tornare a casa, tra le sue braccia, nonostante la delusione bruciante che non riesce a superare. Una mattina, dopo la solita notte insonne, nel primo spiraglio di tempo lui prende coraggio a va a trovarla sul luogo di lavoro, alla Basilica di San Clemente in via di San Giovanni in Laterano. Nei sotterranei Marina, tutta sola, è assorbita nel restauro di un affresco mirabile: Il Miracolo di San Clemente. Dove si racconta che il prefetto Sisinnio, essendosi accorto che la moglie Teodora si era messa a adorare Cristo, era andato a riprendersela con i suoi soldati. Ma Dio non lo permise: accecò Sisinnio e i militi i quali, al posto della donna, portarono via una colonna di marmo. La storia contiene forse una verità che riguarda loro due da vicino, coincidenze su cui riflettere, e scatena una commozione che prelude a un ravvedimento, a un riavvicinamento. Schiavone riprende fiducia e si getta con ritrovato vigore nel caso da risolvere, esponendosi personalmente anche oltre il dovuto.
Noi ne seguiamo le gesta man mano che il vice questore racconta la sua vicenda: perché l’intero romanzo è un flash back, una lunga dolorosa confessione che il poliziotto romano, ora trasferito ad Aosta (in una sorta di punizione mascherata da esilio dorato), affida alle mani del suo superiore per dissolvere alcuni sospetti che gravano su di lui. E anche sui suoi amici trasteverini che, come gli inseparabili quattro moschettieri (nessuno di loro ha letto il libro, ma uno ha visto il film) gli si sono stretti intorno per proteggerlo in quel momento di fragilità.
La trama non è riferibile più di tanto, sarà il piatto forte del lettore appassionato di sciarade da dipanare pagina dopo pagina, irretito dall’abilità dello scrittore. L’estate, si sa, è la stagione più favorevole al consumo di storie da brivido che aiutano ad attenuare la canicola. Nelle classifiche dei libri più venduti c’è una inflazione di romanzi polizieschi e quasi soltanto italiani: da Camilleri a De Giovanni, da Manzini a Lucarelli, da Carofiglio a Carrisi (molti di loro nella scuderia di Sellerio, ormai specializzata nel settore). Il genere tira, perché è di facile lettura, perché racconta insieme ai personaggi di casa, anche le nostre città, i luoghi noti, l’ambiente della provincia così familiare a qualsiasi italiano; sono caratteri, usi, abitudini, tic, vizi e virtù di cui siamo perfettamente al corrente. E, generalmente, ci regalano anche un appagamento poco frequente nella realtà, la gioia di vedere scoperto e condannato il colpevole, o quantomeno tolto di mezzo. Una specie di inarrivabile utopia per il nostro Paese in cui più nessuno paga per i reati che commette e i delinquenti vengono rimessi in libertà il giorno dopo la cattura, con tante scuse per le celle affollate e poco ospitali. Insomma i libri gialli ci accolgono in un mondo ideale in cui ci piacerebbe soggiornare perché ogni sentimento è survoltato, le esperienze tendono all’estremo, l’adrenalina insaporisce gli incontri e gli scontri. E poi ci riesce spontaneo proiettarci nel vice questore Schiavone, quarantenne sovrappeso, che fuma troppo, che c’ha il fiatone, dice parolacce, spara battute, ma è capace di correre rischi per tenere in piedi questa società traballante. Ci piace perché mangia gli stessi cibi che amiamo, grassi e appetitosi, la pasta alla gricia, i supplì unti, i caffè a ripetizione, e non rinuncia a fumarsi appena può un cannone di erba buona.
E’ un trasgressivo de’ noantri, contornato da amici balordi ma di buon cuore, e con accanto una moglie bella e raffinata che alla fine gli perdona tutto per amore. Abbiamo l’illusione di specchiarci in Rocco Schiavone, come in Salvo Montalbano, e altri loro colleghi angeli sporchi della legge, persuasi che incarnino proprio dei caratteri veri. E sapete perché? Perché non lo sono affatto, sono solo delle controfigure. Completamente falsi, generici, scontati – ogni loro gesto, ogni loro battuta di dialogo lo è -; sono stereotipi senza vita, luoghi comuni tutti uguali. Protagonisti, comprimari e generici sono dei pupazzi vuoti, intercambiabili, azionati ai fili con maggiore o minore perizia dal burattinaio di turno (e Manzini ha decisamente una buona mano, agile, veloce; in qualche passaggio ho persino pianto!). Sono le favole rassicuranti per adulti pigri e di scarse letture che cercano un intrattenimento senza sforzi. Sono le stesse storie che poi finiscono sul piccolo schermo, in imbarazzanti recite da oratorio che un orecchio appena avvertito riconosce come stonate, fasulle. Ma fanno audience, hanno un enorme successo, perché quei manichini vuoti, riconoscibilissimi, ci fanno da specchio e riflettono fedelmente ciò che stiamo diventando.