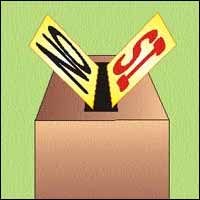Il referendum del 17 aprile è alle porte e forse è il caso di cominciare a chiarirci le idee. Innanzitutto su cosa siamo chiamati a votare: non tutti i media lo spiegano in maniera corretta e comprensibile. In realtà siamo chiamati a scegliere se abrogare la norma che permette di svolgere le attività di coltivazione degli idrocarburi, relative a concessioni già rilasciate in zone di mare, per la vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale (art.6 c. 17 del Codice dell’ambiente). Con parole meno tecniche ci viene chiesto se, quando scadranno le attuali concessioni, vogliamo che sia fermato lo sfruttamento dei giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se contengono ancora gas naturale o petrolio da estrarre.
Il quesito riguarda solo le trivellazioni già in atto entro le 12 miglia dalla costa, (poco più di 22 km), non quelle in mare a una distanza superiore o quelle sulla terraferma. Il referendum coinvolge 21 giacimenti di petrolio e metano, equamente distribuiti fra mare Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia. Di questi, tre di Eni e Edison potrebbero anche essere maggiormente sfruttati: Guendalina e Gospo nell’Adriatico, e Vega davanti a Ragusa.
Qual è la reale posta in gioco? La risposta non è semplice in un contesto mediatico che sembra voler mettere in secondo piano questo appuntamento democratico.
Ricordiamo che l’esito di questo referendum, come per tutti i referendum abrogativi, sarà valido solo se vota la maggioranza più uno degli aventi diritto. Per agevolare la partecipazione sarebbe stato auspicabile accorpare il voto con quello delle prossime elezioni amministrative e desta qualche perplessità la motivazione ufficiale fornita dal governo, cioè “difficoltà tecniche non superabili” come ha dichiarato il ministro dell’Interno Alfano in Parlamento.
Se questo accorpamento non c’è stato, se il tentativo è quello di creare disinteresse nell’opinione pubblica, se un’informazione corretta finora ha faticato a passare, per capire i motivi di tutto ciò, bisogna individuarne le cause. Provo a farlo.
Fra queste in primo luogo metterei il conflitto di competenze fra Stato e Regioni emerso nell’iter che ha portato alla consultazione del 17 aprile.
Il quesito referendario è solo uno dei sei che erano stati proposti da dieci Consigli regionali contro il decreto legge “Sblocca Italia”, che per raggiungere un maggiore sfruttamento dei giacimenti nazionali al fine di ridurre l’import di metano e petrolio, trasferiva una parte del potere decisionale dalle Regioni allo Stato. Da qui la richiesta da parte di Abruzzo (che poi si è ritirato dai promotori), Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto, di sottoporre la normativa a referendum.
Ma contemporaneamente il Governo, per evitare i referendum, è intervenuto con tre emendamenti alla legge di stabilità 2016, stabilendo il divieto di perforare entro le 12 miglia dalla costa e fermando le trivellazioni in corso non autorizzate definitivamente. L’intervento del governo quindi, ha provocato la decadenza di tutti i quesiti referendari ma non è riuscito ad evitare quello relativo alla durata delle trivellazioni già autorizzate.
Per questo motivo il presidente del consiglio tende a boicottare il referendum, invitando i cittadini a non votare, per evitare di raggiungere il quorum minimo (che renderebbe valido il risultato), temendo un successo del si, cioè delle regioni, che metterebbero un punto prestigioso a loro favore in questo braccio di ferro con lo Stato.
Ma al di là del conflitto di interessi, il boicottaggio del referendum rappresenta un grave “vulnus” di uno strumento di democrazia diretta, di cui in passato si è anche abusato, specie quando l’esito è stato mortificato nei suoi effetti, ma che va comunque difeso. Il rischio è che aumenti la disaffezione dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese, a maggior ragione in una fase storica in cui tendiamo a una crescente estraneità verso le istituzioni, conseguente alla convinzione che la nostra opinione sia sostanzialmente irrilevante e che il nostro voto, anche quello referendario, serva a poco.
Nonostante la tecnicità del quesito abbia poco appeal mediatico, l’auspicio è che nei giorni che ci separano dal referendum si apra un dibattito pubblico serio e approfondito, che consenta ai cittadini di scegliere consapevolmente come partecipare.
Non sarà facile perché a differenza della maggior parte dei precedenti referendum abrogativi, i promotori non sono i cittadini ma alcuni consigli regionali, che in quanto pubbliche amministrazioni non possono utilizzare mezzi istituzionali per la campagna referendaria.
Sarà quindi ancora più importante evitare banalizzazioni da una parte e dall’altra, perché votare “si” non vuol dire cancellare l’energia fossile dal nostro Paese, così come votare “no” (o non andare a votare), non equivale a difendere le aziende petrolifere da eventuali chiusure, né a evitare la perdita di posti di lavoro.
L’invito è di prepararsi al referendum con responsabilità, perché è uno strumento di esercizio della nostra cittadinanza: per questo abbiamo bisogno di poter godere in modo completo e trasparente del diritto all’informazione, lontano da pressioni lobbistiche e derive ideologiche.
Questo referendum, al di là del tema specifico, può essere l’occasione per fare alcune più ampie riflessioni sul futuro energetico del nostro Paese.
Dalla Strategia energetica nazionale, il documento politico programmatico del 2013, sappiamo che le risorse potenziali totali di idrocarburi in tutti i giacimenti italiani, marittimi e terrestri, ammontano a 700 milioni di tonnellate di petrolio, ma solo 126 sono riserve certe, mentre i restanti sono considerati come “probabili o possibili”. Poiché l’attuale quota di produzione annua è pari a 12 tonnellate, ciò equivale a un periodo di copertura certa di poco più di 10 anni. Considerando che questa previsione si riferisce a tutti i giacimenti nazionali ma che solo 21 sono quelli oggetto di referendum, le cui concessioni potranno essere rinnovate per 5 o 10 anni, si capisce come abbia una incidenza molto ristretta l’esito referendario.
La nostra dipendenza dall’estero per i prodotti energetici è pesante, ma l’attuale prezzo degli idrocarburi è molto basso e quindi favorevole per un Paese importatore come l’Italia. C’è da rilevare però che il basso livello dei prezzi sta mettendo in difficoltà i produttori: dove i margini di guadagno si riducono, è facile tagliare sulla sicurezza. Non a caso il referendum è stato richiesto dalle regioni direttamente coinvolte nella esplorazione per la ricerca di petrolio e gas naturale, che ritengono i possibili danni ambientali superiori alle entrate derivanti dalla estrazione di idrocarburi. A loro giudizio, una vittoria del “si” allontanerebbe i rischi di incidenti rilevanti nei mari italiani, specie nell’ Adriatico, un mare “chiuso”, il cui ecosistema potrebbe subire effetti devastanti in termini di inquinamento.
Infine, ultimo ma non ultimo, prolungare a oltranza lo sfruttamento di alcuni giacimenti di idrocarburi offshore può apparire miope rispetto a una questione più ampia: siamo certi che sia ancora l’energia fossile la strada da percorrere per la sostenibilità energetica? L’accordo sul clima raggiunto a Parigi recentemente prevede la riconversione verso fonti di energia a basso contenuto di carbonio e il miglioramento dell’efficienza, come la via maestra per contrastare i cambiamenti climatici.
Ci troviamo dunque di fronte a una schizofrenia della nostra politica, che non riesce a sintonizzare le strategie nazionali con gli impegni assunti in ambito internazionale? Anche un referendum può essere l’occasione per chiederci verso quale futuro energetico ci stiamo incamminando.