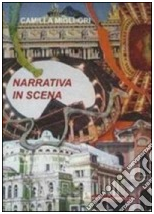Grande scuola il ‘teatro immagine’, anche nel singolo perimetro delle esperienze e delle acquisizioni italiane. Le quali, sia per chi scrive, sia per Camilla Migliori (regista e autrice di “Narrativa di scena” edito di recente da Nemapress-pag 145 E.16,00), costituiscono frequentazioni e ‘seminari della gioventù’ che si spera abbiano dati frutti contigui in territori complementari della pratica teatrale e della scrittura critica che ad essa si rapporta. Conoscenze – imprescindibili- dei condivisi anni sessanta e settanta, attestate sui maieutici nomi di Mario Ricci, Remondi e Caporossi, Lucia Vasilicò. Giorgio Marini, Maria Grazia Cipriani (Teatro del Carretto) – ma quanti altri ne dimentichiamo: dai Magazzini Criminali di Tiezzi e Lombardi ai laboratori della Piramide di Perlini ed Aglioti…- non avrebbero,storicamente, avuto compimento senza le doverose trasferte spoletine alla scoperta (per noi abbacinanti, epifaniche) del teatro secondo Bob Wilson, Pina Bausch, Virgilio Sieni. Tutte ‘opere’ in cui l’uso della della ‘parola’ non era soppiantato ma si rendeva ancella episodica, frammentaria, onomatopeica di universi emozionali universalmente delegati all’ipnosi soggettiva (ed al rito collettivo) di un gesto, una prossemica, un’ossessione o dettaglio iconografico ‘esplicito’ ed ‘ambivalente’ al suo solo trasmutarsi in ‘canone scenico’
Fu solo con l’inizio degli anni ottanta – per comodità di una datazione fatta di propaggini, anticipazioni, marce indietro, appendici-che il teatro di sperimentazione e ricerca, convenzionalmente avviato a quel riflusso ‘privatistico’, post disillusione di palingenesi politica, rivalutante il ‘disagio’ e l’ ‘ecolalia’ della parola (che nel cinema coincide con l’avvento derisorio di Nanni Moretti ed “Ecce bombo”, peraltro preceduto dai ben più drastici e poco ilari “Pugni in tasca” di Marco Bellocchio); quel teatro dell’inavverata palingenesi-dicevo- accettò di confrontare se stesso e la propria lunga ombra socio-antropologica (proiettata su di un pubblico ‘avvezzo’, zoccolo duro delle maratone di Sant’ Arcangelo di Romagna e Ostia Antica) con l’antica lezione del teatro di parola. Pur’esso –senza lo spartiacque, la frattura dell’immagine e dell’immaginazione provvisoriamente al potere (dell’utopia), probabilmente ancora stagnante sulla tardiva retorica del teatro oratoriale, finto-naturalistico, scimmiottante una ‘stagione della regia’ che nasceva e si completava nella lezione (senza grandi eredi) dei pochi Strehler, Missiroli, Squarzina, Pandolfi e del ‘giovane’ Ronconi (allora acclamata genialità in fieri di “lunatici”, “Candelaio”, “Orlando Furioso”). Andò diversamente (fu un bene, fu un male?) e Camilla Migliori se ne fa testimone attiva, perseverante, di lunga memoria.
Sin da quando, nel 1984, con un personale ricordo legato alla mia frequentazione (romana) del Teatro In Trastevere ed a quello dell’Orologio iniziò ad occuparsi di rilevanti (mai enfatiche, mai pretenziose) trasposizioni di ardue e basilari opere letterarie ove il riappropriarsi della facoltà dialettica e dialogica della parola porta a maturazione un già ricco bagaglio di acquisizioni gestuali ed iconografiche, di cui la stessa copertina di “Narrativa di scena” (‘azzardato’ collage della stessa autrice) reca un implicito, sotterraneo omaggio alla lezione (a me pare) del caro e imprescindbile Lele Luzzati. Sono quattro gli adattamenti o rivisitazioni drammaturgiche incastonate nel libro con intento cronologico al solo fine di “sottolineare il cambiamento, nel corso del tempo, della mentalità umana e del suo diverso modo di rapportarsi non solo con la cangiante reatà circostante”, ma anche con “diverse, evolute, rivalutate dimensioni” attinenti lo scandaglio dei sogni, dell’inconscio e fantasie oniriche, rivelabili o meno: in ogni caso traslate in allegorie o metafore dell’ ‘indizio espositivo’ – elaborato nell’atto stesso del suo farsi teatro e work in progress.
E quindi, in “Vita dell’arcitruffatrice Coraggio” (di esplicita derivazione brechtiana), si fa eminente la priorità barocca del ‘dire e sproloquire’ a supporto di licenze ed invettive antibelliche; mentre in “Candido” (‘voltairiano’ sino al midollo) trionfa ed è benefattrice (rimandando ad intolleranze e oscurantismi d’ogni tempo e latitudine) la razionalità illuminista, ‘bestia nera’ del fideismo consolatorio.
Seguono le dostoevskiane “Notti bianche” in edizione di struggente ‘reverie’ romantico- visionaria (con qualche eco da “l’idiota”); ed un Herman Hesse ‘minore’ (quindi superiore ai romanzi di moda iniziatica per cui fu guru ‘generazionale’) che, a partire dalle pagine di diario edite (da Adelphi) con il titolo de “La cura”,’ pantografa’ una ennesima- ma ben schiva – malattia del vivere (da modelli quali Svevo, Joyce, Silvio D’Arzo), coagulata nell’intorpidito (auto) tormento di “Soggiorno termale di uno scrittore ischiatico”- liddove il ‘malessere’, il ‘disagio di esserci’ nonostante tutto e tutti non è atteggiamento o snobismo distacco ‘da intellettuale’ introverso ed ipocondriaco. Ma concreta premonizione della miriade di flagelli che attraverseranno il ‘secolo breve’ e trovando agibilità di intollerante fanatismo sin dai cupi albori di questo millennio che stagna, prolifica, rilancia – senza consistenti, rinnovati antidoti di efficacia ‘globalizzabile’. Nella perseverante jungla delle piccole patrie, tra foschi rigurgiti di populismo e fascismo ‘un tanto al quintale’. Di criminogena esportazione.